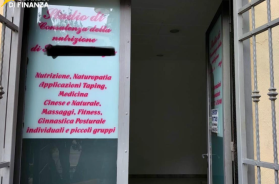Gianvito Mastroleo mi chiama pesantemente in causa nel suo articolo, come sempre stimolante, del 13 febbraio su questo giornale, con già nel titolo un richiamo alla «generazione dei senza politica». Gianvito ha addirittura virgolettato alcune mie frasi tratte da un nostro colloquio privato (ovviamente via whatsapp, come ormai quasi tutti i colloqui. Il confronto diretto è un mezzo ormai desueto, anche tra anziani, quorum nos). Si fa cenno, nell’articolo a una generazione «persa». Ovviamente non è una, ma sono molte, le generazioni perse alla politica. Dopo gli anni ’60, ’70 e ’80 quando tutto era politico, sono venuti gli anni del riflusso. A parte l’edonismo reaganiano e i cattivi esempi, molto hanno giocato, nel distacco delle generazioni dall’impegno politico, eventi storici come la caduta del muro di Berlino e dell’URSS. E quindi la caduta delle ideologie, che sorreggevano l’impegno politico. Un conto è lottare per un ideale, giusto o sbagliato che sia, un altro scendere in campo per il Pil o per lo spread. C’è stata poi la ventata dell’antipolitica, la Casta, Mani Pulite (vicende in cui hanno sguazzato forze oscure), la demonizzazione della Prima Repubblica. Chi poteva aver voglia di impegnarsi in questo contesto? Certo la politica non ha saputo rinnovarsi, ma dov’erano gli intellettuali ex éngagés? Non doveva essere questo il loro ruolo? Non dovevano s’éngagér nell’impresa, titanica, di riformare la politica e magari la sinistra? Piuttosto che sporcarsi le mani hanno preferito tenersi in disparte, criticare, magari irridere. Generazioni «perse», quindi.
E veniamo ai giovani, all’«occorre confidare nei diciottenni». E io, in loro, confido, con speranza e ragione. Certo, ci sembrano strani e alieni. Mastroleo si chiede come si faccia a trasferire loro i «fondamentali» per essere classe dirigente. Il fatto è che essi ci sembrano alieni perché non corrispondono alle nostre aspettative. C’è un racconto di Alice Munro, scrittrice canadese insignita del Nobel, ma non sufficientemente conosciuta da noi. Un racconto che ha dato anche spunto al film Julieta di Almodovar, che spiega ciò che voglio dire. In questo racconto Juliet, una madre single, cresce amorevolmente, forse troppo, l’unica figlia e questa, ad un certo punto, se ne va e scompare. La madre la cerca dappertutto, ma inutilmente. Ipotizza che possa essere stata rapita, che sia andata in India. Dopo anni di ricerche disperate si dà pace. Ma ancora alcuni anni dopo incontra per caso in strada un’amica della figlia che le dice di averla incontrata, qualche giorno prima, in una cittadina poco distante, in un centro commerciale, indaffarata e circondata da figli piccoli. Juliet si chiede come possa essere successo. Perché allora se ne è andata, non in cerca di avventure ma per fare una vita normale? Si può capire in India, ma a fare la mamma…. Io le stavo addosso, volevo il suo bene, volevo che fosse come me, ma magari è questo che non sopportava. Trascrivo a memoria, ma il senso è questo. L’incomunicabilità generazionale. Forse i diciottenni ci vogliono bene, ma non ci sopportano, non sopportano i nostri fondamentali, vogliono costruirne di nuovi. Non vogliono i nostri consigli, e, probabilmente, non ne hanno bisogno. Per noi sono alieni. Internet e la rivoluzione digitale hanno creato un mondo nuovo che noi stentiamo a capire, anzi non capiamo affatto. Internet è stata una cesura che ha comportato uno scarto pluriepocale.
I digitali nati sono homines novi, vengono da Marte, anzi dal cosmo più sconfinato, dato che di marziani a Roma ne abbiamo già visti. Dobbiamo persuaderci che non hanno interesse per i nostri fondamentali e forse non ne hanno bisogno. Che devono cercarsene e crearsene di nuovi, in un mondo nuovo. Che rifuggono dalle nostre aspettative. Vedi il loro rapporto con il lavoro. Non è più il diritto sancito dalla nostra Costituzione (probabilmente si riconoscono di più nel diritto alla felicità della Costituzione americana). Cercano un lavoro che li faccia star bene, che li gratifichi. È un sogno? Attenzione, c’è l’A.I. che può venire loro incontro. Sono meno competitivi e hanno bisogno di meno per campare? Il successo non è più il solo paradigma dominante? E allora? Alle lusinghe delle nostre aspettative rispondono spesso come lo scrivano Bartleby, (I would prefer not to) «preferirei di no». Sembrano rifiutare la corsa del topo (corri, produci, consuma, crepa) che abbiamo visto nei film di Ken Loach. Certo non è l’Eden, e anche per loro si prospettano problemi enormi. Ma li devono affrontare e risolvere con le loro forze, senza i consigli di chi le ha sbagliate tutte o quasi. Qualcosa potrebbe fare la scuola. Ma ne è in grado? Hanno dalla loro la giovinezza che può essere il periodo migliore o peggiore, ma certo è il più creativo. Hanno dalla loro strumenti che nessuno ha mai avuto, come l’accesso agevole all’informazione, che certamente pone dei problemi, ma siamo sicuri di dover essere noi a fornirne le chiavi di lettura? Le troveranno loro. La gioventù è sempre stata progresso, a dispetto dei vecchi. Non c’è dubbio che in questo processo la scomparsa delle ideologie abbia un peso notevole. I fascisti almeno hanno Acca Laurentia mentre i nostri simboli falce e martello, la bandiera rossa, avanti popolo alla riscossa, sono relegati ad una eterna drammatio memoriae. Per i giovani ci sono la lotta ecologista per il clima, la solidarietà del volontariato, la pace, ma soprattutto l’anelito alla giustizia sociale, l’eterna lotta di classe (senza la quale, lo ricordava Chico Mendez, anche l’ecologia non è altro che giardinaggio). Sono questi a mio avviso, i «fondamentali» a cui le giovani generazioni possono attingere, con nostra buona pace.