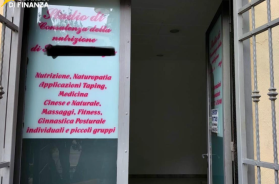Un giovane studente si uccide, ma non sembra un atto così clamoroso da destare l’attenzione dell’opinione pubblica che vira su soggetti e temi più incisivi capaci di destare l’interesse di opinioni che si alimentano con un like, o qualsivoglia reazione, per essere fagocitate in sacche di pregiudizievoli categorie.
La vita e il benessere dei giovani sono indispensabili se vogliamo avere una società sana, equilibrata. Quando parliamo di benessere non si intende avere il maglione griffato, le scarpe alla moda o l’i-phone di ultima generazione. Star bene significa saper distinguere l’avere dall’essere, aver coscienza di ciò che si è, delle proprie competenze, credere in sé stessi, aver fiducia negli altri, avere interlocutori sani ed essere ascoltati.
I ragazzi hanno bisogno di parlare, ma innanzitutto di essere ascoltati, compresi, non giudicati. Hanno impellenza a sognare, a desiderare. Devono poter sognare e gli adulti dovrebbero essere capaci di creare le giuste coordinate perché questi sogni possano diventare realtà. È superfluo paragonare le generazioni digitali con le precedenti, si rischierebbe di cadere in una vacua retorica. Non possiamo permettercelo! Tra i giovani di ieri e di oggi c’è l’abisso della tecnologia, del digitale che – è chiaro – non si può eliminare ma certamente si può educare all’uso e si possono aiutare i protagonisti della loro vita a pensare, a riflettere, a scegliere, a decidere: sul valore del tempo, delle relazioni, dell’amicizia, dell’amore, della parola. Si può e si deve aiutarli a disvelare ciò che spesso risulta un segreto e che non lo è affatto: essere umani. Essere umani significa poter cadere, significa soffrire, aver pazienza, attendere, avere fiducia, agire, lottare, vivere con i propri limiti, le proprie qualità. Accettarsi, migliorarsi, superarsi nella persuasione che ciascuno ha a disposizione dei talenti e che deve essere capace di utilizzare non solo per sé stesso ma anche per gli altri. Significa avere dei punti di riferimento, delle guide.
Ogni generazione ha simboleggiato un’epoca. Ogni epoca è stata madre di figli ribelli, di geni, di incompresi. È nella storia dell’umano. Ciò che è oltremodo essenziale è come i giovani di oggi considerano la vita, cosa pensano della morte e perché cedono a quest’ultima senza troppi condizionamenti, né timori. O forse perché sono troppo condizionati dalle aspettative verso la propria persona, la famiglia, la società. Le relazioni sono centrali nella vita di ciascuno. Sono quel filo sottilissimo che li lega alla loro individualità. Nello specifico, l’individuo è relazione: la reciprocità, l’incontro, la parola che caratterizzano l’essenza vitale per la crescita di un adolescente.
La filosofia greca sino alla contemporaneità ha affrontato il tema del «suicidio» condannato dal Cristianesimo, sostenuto da chi come Seneca abbia avuto la possibilità di decidere anche sulla propria morte. Qui ci si appella alla vita e alla libertà in virtù del principio di autonomia e si sconfina inevitabilmente in altre questioni che richiedono altrettanta attenzione e adeguate riflessioni. Al momento, più che il fine o la fine si intende valutare la causa, le motivazioni per le quali talvolta si giunge a tale definitivo tragico atto.
Anche in ambito bioetico si è trattato il tema del «suicidio giovanile» per l’obiettiva gravità del fenomeno. Più volte si è detto che le statistiche degli adolescenti, dei giovani che muoiono siano esageratamente di un numero elevato. È chiaro che esiste un disagio. Al riguardo, cosa si è fatto?
Nelle società industrializzate si appalesa un tasso di suicidio maggiore rispetto alle altre. I fattori di rischio sono tanti tra bisogni, desideri, frustrazioni: centrale è il ruolo della famiglia, il contesto sociale in cui si vive, il percorso scolastico, il gruppo dei coetanei, l’influenza dei social-media; non solo, la propria individualità, il rapporto col corpo, la concezione della vita, l’idea di libertà, il lavoro. Questi delicatissimi aspetti conducono a una possibile prevenzione del suicidio, intervenire prima che sia troppo tardi. Non temete: non si paventano interventi robotici né intelligenze artificiali. È più semplice di quanto si pensi: è sufficiente nonché ovvio educare, formare, essere in costante dialogo con gli adolescenti, i giovani, e questo lo può fare la famiglia, la scuola, gli organi competenti. È evidente che le difficoltà siano ancora numerose, permangono tali questioni sociali non ancora risolte, semmai si sono acuite. È necessario educare alla parola, all’uso corretto di essa, all’ascolto, alla «sospensione del giudizio», all’immaginazione, all’insegnamento che esiste un tempo in cui si può agire e un altro in cui si deve pensare, attendere, che esistono le difficoltà e che si possono superare. È la corretta relazione tra genitori e figli, tra insegnanti e allievi che genera soggetti liberi, pensanti e responsabili, quando anche questi sono dei modelli, delle testimonianze, degli esempi di uomini, donne, liberi e responsabili.
Insegnare ad amare la vita credo sia l’imperativo di ognuno e imparare a riempirla di senso e significato risulta un dovere etico per tutti.