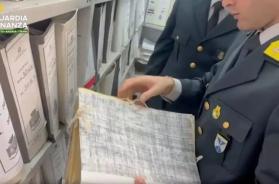Non è facile scrivere di un Papa pochissimo tempo dopo la sua nascita al Cielo. Si rischia di apologizzarlo, oppure di cadere in una spirale argomentativa retorica e poco opportuna. Eppure l’onore (e l’onere) di ricordare Francesco, nasce da una consapevolezza semplice e immediata: l’essere stato un papa generativo. Attraverso questo concetto - attinto per lo più dalle scienze umane e sociali - si sceglie di raccontare un uomo che «i miei fratelli Cardinali sono andati a prendere quasi alla fine del mondo», come disse appena eletto nel primo saluto al popolo di Dio accorso in piazza San Pietro e collegato in mondovisione. Un discorso programmatico a partire dalla scelta del nome petrino, rivelatore di un papato intenzionato ad andare oltre i gesti, i documenti, le decisioni di governo, i dogmatismi, ma pensato e vissuto soprattutto come un universo di senso. Che è stato anzitutto un sensus fidei, un istinto tramutato in amore per il Dio della Misericordia, ma anche un’intenzione costante di discernere riguardo alle cose della fede e alla loro incarnazione nel mondo. Ed è proprio nel discernimento (di matrice ignaziana), che si disvelano i segni evidenti e concreti di generatività, ossia della capacità di comunicare e realizzare sempre e comunque qualcosa di nuovo. Bergoglio ha fatto tanto da subito, ma nel novembre 2013, soltanto pochi mesi dopo la sua elezione, ha anche scritto e promulgato un’Esortazione apostolica sulla Gioia del Vangelo. Rileggere oggi Evangelii Gaudium (EG) risuona come una necessità per meglio comprendere l’essenza di un pontificato che se, da un lato è stato ispirato da una volontà trasformatrice e processuale, dall’altro non ha mai perso di vista la dimensione teologica della custodia. Francesco lo chiarì già nella sua prima omelia (19 marzo 2013) quando spiegò che custodire significa «ascoltare Dio, lasciarsi guidare dalla sua volontà, leggere con realismo gli avvenimenti, essere attento a ciò che ci circonda, prendere le decisioni più sagge». Si tratta di coordinate opportune per decodificare questi 12 anni vissuti con sguardo e corpo rivolti al popolo di Dio e - si legge al punto 116 di EG - alla bellezza del suo volto multiforme. Perché la chiesa, per il Pontefice nato a Buenos Aires, è stata soprattutto un incontro con le diversità dell’umano da non considerare mai come minacce o conflitti, ma come un’unità plurale animata dallo Spirito Santo e radicata in una storia proiettata verso un bene comune condiviso. In questo senso è stato un papa estremamente conciliare perché capace di (ri)collegare la chiesa con il suo aspetto storico e sociale e l’ecclesiologia con il suo senso sociologico ed etnologico. Lo dimostrano i suoi viaggi apostolici, le sue visite pastorali e alcuni luoghi prescelti per le celebrazioni. Sarebbe impossibile citare ogni spazio in cui ha consumato le suole delle sue scarpe (espressione che usò a proposito del dovere del giornalista). È sufficiente indicare le due estremità di questo cammino: l’isola di Lampedusa nel luglio 2013 e il carcere di Regina Coeli lo scorso giovedì santo. In mezzo campi profughi, villaggi africani, mense dei poveri, minoranze religiose ed etniche, come a disegnare un percorso circolare, segno evidente della sua idea di chiesa: non lineare, rigida, precostituita, rassicurante, ma incidentata, ferita, imperfetta e, per questo, sempre aperta alla speranza di un riscatto e di una riconciliazione. E al centro un Gesù equidistante e non giudicante, misericordioso e mai irremovibile, presente e non astratto. Per questo, la presenza e la voce di Francesco sono state fondamentali in qualunque territorio dell’umano. Egli ha destrutturato più volte il galateo dell’«ecclesialmente corretto», ha parlato di cinema, calcio, musica leggera, intelligenza artificiale, è incorso in qualche gaffe e ha addirittura svestito la talare bianca visitando, qualche giorno prima di morire, la Basilica di San Pietro con indosso semplici abiti «civili» e un poncho, come se volesse dire al mondo: «Sono soltanto un uomo argentino». Francesco ha attenuato l’aurea mistica del papato, così come ha scelto di de-istituzionalizzare l’organizzazione ecclesiale. Non lo ha fatto per progressismo di maniera o per volontà di divisione, ma soltanto perché ha annusato le urgenze di una contemporaneità complessa ed incerta che ha scelto di fronteggiare accompagnando la chiesa laddove Gesù l’aveva voluta: in mezzo alle persone. Questo sbilanciamento verso l’umano resterà l’impronta più profonda e generativa del suo ministero che non si conclude certamente con la sua morte. Perché scriveva Romano Guardini (teologo e scrittore amatissimo da Bergoglio): «Tutto ciò che è finito, è difettoso. E il difetto costituisce una delusione per il cuore, che anela all’assoluto».

Non è facile scrivere di un Papa pochissimo tempo dopo la sua nascita al Cielo. Si rischia di apologizzarlo, oppure di cadere in una spirale argomentativa retorica e poco opportuna
Mercoledì 23 Aprile 2025, 14:00