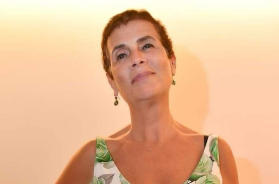Qui e ora, hic et nunc. Nei minuti, nelle ore e poi nei primissimi giorni seguiti al trionfo delle nostre pallavoliste, proprio all’ultima giornata delle olimpiadi di Parigi 2024, non c’è stato intervistatore e poi commentatrice o commentatore che non abbia chiesto all’allenatore della nazionale Julio Velasco di interpretare il «mantra» (così lo ha definito lui stesso) con il quale ha accompagnato le giocatrici nei quattro mesi da che ne aveva assunto la guida tecnica, fino all’imperioso 3-0 con il quale la squadra neo-campione olimpica ha regolato la finale con gli USA, e prima di quella tutte le precedenti partite, tranne l’esordio con la Repubblica Domenicana sconfitta solamente (!) per tre set a uno. Qui e ora.
Un trionfo anche per il tecnico argentino, già notissimo e molto amato nel nostro paese (ma non solo) per le imprese di cui è stato protagonista negli anni Novanta del ‘900, con la «generazione dei fenomeni» della pallavolo maschile. E nel commentare le sue parole (anche quelle pacate e ragionevoli a seguito di alcune dichiarazioni del mondo della politica e dell’informazione di cui – mi arrischio a dire – nessuno sentiva il bisogno, tanto meno l’urgenza) tutti ne hanno lodato la profondità, la saggezza filosofica e umana, l’equilibrio combinato con la consapevolezza. Probabilmente causandogli un qualche imbarazzo, che Velasco sembrerebbe coerentemente estraneo alle iperboli con le quali si usa trasformare le donne, come Paola Egonu, e gli uomini, come sé stesso, in personaggi.
Qui e ora. Lo ha ripetuto alle sue giocatrici per quattro mesi e poi ad ogni partita, durante ogni set, prima di ogni punto da giocare. Non pensare a quello che è successo prima – di buono o di negativo – tanto meno fuggire con il pensiero in avanti: concentrarsi solo sul punto da giocare, punto per punto. Vivere il presente.
Ovviamente Julio Velasco si rifà a una tradizione antica, le cui radici rimandano almeno all’hic et nunc nelle Odi di Orazio, che riecheggia in moltissima filosofia occidentale, e che trova equivalenza esistenziale anche nell’ Oriente buddhista, al quale sovente ci piace riferirci in maniera più immediata, tradendo un certo, compiaciuto piacere per il pensiero esotico.
Ma si può tornare indietro, in un passato ancor più remoto. È il suggerimento che ci arriva dalla lettura de, L’animale inquieto. Storia naturale della scontentezza, scritto a quattro mani da Edoardo Boncinelli e Marco Furio Ferrario. In questo godibilissimo saggio, gli autori individuano le radici evolutive dell’inquietudine che caratterizza la nostra specie sapiens, quel sentimento di continua, permanente scontentezza che ci accompagna, sovente condannandoci al malumore. Avrebbe a che fare con una conquista evolutiva, l’estensione del dominio temporale di cui siamo capaci più e meglio di qualsiasi nostro antenato. Nella riflessione di Boncinelli e Ferrario la percezione, la memoria, l’elaborazione e la previsione costituiscono le colonne portanti di ogni esperienza vivente. Ma in noi sapiens si apprezza un’estensione di questi domini esperienziali che è incommensurabile rispetto a qualsiasi altro essere vivente. Noi possiamo memorizzare un passato estremamente remoto e immaginare un futuro sempre più lontano. E la scontentezza deriva dalla mancata realizzazione delle aspettative, dal confronto del presente con qualcos’altro, che può essere un presente che si era immaginato diverso, un passato conservato nella memoria, un futuro nascosto in sempre nuove aspettative. Per comprendere la nostra natura inquieta, bisogna interrogarsi sul senso di inadeguatezza, su quello di colpa per non essere stati all’altezza, sul narcisismo, il delirio di onnipotenza e il senso d’inferiorità.
Essere consapevoli della finitudine, della limitatezza del nostro orizzonte esistenziale: la nostra eterna inquietudine e la conseguente scontentezza, partono da qui. Se altre forme di vita hanno un dominio di questa estensione piuttosto limitato, per noi è costante il confronto tra quello che è stato e quello che è/sarebbe potuto essere/potrà diventare. È la scontentezza che deriva dalla conquista del «simbolico», dalla nostra evolutiva capacità di astrazione. Che però, ovviamente, ha anche i suoi lati positivi. L’inquietudine, vissuta al meglio, funziona da pungolo verso il costante miglioramento, ci spinge sempre a cercare qualcosa di più: la sua declinazione virtuosa consiste nel rimodellare il mondo materiale per adattarlo al nuovo concetto di finalità con cui ci siamo co-evoluti.
C’è un tempo per il qui e ora, quindi, ma ce n’è anche uno utile a superare i limiti di ciò che è contingente, così da pensarci in spazi e tempi differenti. Fatti non fummo a viver come bruti, ma per cercar virtute e conoscenza. Inquieti e avventurosi. Ma viviamo nella complessità, e un altro poeta aggiungerebbe: «Non domandarci la formula che mondi possa aprirti». Sarebbe d’accordo anche Julio Velasco.