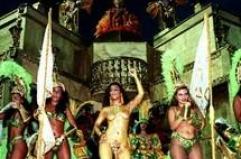Censura, la cara vecchia signora! Quella teatrale, ma anche quella cinematografica. La censura teatrale, con la necessità di un Nulla Osta preventivo su testi e copioni, in Italia è stata abolita nel 1998, quella cinematografica (su sceneggiatura e “prima copia” dei film) nel 2021. È rimasta la possibile limitazione “vietato ai minori”, quasi mai utilizzata per il teatro, di rado per il cinema. Resta il discorso della cosiddetta “autocensura”, ma questo, appunto, è un altro discorso.
Singolare è attraversare, “sub specie censurae”, la storia d’Italia degli ultimi due secoli: fra ‘800 e ‘900 si riscontrano infatti singolari contraddizioni, convergenze, ipocrisie. La censura su teatro e spettacolo, affidata dapprima per lo più all’intervento della Chiesa, si avvale del “braccio armato” della politica: vedi, per parlare di Verdi, delle traversie per Rigoletto che nel 1851 debuttò a Venezia (da Le roi s’amuse di Victor Hugo) declassato con la censura austriaca da corte regale a ducale del ‘500 (Mantova), oppure sempre con Verdi nel Ballo in maschera, in scena a Roma nel 1859, spostato dalla Svezia con regicidio del ‘700 alle Americhe (Boston) del ‘600. Per stare agli anni dell’Unità d’Italia, nel passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia, il controllo sulle attività teatrali è affidato (circolare Galvagno, 1852) al Ministero dell’Interno, ciò fino al 1865 quando (norma di Silvio Spaventa) tutto fu delegato ai prefetti, decentrando così l’attività censoria. Crispi nel 1889 emana una legge in cui si regola l’attenzione sul teatro: i prefetti, nelle diverse province, visionano in anticipo testi, spettacoli (anche mediante spie prezzolate) e concedono o revocano permessi. Oggetto della vigilanza sempre la triade Dio-Patria-Famiglia (un po’ meno quanto a religione, visto che i nostri risorgimentali erano tutti anticlericali e massoni), con proibizioni circa le figure del Re, del Governo, dell’Esercito, a parte l’ovvio moralismo pudibondo quanto a sesso e moralità coniugale. Il problema del decentramento prefettizio è che crea caos e disagi a compagnie e capocomici, con disparità di opinioni, trattamenti, valutazioni, fra una zona e l’altra d’Italia. Il sistema resterà in vigore fino al primo dopoguerra, quando si preoccuperà il Fascismo di riportare il tutto sotto il controllo centrale del Ministero, prima dell’ Interno poi della Cultura, a partire dal 1929. È qui che entra in campo un personaggio per certi versi straordinario: è tale Leopoldo Zurlo (1875/1959) che fu fino al 1943 responsabile unico della visone e valutazione di testi e copioni in Italia. Era in fondo un intellettuale, quasi dispiaciuto di dover manomettere i testi, che spesso “riscriveva” in collaborazione con gli stessi autori, spesso ben contenti dell’agevolazione, per così dire. Zurlo dipendeva dal capo della polizia Bocchini, poi anche da Galeazzo Ciano, sempre sotto l’egida del capo, Mussolini, che metteva becco in tutto. Se la prese con alcune opere di Sem Benelli, pure fascistissimo, ebbe a che fare con Roberto Bracco, che da antifascista era stato bandito dai teatri, ma che pure Zurlo riuscì, nel ‘41, a far debuttare a Napoli. Molto si intrigò con Michele Galdieri e le sue riviste, non tanto per le donnine scollacciate, per le battute e le volgarità, quanto per la capacità, dei “comici” in specie, di scappar fuori dai copioni verso improvvisazioni rischiosamente politiche. Furono, va detto, al di sopra di qualsiasi censura e al riparo da ogni pericolo tre o quattro figure teatrali degli anni ‘30: Pirandello in primis, dopo la sua adesione al fascismo nel ‘25, l’immenso Petrolini, che quando fu insignito del cavalierato della Corona d’Italia esclamò impettito Me ne fregio! A seguire cito i De Filippo, assai apprezzati (a differenza di Raffaele Viviani che scontò il suo popolarismo ritenuto troppo vernacolare) i quali Fratelli furono difesi a spada tratta dai Savoia, che spesso li accolsero per recite private nel teatrino di Villa Savoia a Roma, infine Totò sempre irraggiungibile e incensurabile.
Dal ’30 al ’43 Zurlo lesse e visionò 18.000 copioni (due-tre al giorno!). Nel ’43, mentre col 25 luglio impazzò la libertà e Paola Borboni in camicia da notte su una cabriolet percorreva Via del Tritone issando il tricolore, dopo l’8 settembre arrivarono i tedeschi, coi fascisti di Salò: Zurlo non aderì a Salò, se ne andò in pensione. Nel 1952 pubblicò un malinconico libro di ricordi, Memorie inutili, quasi a dire come inutile, in fondo, è la censura in Italia, da vecchia amica-nemica del teatro.
Oibò, e la censura in età repubblicana, dopo il 1945? Questo è un altro copione, occorrerà parlarne. Lo faremo.