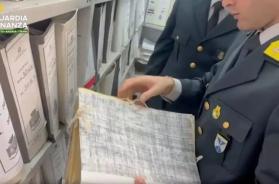Per i greci non vi erano che conseguenze devastanti per chi decideva di sfidare i propri limiti umani commettendo hybris, la colpa di chi supera il limite imposto dalla divinità alla sua condizione materiale. D’altronde la spiegazione della sconfitta dei persiani nell’omonima opera di Eschilo avviene tramite l’accusa a Serse di aver commesso hybris nel tentativo di conquistare l’intero Egeo. In altre parole, al fondo della nostra cultura occidentale sembrerebbe esserci sempre questo immancabile freno che ci tiene a bada da un pericoloso osare. Cosa che per fortuna non avviene nell’arte moderna di oggi, in cui, in alcuni casi, il recupero di istanze rappresentative del sé culturale che ci definisce diviene piuttosto un’inarrestabile sfida verso un futuro che limiti sembra non averne più.
Così mentre Carlo Saraceni, (Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, olio su rame, 1606-7) in un meraviglioso dipinto seicentesco ci mostrava un dramma già concluso, senza schierarsi dalla parte di Icaro, o forse soltanto per un briciolo di compassione umana, in un periodo storico in cui del resto, vista la repressione della Controriforma non ci si poteva permettere più di tanto, se prendiamo invece in esame, per esempio, il capolavoro del preraffaellita Leighton, notiamo che la volontà di Icaro di sfidare il suo destino è più forte che mai, e a nulla valgono le raccomandazioni di Dedalo. La generazione precedente sembra aver fallito nelle sue imposizioni (tema molto fortunato nella successiva letteratura dell’800 che vede una delle sue massime espressioni in Padri e Figli di Turgenev).
Ma bisogna arrivare a uno Chagall del 1975, saltando l’ardore di Chini o la sospensione quasi giocosa che Gowy recupera da Rubens, per arrivare a comprendere l’evoluzione di quella che è stata artisticamente la rappresentazione di un mito così attuale anche per noi. È un moderno Icaro quello di Chagall che, quasi per sfizio, prova a librarsi nel cielo come un uccello. Cambiano i colori e forme delle figure (più accesi e allegri), ma la sensazione che ci comunica il protagonista è comunque quella dello sgomento, suggerendoci che nella storia infinita dell’arte, e quindi dell’inconscio umano, a nulla sia valsa la lotta, dal momento che il nostro destino ultimo sembra essere quello di svanire nell’indifferenza e nella superficialità. Siamo molto lontani anche da un Matisse del ’43, che lo aveva rappresentato come figura stilizzata che abbraccia semplicemente le stelle dei suoi sogni.
Mai però come con l’Icaro di Igor Mitoraj sembra realizzarsi quella sintesi tra classicismo e modernità di cui inizialmente abbiamo parlato. Classe ’44, sotto la guida del grande pittore, scenografo e regista Tadeusz Kantor, trascorre lunghi periodi tra New York e la Grecia, determinanti in questo senso.
Nella sue sculture, (quella di Icaro è stata ripresa anche dalla fotografa Annett Siviglia Mann nel 2020) si percepisce la volontà di recuperare il senso profondamente umano di una tradizione che è fondamento indissolubile anche del nostro moderno vivere, cercando però di mantenerne quella parte buona che dovrebbe accompagnarci sempre come un faro verso le avvincenti sfide dell’uomo del futuro.