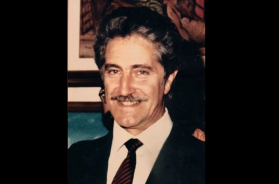Sul caso del tramonto dello stabilimento TD Bosch di Bari, è utile chiedersi cosa ci stia dicendo la crisi dell’industria. Al di là delle indiscusse cause esogene relative alla competizione del mercato internazionale e agli asset che lo guidano - quali i prezzi della manodopera, la carenza delle infrastrutture e dei servizi connessi, i tempi e le complicazioni della burocrazia italiana -, abbiamo da porci una domanda sul ruolo della politica riguardo la presenza di un modello organizzativo strutturale nel nostro territorio: la piccola e media impresa. È indubbio che gran parte dell’economia si è basata negli ultimi anni soprattutto su di essa e non solo sull’indotto delle industrie dei settori più trainanti.
Dall’analisi di Guglielmo Forges Davanzati, infatti, del 28 di questo mese su «La Gazzetta del Mezzogiorno», sappiamo che è esistita una politica economica che ha inteso finanziare le industrie di stato e che queste ultime hanno registrato un rialzo successivamente agli investimenti (Cassa per il Mezzogiorno 1950) con una decrescita nel corso dei successivi cinquanta anni circa.
Qual è il bilancio di sostenibilità degli insediamenti industriali nel nostro territorio, che a seguito di anni in crescita, a beneficio di gran parte della popolazione italiana, hanno mostrato una grandissima vulnerabilità proprio a causa della loro dimensione e della mancanza di flessibilità richiesta dal cambiamento strategico e organizzativo in breve tempo, in prossimità delle crisi internazionali e della liberalizzazione e globalizzazione dei mercati?
Senza considerare – sempre secondo Forges Davanzati – «le privatizzazioni crescenti e la mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo che le ha rese dipendenti tecnologicamente e politicamente dall’estero». La politica ha sempre saputo tutelare i grandi investitori, i colossi dell’industria nostrana per un interesse diretto al territorio.
Tuttavia, forse è ora di chiedersi se la politica non debba anche procedere ad una scommessa più specifica e strutturata atta a salvaguardare e stimolare l’economia dei modelli esistenti che se pure più piccoli, rappresentano una sicurezza e una stabilità continuativa e stabile nel tempo.
In Italia abbiamo anche una forte vocazione imprenditoriale di piccole e medie imprese a carattere famigliare. Sappiamo che in Puglia sono presenti 6.363 unità (Confindustria 2022) tra Start-up, Pmi consolidate e imprese famigliari e Pmi parte di gruppi multinazionali con un approccio locale.
Sono presenti in misura maggiore nel Sud Italia, sorte a partire dal periodo di forte crisi e della ricostruzione industriale nella seconda metà degli anni ‘60, chiuso al ciclo espansivo dal periodo della ricostruzione post-bellica. Quindi le Pmi continuano ad essere solo un prodotto della crisi fordista degli anni ‘70, contrapponendo alla rigidità dell’epoca un modello di industria flessibile e specializzata (Castronovo, 1999)?
Superando infatti i fattori principali di povertà e di arretratezza del nostro tessuto imprenditoriale (Bevilacqua 1993) - le carenze strutturali, l’isolamento delle imprese, la sfiducia nelle politiche di coesione e aggregazione territoriale, da cui è derivata una povertà culturale più che economica-, possiamo affermare che il modello della Pmi è un sistema organizzato che trova nella sua tipicità e nelle qualità di una organizzazione del lavoro e della produzione tipica locale, un proprio motivo di eccellenza, al pari di un modello strutturato più grande.
Se le Pmi prendono distanze da quello che Bagnasco definiva il familismo amorale descritto come la massimizzazione dell’interesse soggettivo e materiale del nucleo familiare anche a discapito della comunità allargata, originario del clientelismo, dei patriottismi, dei clan familiari antagonisti in lotta per il potere personale, sindacale e associativo, si richiama l’urgenza di pensare a una nuova politica economica che riconsidera il valore e il potenziale di reti territoriali per lo sviluppo, accordi di filiera e potenziamento di un piano strategico che le consideri centro propulsivo dello sviluppo economico a partire dalle specificità territoriali.
Si rende necessario investire, altresì, sulla cultura aggregativa e associativa interna ed esterna alle organizzazioni, recuperando i valori che oggi superano il concetto di economia capitalistica e si orientano a virtuosismi pratici, oramai anche certificati (Benefit, di Genere etc.) che ne attestano la sostenibilità (finanziaria, di governance, ambientale e sociale).