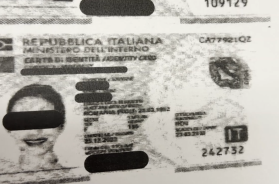L’oppositrice, la presidente e l’imprenditrice. Elly Schlein, Giorgia Meloni e Marina Berlusconi: tre donne leader, specchio dei tempi, interpreti di posture politiche e culturali simmetricamente opposte - woke, conservatrice e liberale. Con la loro presenza rappresentano, da angolazioni diverse, l’Italia di oggi e quella di domani.
Elly Schlein, leader del principale partito dell’opposizione, partendo dallo spregevole attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, è giunta ad accusare il governo Meloni di restringere le libertà, sostenendo che «la democrazia è a rischio». Le parole sono pietre. Mai come oggi questa metafora appare drammaticamente attuale. Una parola è un segno, un suono, un frammento di pensiero; la pietra, invece, è materia, corpo, urto. Eppure, quando le parole vengono lanciate come pietre, diventano strumenti di offesa: feriscono, scavano solchi difficili da rimarginare. La politica italiana, ormai da tempo, procede a colpi di parole-pietre, in un crescendo di aggressività verbale che segna una deriva inquietante. Il sistema democratico rappresentativo, fondato sul confronto e sulla misura, sta mutando sotto il peso di un linguaggio esasperato e polarizzante. In un mondo dominato dalle Big Tech, in cui il balance of power va scemando e ogni frase può trasformarsi in un proiettile digitale, il lancio è continuo, incessante, privo di filtri e di responsabilità.
Marina Berlusconi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha denunciato lo strapotere delle Big Tech, dove «democrazia e libertà sono voci isolate che vale la pena continuare ad ascoltare». I colossi della Silicon Valley, aggiunge, «sono passati dal wokismo al trumpismo con la disinvoltura di chi cambia una felpa». In definitiva, si produce così «il brodo culturale della polarizzazione e della radicalizzazione, in cui purtroppo affoga anche la politica». Nessuno può dirsi al riparo dalla violenza delle parole: la libertà di espressione, conquista irrinunciabile delle democrazie moderne, rischia di essere distorta dall’abuso, dalla disinformazione e dall’anonimato. Sui social, ogni individuo diventa editore di se stesso, ma senza gli obblighi morali e professionali di chi fa informazione. La velocità della rete annulla la riflessione; il «mi piace» sostituisce l’argomentazione; la verità si dissolve in un mare di opinioni. Così, la libertà di parola - valore assoluto in una società aperta - si trasforma, paradossalmente, nel suo contrario: in una libertà che ferisce, delegittima, distrugge.
Dietro l’asprezza delle parole si nasconde però un vuoto politico e culturale. Quando mancano i contenuti, restano le invettive. Quando viene meno la visione, si cercano nemici. È qui che il confronto democratico degenera in scontro tribale, dove non conta più convincere, ma colpire. «Buscar el levante por el ponente», cercare l’Oriente a Occidente, è un vecchio proverbio spagnolo che allude a chi cerca la verità nel posto sbagliato. Forse è proprio questo il male della nostra politica e della nostra informazione: cercare nel luogo sbagliato. Si invoca la libertà, ma si coltiva la rissa; si parla di democrazia, ma si alimenta il sospetto; si difende la stampa libera, ma la si piega al tifo.
Nel tentativo di descrivere un’Italia oppressa da un presunto clima illiberale, Schlein finisce per scivolare in una narrazione apocalittica che annulla il pluralismo e alimenta una visione caricaturale del Paese. L’idea di una «democrazia a rischio» non è più un allarme, ma diventa uno strumento di mobilitazione emotiva, utile a cementare un fronte elettorale in vista dell’ultima coda delle regionali che si terranno a fine novembre e dell’importante appuntamento del 2026, quando la riforma della giustizia - e con essa la separazione delle carriere - sarà sottoposta a referendum confermativo. Sarà quella la prima vera prova di forza tra maggioranza e opposizione: un banco di verità che anticiperà il gran finale delle elezioni politiche del 2027. Saranno quelle le vere prove che decideranno le sorti della Repubblica, il suo equilibrio democratico e la fiducia del cittadino nello Stato. Solo allora si vedrà se Elly Schlein avrà avuto ragione nel dire che l’Italia è stata, come in una canzone di Francesco De Gregori, «derubata e colpita al cuore» democratico, oppure se Giorgia Meloni potrà rivendicare l’opposto, con parole destinate a restare nella memoria politica del Paese: «Viva l’Italia che resiste» nella libertà.
Là dove Schlein vede ombre e incolpa l’avversaria di vittimismo, Meloni rivendica stabilità; dove si grida all’autoritarismo, lei parla di premierato. In mezzo, resta il Paese reale: stanco delle parole-pietre, delle accuse reciproche e delle narrazioni tossiche. Un clima che alimenta la disaffezione degli elettori e finisce per produrre governi di minoranza. In conclusione, forse la vera libertà, oggi, non è gridare alla dittatura, ma recuperare la misura del dialogo e la forza della verità.