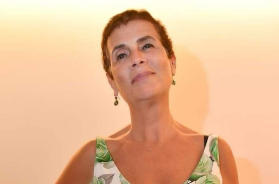Una chiave di lettura probabilmente utile per comprendere la tormentata vicenda dell’ex Ilva può essere fornita dalla ricostruzione delle vicende delle privatizzazioni in Italia. L’occasione è offerta anche dalla recente pubblicazione di un interessante volume sull’economia italiana, e, in particolare, sulla svolta del 1992 (Franco Amatori, Pietro Modiano e Franco Reviglio, a cura di, L’Italia al bivio. Classi dirigenti alla prova del cambiamento: 1992-2022, Franco Angeli, Milano 2024), con interventi di alcuni fra i migliori economisti e storici economici italiani e di autorevoli protagonisti di quella stagione, fra i quali Giuliano Amato e Romano Prodi.
Il punto di partenza di questa ricostruzione è dato dall’evidenza empirica registrata dall’Ocse, nel Rapporto «Regulatori Reform in Italy» del 2001: le privatizzazioni italiane hanno costituito uno dei più imponenti trasferimenti di ricchezza della Storia occidentale da uno Stato sovrano a imprenditori privati. In particolare, il nostro Paese è arrivato tardi a privatizzare, ma ha fatto di più e ha fatto più rapidamente di tutti gli altri Paesi industrializzati.
Le motivazioni che furono avanzate per le dismissioni di importanti imprese pubbliche in quel periodo furono sostanzialmente due: in primo luogo, si ritenne il nostro settore pubblico esclusivamente fonte di sprechi e inefficienze, ancor più a seguito del coinvolgimento di vertici aziendali nell’inchiesta Mani pulite; in secondo luogo, si argomentò che le privatizzazioni avrebbero consentito una migliore allocazione del risparmio delle famiglie italiane.
La letteratura sull’argomento evidenzia che la reale motivazione della vendita di imprese pubbliche fu il «fare cassa». Si trattava, infatti, di produrre risparmi dello Stato, e di farlo con urgenza, a seguito della stipula del Trattato di Maastricht e, dunque, della necessità di ridurre il rapporto debito pubblico/Pil in vista dell’adozione della moneta unica. Il 1992 fu anche l’anno della crisi valutaria che determinò l’uscita della Lira dallo Sme nel settembre del 1992, a seguito degli attacchi speculativi dei mesi precedenti e fu anche caratterizzato dall’inutile tentativo della Banca d’Italia di contrastarli.
La convinzione che l’elevato debito pubblico fosse il principale problema dell’economia italiana e che fosse necessario porvi rimedio riducendo in modo rilevante e rapido la spesa pubblica fu alla base delle politiche di privatizzazione ed è stato anche successivamente - ed è ancora - l’ingrediente essenziale della politica economica nel nostro Paese. Sia qui sufficiente ricordare che dal 1991 al 2023 l’avanzo primario del bilancio pubblico rispetto al Pil è stato pari al 2.3%, superiore al valore registrato in Francia (0.9%) e Germania (0.8%), e secondo, in Europa, esclusivamente al Belgio (2.7%) e che si è avuto disavanzo del settore pubblico solo nel 2009, a seguito della grande crisi finanziaria dell’anno precedente, e nel periodo della pandemia, nel 2020-2021.
L’obiettivo di fare cassa vendendo proprietà pubbliche fu strettamente connesso alla mancanza di un disegno strategico in ordine a quali settori industriali fosse eventualmente opportuno tutelare per gli interessi nazionali e per la crescita economica di lungo periodo. In particolare, con le privatizzazioni di quel periodo, si perse il fondamentale contributo che IRI dava alla ricerca e sviluppo. Una fondamentale ricerca di Storia di quella impresa (Storia dell’IRI, Laterza) documenta che, ancora negli anni Ottanta, la quota di ricerca effettuata in quell’impresa era superiore a quella realizzata da tutto il settore privato.
Le privatizzazioni sono state, da questo punto di vista, il tassello essenziale che ha portato alla perdita della nostra «sovranità tecnologica», ovvero al depauperamento di una base produttiva con elevata intensità tecnologica. La cessione a privati implica, infatti, un elevato rischio di comportamenti opportunistici da parte di questi ultimi di tipo «mordi e fuggi»: rapida acquisizione di profitti in Italia e altrettanto rapido disinvestimento, per successivamente riallocare i propri capitali in altre sedi diventate, nel frattempo, più convenienti.
A ciò si aggiunge un’ampia evidenza che mostra l’aumento del grado di concentrazione industriale su scala globale. Questo significa che la vendita di imprese pubbliche a soggetti privati incontra sempre meno potenziali acquirenti, in un contesto, peraltro, nel quale gli assetti proprietari stessi risultano sempre più concentrati e nel quale, per conseguenza, l’intensità della concorrenza è via via minore. In questo contesto, si verificano effetti di «cattura del regolatore»: le imprese regolate possono influenzare - e trovano conveniente farlo - le decisioni del regolatore (il soggetto pubblico), imponendo sprechi di risorse alla collettività.