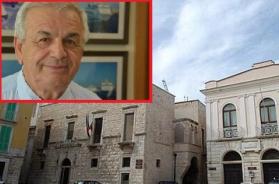La vicenda dei quattro bambini colombiani, sopravvissuti, senza alcun aiuto, per quaranta giorni ai pericoli della giungla, induce delle riflessioni sul tema fragilità vs resilienza, quest’ultima parola molto utilizzata in questi nostri tempi abbastanza complessi e complicati.
La stampa riporta, con dovizia di particolari, la cronaca di quelle quattro decadi vissute dai piccoli, rimandando soprattutto a due elementi: la forza della «natura», della giungla ma anche di quella dei quattro bambini, e la «cultura» alla quale appartengono: indigena e salvifica poiché ancora in grado di trasmettere alle generazioni a venire la saggezza di un rapporto, quello tra natura e cultura, rispettoso e mutualistico.
Pur rischiando la retorica e la nostalgia del lost paradise credo che possa essere utile riflettere sul concetto di natura benevola, che è tale nel momento in cui non è aggredita e violentata come, purtroppo, succede da molti anni in molte zone del mondo mentre, giocando sul filo delle attribuzioni, al contrario frequentemente la cultura, cui diamo vita con i nostri comportamenti, risulta essere malevola.
Nel caso dei quattro bimbi sudamericani, è indubbio che abbiano vissuto una quota inimmaginabile di stress: dall’incidente aereo alla morte della madre, dall’impatto con un territorio sconosciuto e pericoloso al dover provvedere da soli al sostentamento di base per non morire di fame e di sete. Un più che probabile PTDS (Disturbo Post Traumatico da Stress) dovrà essere «curato» anche se ce l’hanno fatta sul piano fisico.
Una condizione traumatica che purtroppo ancora colpisce i bambini che vivono in zone di guerra. Si pensi ai bambini palestinesi e siriani, per esempio, o, guardando ad un’altra parte del mondo, ai bambini ucraini.
Il trauma, potente e pesante, se non elaborato influenza la vita mentale adulta anche se, come succede in molti casi, può essere «dimenticato» dalla memoria esplicita ma continuare ad agire, se non opportunamente curato, in quella implicita.
È il caso dei sopravvissuti, per fare un ulteriore esempio, ai lager nazisti.
In queste ore molti si stanno chiedendo se uno dei nostri figli, in una situazione simile, ce l’avrebbe fatta. Molto probabilmente no e questo perché la fragilità e la resilienza, cui si accennava in apertura di questa breve riflessione, al giorno d’oggi sono relativamente tenute in considerazione dagli adulti che si occupano dei bambini. Il risultato, pertanto, in molti casi sono bambini «psicologicamente cagionevoli», non in grado di resistere alle fisiologiche frustrazioni della vita (la loro vita) a causa di un generale sistema educativo permissivo e, frequentemente, lassista. Forse per un senso di colpa dei genitori e degli educatori in genere che, a fronte dei repentini cambiamenti sociali, hanno difficoltà a dare risposte certe, e per questo rassicuranti?
Probabilmente. Ma un bambino ha bisogno, come il pane, di certezze educative, di punti di riferimento, anch’essi educativi, stabili; di regole che dovranno essere discusse ed argomentate ed, eventualmente, anche modificate nell’alveo di una «dialettica pedagogica» e di una costante «presenza affettiva» che dia continuità, presenza dell’adulto e contenimento emotivo alla crescita.
In una realtà sociale e culturale, nella quale viviamo e dove accade che i bambini addirittura vengano «dimenticati» in auto perché il padre o la madre «hanno fretta» o hanno mille impegni cui adempiere, il tema della cura educativa e dell’attenzione all’accudimento psicologico di ogni figlio dovrebbe essere centrale in ogni politica che intenda promuovere un efficace sostegno alla famiglia che sta cambiando ed alla quale i vecchi fari che ne illuminavano il cammino ormai sono spenti da tempo.