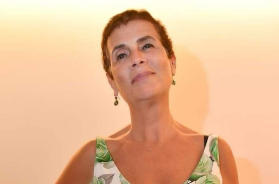«Se credete di aver capito la teoria dei quanti, vuol dire che non l’avete capita. Penso infatti si possa tranquillamente affermare che nessuno capisce la meccanica quantistica”». Se a dirlo è Richard (the Genius) Feynman, premio Nobel per la fisica nel 1965 per l’elaborazione dell’elettrodinamica quantistica… beh, in un certo senso è rassicurante.
Molta scienza, a far data dai primi decenni del ‘900, ha divorziato dalla raccontabilità. Se la fisica di Newton o le equazioni di Maxwell e la legge elettromagnetica di Faraday erano e rimangono di difficile comprensione, relatività, quantistica e l’incompletezza sancita dai teoremi di Kurt Godel sono sviluppi e acquisizioni della cultura del XX secolo che hanno fatto dire ad uno dei suoi protagonisti, il tedesco Werner Heisenberg, «Cosa siano gli atomi non abbiamo i termini adatti per dirlo, perché la lingua che parliamo si fonda sull’esperienza ordinaria, alla quale gli atomi non partecipano». Quando è la stessa esperienza del mondo a cambiare, bisogna inventare una nuova lingua. O, intanto, provare a contaminare i generi di discorso.
In un suo recentissimo, I TRE. Federer, Nadal, Djokovic e il futuro del tennis, Sandro Modeo, scrittore, saggista, uno dei consulenti editoriali più apprezzati nel nostro Paese, riprende e attualizza una formula che aveva già sperimentato con grande successo tra il 2010 e il 2011 dando alle stampe due illuminanti saggi, uno dal titolo L’alieno Mourinho, dedicato al carisma e alle capacità dell’allora allenatore del triplete, l’altro Il Barca, in onore del calcio di Pep Guardiola e del suo sfavillante Barcellona. Cosa c’entrano relatività, meccanica quantistica, biologia molecolare, psicologia cognitiva - e tanto, tanto altro - con il ciclo ventennale dei tre campioni del tennis che tutti insieme, ad oggi, hanno messo in bacheca complessivi 64 slam, condannando una generazione di atleti loro coetanei all’insignificanza? In che modo, il calcio di José Mourinho e di Pep Guardiola, ci possono aiutare a raccontare tutti altri ambiti, interrogativi, storie? Leggere per credere!
La scelta, se si vuole l’astuzia, è quella di utilizzare un tema, e una serie di personaggi, e alcuni avvenimenti di grande risonanza pubblica - le finali di Champions, i tornei del grande Slam - per avvicinare il lettore, metterlo a suo agio all’interno di un ambiente conosciuto, confermarlo nei suoi interessi e nella passione, facendogli capire che alcune acquisizioni di frontiera delle scienze cosiddette dure, la conoscenza della storia dell’arte e della musica, la frequentazione dei grandi classici della letteratura, la consapevolezza storica, in altre parole un vasto e consapevole patrimonio di conoscenze, non solo non t’impedisce di godere delle gesta dei tuoi atleti preferiti, ma ti mette anche nella condizione di capirli meglio, di apprezzarli ancora di più. Alla faccia della noiosità della cultura alta!
Naturalmente il discorso fila anche specularmente, ché chi fosse convinto che non vi è nulla in ciò che accade nel calcio, nella boxe, nel grande basket, nel rettangolo di un campo da tennis, degno di suscitare interesse in un animo nobile avvezzo alla bellezza delle lettere classiche, potrebbe scoprire, magari piacevolmente, che il suo snobismo era assai mal coltivato. E magari ricordando che già un grande scrittore contemporaneo come David Foster-Wallace aveva raccontato il tennis, e Roger Federer in particolare, come «un’esperienza religiosa».
Della frequentazione della cultura alta e bassa, Umberto Eco aveva fatto un marchio di fabbrica; un matematico e filosofo della Scienza come Giulio Giorello non mancava mai di ricordare come, sedicenne, leggeva l’Etica di Spinoza insieme all’albo Topolino: e non v’era settimana o mese che saltasse l’appuntamento in edicola con Tex Willer e altri fumetti di cui era avidissimo lettore. Libri e militanza culturale come quella di Modeo ci ricordano che alla diffusione dei cosiddetti saperi complessi - non c’è mica solo la scienza, si pensi alla difficoltà di penetrare molti concetti e discorsi in ambito giuridico - corre in soccorso la capacità e la curiosità di frequentare campi dell’esperienza e generi di discorso che possono essere apprezzati anche facilmente (?) ma che non di rado nascondono ricchezze in grado illuminare, di riflesso, asperità concettuali altrimenti inattingibili ai più.
Forse ricordando anche la lezione del semiologo Paolo Fabbri: «Io non sono interessato a una prospettiva ontologica o a capire se qualcosa è vero o è falso: a me interessa cosa significa». Forse cercare l’Essere e la Verità, in effetti, può essere per pochi. Ma scoprire un po’ di senso, anche laddove sembra ci sia solo intrattenimento, magari aiuta a vivere meglio.