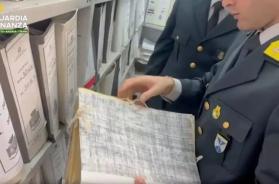Ancor oggi le emozioni abitano «una terra in gran parte sconosciuta». Le emozioni hanno la loro radice nella parte più antica del nostro cervello (amigdala, ippocampo, locus coeruleus) e influenzano le parti più nobili della nostra psiche come i nostri sentimenti, i nostri vissuti, le relazioni sociali e anche le nostre strutture mentali. Le diverse teorie delle emozioni, da quella di Darwin, psicoanalitica a quelle neuroscientifiche, fanno capo a due modelli interpretativi: platonico e fenomenologico.
Nel suo ultimo lavoro Umberto Galimberti (“Il libro delle emozioni”,Feltrinelli, pp. 188, Euro 17) opta per il secondo modello: «se vogliamo capire che cos’è un’emozione, non possiamo partire dal dualismo platonico di anima e corpo, dove le emozioni sono descritte da una mente con categorie psicologiche, ma dobbiamo assumere il punto di vista fenomenologico, inaugurato da Husserl, Heidegger, Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty, Borgna, dove il nostro corpo vivente, originariamente aperto al mondo, suscita immediatamente un’emozione di attrazione o repulsione senza bisogno di mediazioni razionali».
La tecnologia, che non è, come si è soliti pensare, uno strumento, ma, per effetto della sua espansione, è un mondo, il nostro ambiente, che ci plasma e condiziona il nostro modo di pensare e di sentire, ha sviluppato le nostre potenzialità intellettuali e impoverito il mondo immaginale, emotivo e sentimentale.
Galimberti ci offre un ricco spaccato dell’attuale condizione umana. Tra gli effetti più preoccupanti della comunicazione digitale, della sua logica binaria, annovera la de-realizzazione, la marginalizzazione della realtà “fisica” in favore di quella virtuale, e la de-socializzazione, la riduzione drastica dei processi di socializzazione per effetto dell’isolamento del singolo individuo.
La pubblicizzazione della propria intimità riduce l’uomo alla sua immagine e gli fa perdere il pudore. Tutto questo approda a un solo effetto:«attuare l’omologazione della società fin nell’intimità dei singoli individui e portare a compimento il conformismo. In fondo – aggiunge Galimberti – non è un’operazione difficile. Basta «non aver nulla da nascondere, nulla di cui vergognarsi», che tradotto significa: «sono completamente esposto», «non custodisco nulla di intimo, ma in compenso ho guadagnato visibilità, conformità sociale e forse qualche apprezzamento per il mio coraggio e la mia sincerità».
Anche i rapporti personali seguono lo schema dei prodotti pubblicizzati. Le scelte non implicano più impegni e conseguenze, sono rese disponibili dalla cultura del consumismo. Tutto, dalla scelta di un amico a quella di una carriera, «può essere suscettibile di una cancellazione immediata, non appena si presentino opportunità all’apparenza più vantaggiose». La libertà è intesa come revocabilità di tutte le scelte.
Galimberti sottolinea la fondamentale importanza dell’educazione emotiva e dei sentimenti dei ragazzi, alla quale ha dedicato con Anna Vivarelli un bel volume con le illustrazioni di Alessandra De Cristofaro dal titolo “Che tempesta! 50 emozioni raccontate ai ragazzi” (Feltrinelli, pp. 231, Euro 19,50).
È venuta a mancare l’educazione delle pulsioni, manca il tragitto che dalle pulsioni, che a differenza degli istinti sono indeterminate, conduce alle emozioni e poi ai sentimenti.
Si dovrebbe pensare, come suggeriva Alessandro Manzoni, «più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio».
È la risonanza emotiva che permette di sentire, prima della riflessione, la differenza tra il bene e il male, il giusto e l’ingiusto. Più per via emotiva che mentale, ascoltando le fiabe o le letture delle nostre mamme, si acquisiva «un regolatore emotivo, che ci consentiva di “sentire” quando le nostre azioni erano buone o cattive, giuste o ingiuste. Senza un’educazione emotiva, – concludiamo con Galimberti - oltre a non avere un’immediata consapevolezza della bontà o meno delle nostre azioni, si rimane a livello pulsionale, con una pericolosità sociale che la cronaca nera di ogni giorno non cessa d’illustrarci».