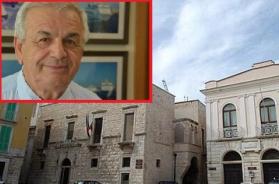Da Bruno Marchi, specialista in Psicoterapia Psicoanalitica a Fasano (Brindisi), riceviamo e pubblichiamo.
«I fatti di Foggia», della struttura psichiatrica degli orrori, testimoniano e segnalano una protervia ed un accanimento contro i fragili tra i più fragili: i portatori di disagio mentale grave.
Per essi, dall’Età Classica, così come ci è stato dottamente insegnato da Michel Foucault, sembrerebbe che il destino sia lo stesso: segregazione. Sembrerebbe che le comunità di riabilitazione psichiatrica altro non siano che manicomi, magari in miniatura, per la cui chiusura Franco Basaglia ed i suoi collaboratori hanno dedicato la vita professionale e non solo. Sforzo, scientifico e politico, che nel corso degli anni purtroppo è stato vanificato da scelte sempre più «aziendali» che la sanità pubblica ha messo in atto tradendo, se non bastasse, non solo la legge 180/78, nota come «legge Basaglia», ma anche lo spirito della riforma sanitaria, anch’essa del 1978.
Molto frequentemente la spesa relativa ai pazienti psichiatrici ricoverati nelle comunità riabilitative è stata sostenuta senza la doverosa convinzione che il recupero di queste persone, poiché di persone e cittadini si tratta, richiede interventi specifici e specialistici ma anche azioni sociali e culturali sul territorio. Pertanto, non solo psicofarmaci che frequentemente hanno finalità esclusivamente sedative.
Tradita la legge Basaglia, si è realizzato un confino di queste persone, di questi cittadini, in strutture molto spesso chiuse in se stesse, autoreferenziali; piccoli universi anche virtuosi, ovviamente non ve ne sono solo di malsane, che nella maggior parte dei casi, però, non riescono a dialogare con i territori e con questo paradossalmente favoriscono, senza rendersene conto, un segregante processo di esclusione dal contesto sociale e dalla possibilità di fare esercizio di cittadinanza attiva, cioè di inclusione.
Alla base delle esperienze comunitarie problematiche, non necessariamente caratterizzate da violenza o perversione, ci sono diversi elementi tra i quali, qui si evidenzia, quello della formazione degli operatori che spesso è generale e non focalizzata sulla mente e sul suo mal/funzionamento; quello della supervisione clinica degli operatori la quale avrebbe anche funzione di sostegno a persone che quotidianamente impattano il disagio con quanto ne deriva sotto il profilo dell’affaticamento mentale; quello del supporto psicologico ai parenti più prossimi dei pazienti.
Non si tratta, per concludere, di suggerire una ricetta risolutiva poiché, di fatto, nessuno ce l’ha in tasca in quanto la tematica/problematica del disagio mentale grave è complessa e coinvolge più livelli: da quello biologico a quello più puramente mentale.
Si tratterebbe, pertanto, di intendere la comunità riabilitativa non come luogo di ricovero residenziale bensì come luogo veramente aperto al territorio che partecipi, grazie ad un opportuno processo di in/formazione, alla cura ed al reinserimento di queste persone sofferenti – poiché di sofferenza stiamo parlando – aiutandole a sviluppare le loro potenzialità in ambito culturale, creativo e lavorativo. Con altre parole: si tratterebbe di cominciare a considerare chi vive un disagio mentale grave come un cittadino avente diritti nella cui mente possono essere rintracciate risorse emotive alle quali agganciarsi per un possibile recupero, a condizione che tali risorse non siano spente dai farmaci e da una dinamica difensiva, da parte dei cosiddetti sani, tesa ad imbarcare sulla «nave dei folli» coloro che ci ricordano la caducità del nostro presunto equilibrio mentale.