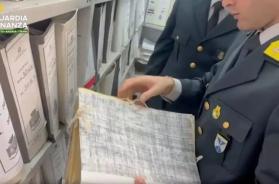«Le accuse che coinvolgono il Parlamento europeo», dichiara Roberta Metsola, «sono un colpo alla democrazia e a tutto ciò su cui abbiamo lavorato per molti anni. Ci vogliono anni per costruire la fiducia, ma solo un momento per abbatterla». La presidente dell’Europarlamento rappresenta in questi terribili giorni l’ala oltranzista, alla quale, mentre cresce lo sgomento per il Qatergate scoperchiato, spetta il compito più duro e deciso: «Non ci sarà impunità, non ci sarà da nascondere sotto il tappeto, non ci sarà da fare come al solito…».
Una scelta decisa che si muove tra due poli: la «giustizia retributiva», assai sentita e condivisa, come può esserlo ogni reazione di un corpo sano rispetto a una cancrena, con l'intento che la pena-punizione per il crimine appaia proporzionata al reato-crimine commesso; e una «giustizia riparativa», dove invece si considera maggiormente l'obbligo, per l'autore del reato, di accedere a una rieducazione e di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta.
Non crediamo però che i sentimenti e le riflessioni dell’opinione pubblica possano soffermarsi su tali questioni, che toccano la natura stessa e gli strumenti della giustizia. Di sicuro spetta ai corpi sani delle istituzioni reagire con prontezza e fermezza per una vicenda che dischiude scenari in apparenza poco verosimili, in realtà più articolati e ricchi di particolari di quanto ci immaginavamo, man mano che avanzano le indagini. Di sicuro, poi, conviene chiederci, imbracciando il buon senso di ogni cittadino, se esistono percorsi e metodi e riforme per sconfiggere un antico male, la corruzione, che non risparmia cultura o paese. Il nostro, per esempio, è in buona compagnia di altre nazioni della più solida tradizione democratica.
Facciamo due verifiche, una di ordine storico, l’altra più di indagine sociologica.
Con la prima ripercorriamo a ritroso la nostra storia per capire come le vicende pubbliche e private siano state infangate e corrose da grandi scandali legati al fenomeno corruttivo, uno per tutti, e il più eclatante, la stagione di Mani pulite.
Con la seconda proviamo a misurare la corruzione a scala mondiale, scorrendo la classifica del cosiddetto CPI, Indice di percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica. Dal CPI, assegnando punti che vanno da 0, per i Paesi più corrotti, a 100 per quelli meno corrotti, si può capire quali siano i campioni del fenomeno corruttivo. La media, aggiornata al 2022, staziona da un decennio intorno ai 42-43 su 100. Ma… udite udite, l’Italia è il fanalino di coda dell’Europa occidentale, pur avendo di recente guadagnato 3 punti: siamo al 42esimo posto nella classifica mondiale con 56 punti.
Mettendo da parte falsi moralismi, dobbiamo quindi prendere atto che quello di corrompere (e di farsi corrompere) è… l’altro più antico mestiere del mondo, così come che gli sforzi di ordine strutturale-normativo ma anche comportamentale probabilmente sono destinati a fallire. Pur senza voler, con questo, sbarrare la strada alla giustizia.
Allora, più che di una giustizia retributiva e/o riparativa, abbiamo bisogno di una giustizia… rifondativa, cioè di una rivoluzione del sistema di formazione che restituisca agli individui, alle cose e ai principi il loro valore reale, per distinguere il legale dall’illegale, il lecito dall’illecito, per definire il senso di una norma ma anche del merito e della dignità della persona.
Pensiamo che bisogna voltar pagina rispetto alla società dell’indifferenza, dove neanche l’indignazione riesce più a far leva su una tragica storia che né il 68 né Tangentopoli né la lunga catena di misteri sono riusciti a cambiare.
Pensiamo che bisogna scuotere le coscienze, a partire da quelle dei giovani, nelle case, nelle scuole, nei luoghi dove si struttura l’educazione come emulazione degli uomini onesti e viaggio nel firmamento dei principi.