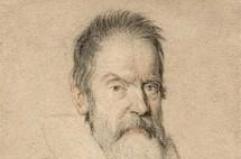Fu l’ultima volta, nel 2014, che Nicola Saponaro (1935/2015) comparve in pubblico, prima della sua scomparsa l’ anno dopo: da un palco del Petruzzelli rispose al saluto e all’applauso degli spettatori dopo la messinscena de La Bottega dei sogni, una sua commedia, già presentata nel 1995 prima a Trani poi a Bari (nel Kursaal Santalucia) con la regia di Armando Pugliese, ma che in quel 2014 si dette al Petruzzelli in veste operistica, con musica di Angelo Inglese, cantanti e orchestra. Singolare vicenda, quella di Saponaro, intellettuale del Sud ma non ”sudista”, commediografo anzi dramaturg del tutto intriso di quella “polvere di palcoscenico” che lo vide sempre cimentarsi con le dinamiche della messinscena, con registi, con attori in carne ed ossa, nei numerosi allestimenti di suoi testi, a Bari, in Puglia, nel vasto parterre nazionale. Quella commedia, per dire, quella Bottega dei sogni da cui ho iniziato questa riflessione, curiosamente rimanda a legami atavici del Saponaro col teatro e i suoi “sogni”: vi si tratta infatti delle origini del Teatro Petruzzelli, in quella bottega di stoffe dei Fratelli Petruzzelli che è all’ origine del Politeama barese, fra ’800 e ’900. Ebbene il caso (?) vuole che anche i Saponaro, la famiglia del Nostro, fossero dai primi del 900 commercianti di stoffe, con magazzino nella stessa Via Melo dei Petruzzelli, in concorrenza con gli stessi! Ma il nostro Nicola non molto si occupò dell’ azienda di famiglia: dopo laurea in economia fu rapito dal teatro, che non lo rilasciò mai più. Apprendistato nel Cut (Centro Universitario Teatrale) degli anni ‘60 e 70, poi la feconda attività di scrittura, i premi (Marzotto ‘63, U. Betti ‘65, Riccione ‘69, poi Daunia ‘80, Magna Grecia ‘96) le messinscene numerose.
Nella vicenda di “Saponaro meridionalista” non si può non citare quel Giorni di lotta con Di Vittorio che nel ‘72 fu allestito dal Teatro Stabile di Bolzano (!) con regia di Maurizio Scaparro e con Pino Micol protagonista: girò in tutta Italia (fu anche a Cerignola naturalmente) con recite addirittura nelle fabbriche, nelle mense e negli spazi “alternativi” (allora si usava!). Anche notevole fu un Fuori i Borboni! del ‘75, scritto con Alessandro Giupponi, che rifletteva sulle vicende del Risorgimento nel Sud, Brigantaggio annesso. Anche di sud trattò Saponaro in Rocco Scotellaro, vita scandalosa del giovane poeta del ‘76, con Bruno Cirino, e poi in L’alba è nuova del ‘77: le lotte del sindaco-poeta Scotellaro e la Resistenza a Matera nel ‘43 erano l’argomento. La mafia non esiste fu poi il testo di Saponaro, del 1983, che creò sensazione: non solo per il titolo provocatorio ma più per la tecnica di messinscena (regia di Augusto Zucchi) e per l’argomento: l’uccisione del sindacalista Placido Rizzotto e le indagini dell’allora capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Debutto a Roma e repliche un po’ dappertutto, come era accaduto del resto per il Di Vittorio, per Fuori i Borboni, per lo Scotellaro, per numerosi altri lavori di Saponaro in quegli anni. Sempre notevole, lo si evince dalle differenze spesso rimarchevoli fra i testi originali e i copioni di scena, è la capacità di Saponaro nell’adeguarsi alle necessità di registi e attori, alle regole e ai ritmi del palcoscenico, rispetto al rigore della scrittura “pura”. In questo si rivela in effetti “poeta di compagnia”, come intitola Franco Perrelli il volume (appunto Un poeta di compagnia) pubblicato da Schena nel 1998. Sempre Perrelli ha curato un’edizione Opere (ed. Spirali, 2008), mentre Daniele Maria Pegorari ha pubblicato un Nuove Opere nel 2013.
Degli innumerevoli contesti “meridionali” nei testi di Saponaro citazioni meritano, oltre quelli indicati, lavori quali Bianca Lancia (1986) con un Medioevo federiciano in Puglia, o un Osso Sacro su S. Nicola (nell ‘87 in collaborazione con l’ Anonima G.R. e con la regia di Nanni Loy) cui seguì una Rapsodia Nicolaiana nel ‘93, un Maggio Napoletano nel ‘99,etc. etc. Ultimo suo impegno portato in scena fu, nel 2011, 150° dall’Unità d’Italia, un Dietro le quinte del Risorgimento, con un Pio IX malmostoso e acciaccato, dopo Porta Pia.
Non fu mai proclive al vernacolo e alle sue lusinghe, ma ricordo un’ eccezione: nel 1977 scrisse un Don Juan in barese, che andò felicemente in scena al Purgatorio, sulle orme di Tirso de Molina, Molière, Mozart e Da Ponte, con regia di Michele Mirabella. Don Giovanni/Juan era Gianni Ciardo, Sganarello Nicola Pignataro, Donna Anna Carmela Vincenti. Che poi, non si vive di solo impegno!