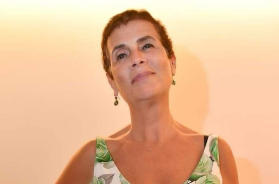In questa estate torrida, con un caldo sempre più insopportabile, se ne stanno andando in silenzio, uno dopo l’altro, gli anziani nati negli anni Trenta e Quaranta. Passano a miglior vita senza clamore, senza onori, spesso senza nemmeno la consapevolezza collettiva di ciò che rappresentano.
Sono i «bambini della guerra», quelli che udirono i bombardamenti dell’ultima guerra mondiale. Bambini costretti a crescere in fretta tra le macerie, con negli occhi la paura e il boato delle bombe. Mia madre raccontava spesso di un episodio accaduto a Castellaneta nei giorni dell’armistizio del 1943. Dopo lo sbarco degli inglesi a Taranto, nell’Operazione Slapstick, le truppe britanniche avanzarono verso l’entroterra. Passarono per Massafra e Mottola, dove già incontrarono resistenza tedesca. A Castellaneta, il suo paese, durante la ritirata verso nord, un reparto tedesco decise di seminare il terrore. Aprirono il fuoco sui civili che si trovavano lungo la salita di San Martino, in attesa dell’arrivo degli Alleati. Morirono 23 persone: 22 civili e un militare italiano. Alcuni furono colpiti da mortai sparati da postazioni sopraelevate. Il funerale collettivo fu un corteo lunghissimo di cittadini affranti, costretti a seppellire in fretta i loro cari.
Questa è solo una delle tante storie che si porta addosso quella generazione. Finita la guerra, l’Italia si trovò in ginocchio, con una crisi economica profondissima, specialmente nel Mezzogiorno. Dal 1958 al 1963 più di 1,3 milioni di persone lasciarono il Sud per trasferirsi al Nord o all’estero. La Puglia fu tra le regioni più colpite: quasi 17.000 pugliesi si spostarono solo a Torino tra il 1959 e il 1962. Un vero esodo biblico. Famiglie intere caricavano su un treno o su un camion le poche cose che avevano, inseguendo la promessa di un lavoro. Le destinazioni erano sempre le stesse: Torino, Milano, Genova, il cosiddetto «triangolo industriale».
Molti trovavano impiego nell’edilizia, dove in alcune città i pugliesi arrivavano a costituire l’85% della manodopera. Le condizioni di vita erano durissime: baracche, cantine, case sovraffollate. Nacquero le famose «Coree», quartieri informali ai margini delle città industriali, simbolo di miseria ma anche di tenacia e solidarietà. E non tutti andavano al Nord. Molti partirono per l’estero. Dal Salento, intere comunità emigrarono in Belgio per lavorare in miniera. E lì, a Marcinelle nel 1956, 22 pugliesi morirono in un’unica tragedia, ricordata ogni anno con una cerimonia che forse oggi non dice nulla ai più, ma che per i nostri padri e madri era una ferita aperta.
L’Italia del dopoguerra non era per loro una promessa ma una scommessa: il domani non poteva essere peggiore di ieri. Furono loro a sostenere sulle spalle le sorti di una nazione in macerie. A ricostruire, mattone dopo mattone, città e comunità. A credere nella scuola e nel lavoro come unico riscatto possibile. A fare sacrifici veri per dare ai figli un futuro che fosse davvero migliore. Fu grazie a quella generazione che si realizzarono riforme fondamentali: la riforma agraria che rese coltivabili terre incolte; l’industrializzazione che sorse in mezzo agli ulivi e trasformò il volto del Meridione. Furono loro a stringere la cinghia mentre l’Italia cresceva a ritmi vertiginosi, il famoso «boom economico» di cui oggi si parla come di un miracolo ma che fu, in realtà, sudore, emigrazione e rinunce.
Sono i padri e le madri che hanno visto, un po’ sgomenti e increduli, il Sessantotto con le sue rivendicazioni e le sue sfide all’autorità. Che hanno allevato figli tra la tradizione e la fede, con un senso profondo del dovere e della famiglia.
E poi hanno subito l’onta del crollo della Prima Repubblica, le promesse mancate della Seconda, l’inaridirsi della politica. Hanno visto i partiti dissolversi in personalismi, gli ideali perdere senso, la partecipazione ridursi a risse televisive.
A questi padri e a queste madri nessuno dedica nulla. Né una via, né un monumento. Io avrei voluto tanto che nella mia città sorgesse un monumento alla civiltà contadina, per ricordare chi ha reso fertile una terra arida non solo con il sudore ma con la speranza. E invece di loro restano le lapidi nei cimiteri: «Nato nel 1940, morto nel 2025». E basta.
In una società che corre senza guardarsi indietro, immersa negli schermi di uno smartphone, la vita scorre come in un videogioco, obliterando la storia dei padri e delle madri, ridicolizzandoli perfino con l’appellativo sprezzante di «boomer». Ma se oggi abbiamo diritti, strade asfaltate, ospedali, scuole e un’idea stessa di dignità del lavoro, è perché loro non si sono arresi quando tutto sembrava perduto. Perché hanno saputo sognare un futuro che non avrebbero neanche goduto in prima persona. Forse dovremmo fermarci, almeno un attimo, a dirgli grazie.