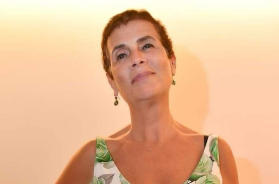Assodato che i bombardamenti statunitensi sull’Iran abbiano prodotto l’effetto voluto, cioè la distruzione o il danneggiamento dei siti nucleari, rassicurazioni che, peraltro, ci derivano da chi tali azioni di guerra le ha iniziate e portate a termine, sembrerebbe che le guerre in corso siano d’un tratto cessate, o comunque si sia raggiunta una tregua, una tregua che lascia intravedere il tempo trascorrere come fosse risolta ogni problematica che aveva sino a pochi giorni fa accesi i dibattiti e rinfocolate le ambizioni storiche e territoriali. E invece in pochi giorni una amnesia collettiva riprende il suo ruolo da protagonista delle vicende politiche europee, e non solo, lasciando che il tempo non sia più in movimento, che la barca non veda più gonfiarsi le sue vele, rimanendo in uno stato di bonaccia.
Risultato della tregua? Di quale genere? Probabilmente si tratta di una cessazione provvisoria dei conflitti: la questione Ucraina è stata derubricata a regolamento dei conti regionale, o a vicende interne; in cambio si è ottenuta l’invasione dello spazio aereo iraniano, il bombardamento del suo territorio come fosse una terra nullius, per non parlare dell’avanzante incenerimento (definitivo), umano e strutturale, di Gaza. Ma in tale ultimo aspetto c’è da sottolineare che grave responsabilità è da addossare a Hamas e ad alcuni Paesi arabi, non intervenuti a sostegno dei Palestinesi, considerati inaccettabili dall’Egitto, non graditi in Libano o Giordania, con la conclusione che un popolo che rimane senza territorio, si trasforma in una massa di apolidi, proprio come lo erano coloro che cercavano una terra, poi nel 1948 divenuta immediatamente Israele, luogo di destinazione per tutti gli ebrei rimasti in Europa dopo lo spaventoso eccidio nazista: la shoah (da rivedere il film Exodus del 1960 che delineava chiari anche i crimini britannici).
Attualmente il problema si ripropone nei confronti di altre famiglie, uomini, donne, bambini, molti più orfani che non possono dirigersi verso una casa, verso un luogo, una terra che diventi un territorio, cioè uno dei tre elementi costitutivi di uno Stato. Gli altri due sarebbero popolo e sovranità. E il popolo ci sarebbe anche, ma senza un riconoscimento di coloro che patteggiano tregue per dare fiato alle truppe o rimpinguare gli arsenali al momento svuotati, non c’è uno Stato e, di conseguenza, neppure il riconoscimento di quegli orfani, delle vedove, delle famiglie senza terra e senza più risorse, che si chiamano Palestinesi: nella storia, tuttavia, ci si disperde come in una vita di vicoli ciechi, in cui si ritorna indietro, si ricomincia il cammino e ci si sbaglia nuovamente.
Il presente non è più frutto del passato, diviene piuttosto specchiarsi nel futuro, proprio in quanto abbiamo da sempre scongiurato (la guerra) e in un certo modo assicurato che non si sarebbe più verificato, lasciato a spiegazzarsi nei lembi del presente come un’eventualità lontana. Eppure la cessazione di ogni ostilità, cessazione che invece ha ricominciato a circondarci, in un continuo rischio di interrompersi dando avvio a una loro ripresa, magari in un ennesimo luogo di scontro, stringendoci nuovamente, lasciandoci increduli, timorosi sull’avvertire concreto quanto ritenuto con una certa enfasi mai più avverabile, ci rende scettici rispetto alle ultime solenni dichiarazioni, che riguarderebbero unicamente una interruzione dei conflitti, ma non ancora delle intese effettive di pace fra le nazioni.
Organizzazioni internazionali, comunità di Stati, intese politiche e trattati di pace interni ai continenti, processo di decolonizzazione hanno largamente assicurato che epoche ed età, riferibili alla storia recente o ancor più indietro nel tempo, non dovessero più ricominciare nelle loro tipiche forme: piccole scaramucce territoriali, conflitti man mano più estesi, infine guerre e quanto il filosofo inglese Thomas Hobbes nel XVII secolo aveva già stigmatizzato essere il bellum omnium contra omnes: la guerra totalizzante, quella che attualmente, in una sorta di periodizzazione della storia, si può definire come balcanizzazione delle sorti, quando non si riesce più a risalire ad un artefice scatenante il conflitto, ma ci appaiono i vari eserciti, insieme a milizie, truppe speciali, mercenari, impegnati in un indefinibile conflitto, nebuloso ed arcano nel suo dilagare su altri territori, incerto nelle cause, approssimabili e ugualmente inoppugnabili, affatto stigmatizzabili territorialmente: ogni territorio ne viene coinvolto, come se infine ogni parte in lotta sia al tempo stesso aggressore e vittima.
Potremmo forse mai chiarire la «giustificabilità» della guerra? Potremo comprenderne la «plausibilità» rispetto a quanto sta avvenendo fra Ucraina e Russia? O fra Israele e quel che resta della striscia di Gaza? O fra Israele e quanto avvenuto in questi giorni in Iran? La comprensione deriva soltanto accettando l’attivazione di un meccanismo di pace, come fosse una rinnovata intimidazione nei confronti di chi osa attrezzarsi di strutture, apparentemente per uso civile, e che viene invece «scoperto» a farne uso militare, e così via: tale condizione riduce la pace ad uno slogan politico di chi è pronto a ritenere «necessari» i bombardamenti.
L’epoca di pace, pertanto, sopravvivrà in una euforica condizione di guerra; paradosso analogo a quei governi che tutelano l’esercizio delle libertà fondamentali e dei diritti individuali, però interrompendoli per un pericolo sempre presente, eppure indefinibile, ineffabile, che metterebbe a rischio diritti e libertà, che quindi è meglio rinviare a tempi migliori. E la tregua non fa altro che dilazionare a tempi lontani la pace, tempi che saranno ritenuti «migliori» ma chissà irraggiungibili, proprio da chi vede nella guerra l’efficacia volta a garantire una tregua.