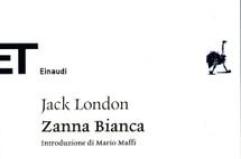«Io le ali non ho, non le ho. Però proverò, cercherò, volerò... come Icaro...», cantavano i Nomadi nel 1973, ispirandosi nel brano Icaro al celebre mito greco, simbolo del desiderio umano di superare i propri limiti, e della conseguente caduta dovuta all’eccessiva ambizione. I Nomadi accentuano in quel brano l’aspetto onirico e poetico della figura mitologica, ma è inevitabile che la musica di ogni genere ed epoca abbia spesso attinto a una metafora potente e simbolo di ambizione, caduta e libertà.
Nel genere colto, soprattutto in ambito contemporaneo, uno degli esempi più noti è Icarus di Peter Maxwell Davies (1934-2016), opera orchestrale che evoca il volo e la tragica caduta attraverso un linguaggio musicale espressionista. Anche Philip Glass, con il suo stile minimalista, ha reso omaggio al mito nel brano Icarus at the Edge of Time, composizione ispirata a una versione futuristica della leggenda, in cui il volo diventa una metafora della scoperta scientifica. Non da meno è stato John Tavener (1944-2013) nel lavoro Icarus, che con un linguaggio spirituale e ascetico cattura la tensione tra elevazione e discesa.
Nel repertorio sinfonico, Icare di Charles Koechlin (1867-1950) è un esempio straordinario di impressionismo musicale, con orchestrazioni delicate che rievocano l’ascesa e il crollo del giovane. Anche il compositore greco Iannis Xenakis (1922-2001), nel brano Ikaro, ha tratto ispirazione dal mito, sfruttando ritmi irregolari e sonorità sperimentali, per rappresentare l’audacia e la rovinosa fine di Icaro. Tra i contemporanei va citata anche la compositrice finlandese Kaija Saariaho (1952-2023), che ha ripreso la figura nella sua opera L’Aile du songe, esplorandone il lato psicologico e simbolico, con sonorità astratte e suggestive. Nell’opera lirica il compositore inglese Jonathan Dove ha ripreso il tema in Flight (1998), in cui un protagonista che cerca la libertà in un aeroporto moderno richiama la figura di Icaro e il suo desiderio di volare. Un altro esempio significativo, restando sempre in Gran Bretagna, è The Minotaur di Harrison Birtwistle (1934-2022), in cui il mito di Dedalo e Icaro viene rielaborato in un contesto drammatico, con sonorità potenti e inquietanti.
E Pop, rock e jazz? Non potevano certo esimersi dal suonare e “cantare” nel nome di Icaro. Il chitarrista statunitense Ralph Towner, oscillando tra jazz e folk rock, ha scritto un brano molto apprezzato come Icarus, caratterizzato da melodie aeree e un senso di malinconia che richiama la caduta dell’eroe mitologico. Al rock progressive appartiene invece Icarus - Borne on Wings of Steel dei Kansas, in un testo che si fonde con l’epica strumentale. Anche i Bastille, in Icarus, utilizzano il mito come metafora dell’eccesso e dell’illusione, mentre sul fronte heavy metal gli Iron Maiden richiamano il mito nel brano Flight of Icarus.
Il cantautorato italiano merita un capitolo a parte. Già i Nomadi, nel brano citato, riflettono sulla tensione tra l’aspirazione alla libertà e i pericoli dell’imprudenza. Attraverso la figura di Icaro, esplorano temi come la ribellione, la ricerca di sé e le conseguenze delle proprie scelte. Renato Zero ha addirittura intitolato Icaro, nel 1981, un fortunato doppio disco live, mentre l’anno prima aveva scritto Metti le ali, immaginario riferimento a Icaro che invita a superare le difficoltà della vita, liberandosi dai propri limiti.
Allo stesso tema si rivolgono anche i Gemelli Diversi in Icaro, mentre sono recentissimi i brani di Irama (Icaro, 2019) e Mahmood (Icaro è libero, 2021). Nel primo Irama, con Mr. Rain, utilizza la figura simbolica per descrivere una relazione intensa e travolgente: la persona amata è paragonata al sole, un fuoco che brucia vivo, evocando l’idea di un’attrazione potente ma potenzialmente pericolosa. Mahmood trae invece ispirazione dal mito di Icaro per esplorare temi come libertà e oppressione. Il cantautore paragona Icaro a un carcerato, entrambi desiderosi di superare i propri limiti e sfuggire alle costrizioni imposte dalla società. E la “prigione” rappresenta metaforicamente le pressioni sociali che cercano di tarpare le ali dell’individuo.
GUIDA ALL’ASCOLTO (Nicola Morisco)
John Lee Hooker
The Standard School
Broadcast Recordings
Da due giorni è disponibile una registrazione in studio rara del grande bluesman John Lee Hooker che, fino a poco tempo fa, si pensava perduta: “The Standard School Broadcast Recordings”. Si tratta della prima pubblicazione commerciale di una rara registrazione di una band blues completamente elettrica risalente al 1973. Eseguita direttamente su nastro al Coast Recorders di San Francisco, la session cattura Hooker in un momento tumultuoso e ricco di cambiamenti della sua carriera, Nella registrazione il bluesman è accompagnato dalla sua sezione ritmica di riserva composta da Gino Skaggs (basso), Ken Swank (batteria) e dal figlio Robert Hooker (pianoforte). La Standard School Broadcast, iniziata nel 1928, era una serie radiofonica educativa pluripremiata sponsorizzata dalla Standard Oil (alias Esso, in seguito Exxon). Con sede a San Francisco, le collezioni sono specializzate nell’apprezzamento della musica e della storia americana.
Gabríel Ólafs
Polar
Fresco di stampa anche l’album “Polar” del 26enne islandese Gabríel Ólafs. Pianista, compositore, produttore e cofondatore della Reykjavík Orkestra, la sua formazione abbraccia sia la musica classica, che il jazz. Ólafs si è distinto a livello internazionale per le sue composizioni di musica strumentale per pianoforte, archi, coro ed elettronica con influenze classiche e della tradizione del suo paese, che proiettano in un mondo dominato dalla fantasia e dalla natura. Con oltre 1,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è una delle nuove star dell’area neoclassica. Il nuovo album “Polar” è un’opera di narrativa speculativa in forma musicale. “Polar” è la giusta colonna sonora di un mondo ghiacciato. Un mondo di imponenti catene montuose, tundra desolata, oceani ostili e resti monolitici di una civiltà perduta raccontato in musica con un linguaggio epico e moderno al tempo stesso.