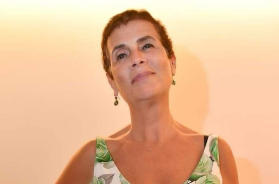Tempi sempre più duri per i governanti e i loro elettori… L’«estività» che stiamo vivendo, quello stato fluido di passaggio dalle stagioni solide e piene di una volta ai tempi incerti ed evanescenti dell’oggi, è popolata di un interrogativo diffuso: gli uomini che ci governano dovrebbero essere, per tutti noi, portatori, se non di benessere, almeno di un pizzico di felicità? Dovrebbero migliorare la nostra condizione?
Genera questi e altri dubbi il riproporsi di scenari in cui pullulano classi dirigenti ed élite costrette a contenere il dissenso e il malcontento, quindi a investire più nell’emergenza e nella ricerca del consenso che nella progettazione di un futuro rasserenante.
Le opzioni che si fronteggiano, nel concepire e ordinare il mondo, sono dunque, sugli opposti fronti, emergenza e consenso versus ricostruzione e previsione?
La verità è che ogni generazione, quale che sia il suo ruolo preminente, deve interrogarsi sulle sconfitte e vittorie, sui suoi reduci, sugli sconfitti che non possono scrivere la storia, sulle eredità che riceve dal passato e su quelle che, invece, affida ai posteri.
Reduci e reducismo sono generati da eventi epocali, come lo furono la prima e poi la seconda guerra mondiale, al pari di altre stagioni più vicine al nostro sentire, il Sessantotto e, ancora, gli anni di piombo, ma anche, per guardare in casa altrui, il Vietnam.
Reduci e reducismo ingrossano i ceti sociali dello scontento, insufflano in loro profonda e sottile insoddisfazione per quanto la storia ha riservato, quindi determinando, prima o poi, aperti fenomeni di rivalsa e ribellione.
Anche quelle che stiamo vivendo negli ultimi anni sono stagioni che lasciano l’amaro in bocca dei reduci: siamo coloro che sopravvivono alla pandemia e alla guerra del condominio accanto, che attraversano la mutazione della crisi climatica e del dissesto idrogeologico. I fenomeni sono ancora in atto e potrebbero riservare sorprese. I cui effetti e incidenza nella storia futura non conosciamo e non abbiamo sperimentato ancora sino in fondo.
Come usciamo da queste patologie, che attaccano le società nel corpo ma anche nella tenuta psicologica? I fenomeni ci raccontano di ferite gravi, di malessere sottile, ma le cicatrici stentano a rimarginare e in genere non lasciano trasparire quanto profondo sia il danno subìto. Anzi, man mano che i colpi della sorte, uno sull’altro, si accaniscono insieme al caso e si fanno gioco della imprevidenza, lasciano sguarnita e perplessa la razionalità operosa.
Il ventaglio di risposte e la scelta delle opzioni devono essere chiari, quindi, a quanti hanno in mano le sorti delle società, dagli educatori che forgiano i futuri cittadini alle classi dirigenti che governano le economie, gli Stati.
Ma assai spesso tuttavia del tutto estemporaneo è l'armamentario e l'assetto ideativo delle risposte. Dobbiamo uscire dallo stato di lutto e di riparazione prevalenti, della ricerca di un consenso a ogni costo, per costruire e offrire invece, da un lato, una filosofia della crisi all’altezza delle sfide repentine e variabili che la storia pone e, dall’altro, modelli di prevenzione e di ricostruzione ad ampio spettro.
Servono uomini visionari, grandi e coraggiosi costruttori che, immaginando e studiando, prevengano e governino emergenze e imprevedibilità.
Un progetto di futuro che non sia solo riparativo bensì creativo.