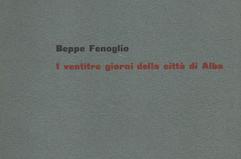Il 25 marzo per i greci è tutto: è data di grande valenza civile e religiosa. È data fortemente identitaria. La festività, che si celebra il 25 marzo, commemora l'inizio della guerra per l'indipendenza dagli ottomani, avvenuta a Patrasso il 25 marzo 1821 e proprio il 25 marzo scorso si è appreso dai media che quel giorno «sono stati presentati nel museo dell’Acropoli di Atene i frammenti del Partenone restituiti dal Vaticano». A parlarne per primi i giornali inglesi, fra i quali il Guardian.
Il foglio londinese riportava le dichiarazioni dell’arcivescovo ortodosso di Atene e di tutta la Grecia, Geronimo II, il quale aveva sottolineato come il gesto di papa Francesco avesse «un significato storico, e ha un impatto positivo a più livelli» ed aveva auspicato che «altri seguiranno l’esempio». Papa Francesco, del resto, aveva annunciato la restituzione dei frammenti del Partenone a metà dicembre dello scorso anno ed il 7 marzo di quest’anno, invece, era stato il portavoce vaticano e riferire che quella mattina sarebbe stato sottoscritto «un accordo, per l’attuazione della donazione del Papa, alla presenza del cardinale Fernando Vergez Alzaga, dello Stato della Città del Vaticano, di un rappresentante dell’arcivescovo di Atene, del ministro greco della Cultura e dello Sport, e di Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani». «Questa donazione è un gesto di pace in questo momento storico così segnato dalle guerre», disse in quell’occasione il card. Fernando Vérgez Alzaga, un gesto che «vuole gettare ponti di fraternità e manifestare al mondo che esiste sempre e comunque una via per il dialogo e la pacificazione. Come auspichiamo possa avvenire nel conflitto in corso in Ucraina».
Il porporato, tuttavia, andò oltre con queste parole: «Il valore più importante di questo atto – disse Vergez ricordando che i Musei detenevano i frammenti del Partenone “a seguito di regolari acquisti” – è, ancora una volta il constatare come le collezioni d’arte del Romano Pontefice diventino un punto privilegiato di amicizia tra i popoli, le genti, le fedi, le Chiese, superando ogni barriera». «Sua Santità il Papa di Roma ha dimostrato che ciò è possibile e realistico», chiosò Papamikroulis Emmanouil, in rappresentanza di Geronimo II.
L’intera vicenda del Partenone suscita un turbinio di pensieri nel Topo a partire dal riferimento alla pace ed all’attuale tempo presente «così segnato dalle guerre»: anzi segnato dalla «terza guerra mondiale a pezzetti», come ha detto il Pontefice e, non appena si fruga su una bancarella di libri ed altre carte, cosa appaiono infatti – o meglio – cosa cercano i collezionisti di foto? Cercano foto di guerra, genere assai ricercato a partire da ciò che immortalò Roger Fenton in Crimea. Ma sono pure oggetto di ricerca quelle dei giorni di fine aprile 1941, quando la Grecia fu invasa dalle truppe italiane e da quelle tedesche e ci sono fior di fotografie, che ritraggono militari italiani e tedeschi con sullo sfondo il Partenone: sono fotografie che negli archivi dei giornali ci sono, come pure sono custodite nelle collezioni private. Ma a cercare in vecchi album, talvolta proposti da librerie antiquarie quando acquistano in blocco un archivio-biblioteca, si trovano magari pezzi meno rari, soggetti meno fotogenici e con meno Storia (con la s maiuscola) raccontata, ma si trova vita reale ed affetti di famiglia ed amicali, che altrove non si riscontrano.
Sulle bancarelle e nei cataloghi, ancora, trovi qualcosa sul Partenone in libri che non ti aspetti: il mito della contesa di Athena con Posidone per il dominio dell'Acropoli – ad esempio -, «contesa che si risolse con un miracolo compiuto da ciascuna delle due divinità: sull'arida roccia dell'Acropoli Athena fece nascere improvviso l'olivo, Posidone con un colpo di tridente fece scaturire una polla di acqua salata», la si trova in buoni trattati di mitologia greca e di studi sui miti delle civiltà classiche, la maggior parte dei quali scritti in tedesco e portati a conoscenza di un pubblico più vasto, in italiano, quando Alessandro Della Seta, curò la voce Acropoli per l’Enciclopedia italiana. Si era nel 1929 e fu anche allora che l’autore spiegò come «i lavori iniziati nel 447 erano essenzialmente finiti nel 438 a. C. quando vi fu collocata la grande statua in oro ed avorio di Athena Parthenos, opera di Fidia» e come «ricchissima era la decorazione scultoria del Partenone. Ad altorilievo erano ornate le 92 metope della trabeazione, e i loro soggetti erano ad E. la Gigantomachia, ad O. l'Amazonomachia, a N. e a S. la Centauromachia, insieme con scene di miti ateniesi ed episodî della presa di Troia». E quella narrazione ti porta praticamente al punto di partenza: a quei frammenti del Partenone consegnati ad Atene o ancora contesi fra la Grecia e i musei più importanti al mondo che ora li custodiscono.
L’archeologo Edoardo Brizio, scrisse sì, nel 1880 un bel saggio sulla Nuova Antologia del Protonotari, ma giusto per confermare quanto si va dicendo: «Da quasi tre secoli il Partenone è fatto argomento di ricerche e di studii per parte degli artisti, degli architetti e degli archeologi. I primi lavori serii però datano soltanto dalla metà del secolo passato. Fino allora quel monumento era visitato dai viaggiatori come un oggetto meraviglioso di curiosità». È da credere, dunque, che anche per il Partenone valga l’opinione comune tra giornalisti, secondo la quale vale più una foto (nemmeno bella) di una pagina ben scritta. Ed allora giova forse cercare immagini di questo splendido sul mercato antiquario.
L’Ottocento è stato prodigo di immagini incise, pubblicate sui giornali popolari, a corredo di un bozzetto o di un reportage: il titolo, l’immagine e poi le due colonne di testo. Il tutto impaginato in maniera tale che il lettore, sollevando gli occhi dallo scritto, continuasse ad andare con la mente, aiutato dalla contemplazione dell’immagine. E se il tipografo-editore, poi, era a corto di argomenti o deve solo quadrare tipograficamente il numero da mandare in stampa, ecco che il cliché veniva riproposto o in apertura di numero o a conclusione dello stesso.
Ed ecco spiegato il perché una veduta del Partenone, ritagliata da uno di quei numeri di rivista ottocentesche e collocata entro un passe-partout viene proposta a poche decine di euro.
Diverso discorso va fatto, invece, per le stampe che attirano anche l’attenzione dei meno adusi a trattare di queste bellezze. La davvero superba incisione dell’Antica e moderna città di Atene dedicata dal P. Coronelli all’illustriss(imo) et eccellentiss(imo) Sig. Cristino Martinelli Patrizio Veneto, corredata sulla cornice da un’altrettanto accurata legenda (610 x 455 mm), la si trova sul mercato antiquario del libro e delle carte a non meno di 800 euro. E li vale tutti, questa incisione tardosecentesca (1690 ca) originata dagli studi di quel religioso geografo.
Come pure singolare è un Prospetto del Castello e città di Atene di anonimo incisore che passa per le librerie in questi frangenti, mentre giova ricordare che i lettori tedeschi dell’Ottocento contemplarono il Partenone grazie ad una ben realizzata incisione che lo ritrae in prospettiva: la pubblicò l’enciclopedia tedesca Pierers Konversationslexikon nel 1891. Forse quell’enciclopedia è tra le più… ritagliate ai giorni nostri perché vi è abbondanza di quell’immagine, si riesce ad acquistarla a prezzi accessibili.
Ma il Topo no: rintanato nel suo noto cliché (è proprio il caso di dirlo) di bibliofilo squattrinato, dinanzi alle stampe ottocentesche che ritraggono il Partenone si è sentito come l’asino di Buridano: lasciandosi sfuggire la stampa tedesca, ha cercato rifugio nella Veduta di Atene moderna pubblicata dal Poliorama Pittoresco a Napoli nel 1844. Lì l’Acropoli e il Partenone si vedono sulla destra dell’immagine e c’è tutt’intorno una certa composta complessità che allieta l’occhio… Quando però ha telefonato al libraio per acquistarla, si è sentito rispondere: «Mi dispiace, signore: l’ho vendita due giorni fa. Sarà per la prossima volta…».