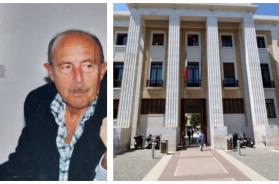Da qualche parte si annida la causa della sindrome italiana denunciata dal Censis secondo cui il 41,1% degli italiani crede erroneamente che Gabriele D’Annunzio sia l’autore de L’infinito e il 35,1% che Eugenio Montale sia stato un presidente del Consiglio dei ministri degli Anni ‘50.
Se spostiamo l’attenzione sulla competenza linguistica dell’italiano rilevata dall’indagine Ocse Pisa va anche peggio. Messi di fronte a un compito di lettura, gli adulti italiani compresi nella fascia di età fra i 16 e i 65 anni, nella ragguardevole percentuale del 35% (di gran lunga superiore alla media Ocse) ottengono un punteggio pari o inferiore al livello 1. Il che significa che sono incapaci di comprendere anche una frase breve e semplice. Sono italiani tagliati fuori dal mondo produttivo e dalla cittadinanza perché non capiscono lessico, impliciti e morfosintassi della madrelingua che parlano. Gli esiti complessivi dell’indagine sono nel Rapporto Ocse Pisa «Do adults have the skills they need to thrive in a changing world? Survey of Adult Skills 2023» la cui lettura è assai utile per farsi un’idea di ciò che andrebbe riformato nel sistema di istruzione del nostro Paese, a cominciare dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, il documento principale che orienta le scelte didattiche degli insegnanti.
Nella parte dedicata all’Italiano, le Indicazioni soffrono il peso di decenni di sfiducia nell’analisi grammaticale e logica, nell’insegnamento di regole ortografiche e sintattiche, sull’onda infausta delle Dieci tesi per un’educazione linguistica democratica di Tullio De Mauro che ancora lambisce le pratiche di insegnamento dell’italiano. Val la pena di richiamare il passaggio più duro di quelle tesi, quello sulla «nocività dell’insegnamento grammaticale tradizionale»: «Le grammatiche di tipo tradizionale sono fondate su teorie del funzionamento d’una lingua che sono antiquate e, più ancora che antiquate, largamente corrotte ed equivocate (un Aristotele assai mal capito); […] ci vorrà molto tempo prima che per l’italiano si disponga di una grammatica adeguata ai fatti; costretti a imparare paradigmi e regole grammaticali, oggi come oggi gli alunni delle nostre scuole imparano cose teoricamente sgangherate e fattualmente non adeguate o senz’altro false».
L’attacco alla pedagogia linguistica tradizionale e la svalutazione della grammatica (con conseguente nefasta riduzione degli spazi dedicati nell’insegnamento) non mi pare che abbiano sortito alcun miglioramento negli apprendimenti. Anzi, le lacune hanno largamente danneggiato la capacità di pensare e riflettere degli studenti, che riflettendo meno, comprendono meno, come attestano i dati Ocse.
Non sarebbe stato meglio tenersi la grammatica tradizionale, piuttosto che gettare l’acqua sporca col bambino? Da tempo i docenti universitari denunciano le carenze linguistiche dei loro studenti in grammatica, sintassi e lessico, insieme a difficoltà di comprensione e ad errori appena tollerabili in terza elementare. Non sono una laudator temporis acti, ma trovo quanto mai urgente ridare fiducia a grammatica e a latino, svalutati o addirittura cancellati dai curricola delle scuole con improvvida sicumera.
Non mancano approcci metodologici attraverso i quali motivare gli studenti ad apprendere tali discipline. Delle quali auspico, nel nuovo anno scolastico, un felice ritorno. Fa rumore il silenzio sull’analfabetismo di ritorno degli italiani da parte dei tanti detrattori senza giusta causa del ministro Valditara, pronti a rilevare inesistenti errori grammaticali nei suoi testi social. A questi detrattori suggerirei un veloce ripasso di grammatica: visto che i rilievi che muovono si rivelano sempre tutti sbagliati.