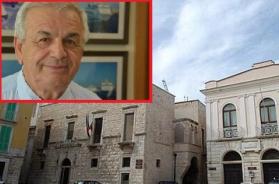Una donna che stringe tra le braccia il cadavere della nipote ha vinto il World Press Photo 2024. Non importa la nazionalità del fotoreporter di Reuters che ha scattato la foto, non importa la provenienza di chi è stato immortalato senza neanche avere un volto. È comunque una icona che fissa a futura memoria due corpi disperati, l’uno irrigidito nella morte, l’altro impietrito nel dolore, eppure in un gesto protettivo dall’eterno. Un gruppo quasi marmoreo che riecheggia le movenze della Pietà in una nuova posa.
Le due donne ci rammemorano, meglio di ogni documentario, come nei mesi trascorsi dal 7 ottobre si stia consumando l’estinzione della vita: quasi 14 mila i minori uccisi a Gaza e 113 in Cisgiordania; ad almeno mille bambini sono state amputate una o entrambe le gambe, mentre la carneficina non risparmia gli stessi ospedali, bombardati a decine.
Alle vittime di Gaza aggiungiamo quelle dell'Ucraina. Secondo l’Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, solo a marzo sono stati uccisi o feriti almeno 57 bambini, il doppio rispetto a febbraio. Alcuni milioni di piccoli sono sfollati o hanno raggiunto altre terre come rifugiati.
Ma il primato non riguarda solo i numeri, né la pervicacia della distruzione. Tocca semmai soprattutto l’essenza stessa e la definizione della fanciullezza e la sua metamorfosi. La profanazione ha snaturato la condizione di bambini. Fino ad oggi i bambini potevano essere belli o brutti, poveri o ricchi, buoni o monelli, potevano anche essere figli dell’amore, della guerra, o della strada, ma giammai «bambini di guerra».
Così come ci sono i soldati di latta o le persone di coraggio, gli uomini di cuore o di ricotta, avanza una nuova genia di infanti, muti e attoniti, invade il nostro comodo presente, si insinua nel nostro peloso pietismo: essere «bambini di guerra» è uno status esistenziale, dichiara una qualità, una provenienza, una appartenenza ma anche un destino.
Non più i bambini impastati di sangue e vita, i bambini di strada o di cortile, che siamo abituati a guardare e ad accarezzare, anche a proteggere. Quella che stiamo conoscendo, attraverso i silenzi e gli sguardi muti, è una nuova stirpe. Marchiata a vita e per la vita. A raccontare la storia della loro vera madre: la guerra.
E così i «bambini di guerra» sono entrati nelle nostre coscienze: raccogliamo per loro, al fine di tacitarle, pupazzi e bambole, giocattoli e cianfrusaglie di ogni fattezza e genere, abiti, cappelli, scarpe; in cucina e dal frigo, infine, dolci, biscotti e caramelle, cibi in scatola.
Pazientemente ramazziamo dal benessere e riponiamo in enormi bustoni. Per chi? Alla domanda, per chi stessimo raccogliendo, lapidario risuona «per i bambini di guerra».
Un neologismo che solo la fervida fantasia degli infanti può concepire. Una parola di nuovo conio, inaudita, a dispetto della guerra-spettacolo e pure della guerra-guerra.