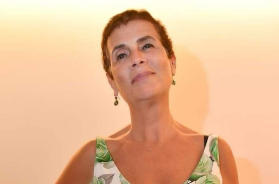L’economia europea perde posizioni nella competizione internazionale e sperimenta, al suo interno, una costante crescita delle divergenze regionali (l’impoverimento relativo del Mezzogiorno rispetto al Nord è parte di questa dinamica). A Mario Draghi, come è noto, è stato affidato il compito di redigere il rapporto sulla competitività europea, che verrà ultimato verosimilmente a giugno prossimo. Nel discorso dello scorso 15 febbraio all’Economic Policy Conference di Washington (durante il conferimento del premio Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award), che va letto insieme a quello all’Ecofin del 24 febbraio, ne ha resi noti i fondamentali ingredienti.
Partiamo dalla diagnosi. L’ex Governatore della BCE formula due critiche. La prima è rivolta al modello della globalizzazione sperimentato negli ultimi decenni, che avrebbe portato squilibri commerciali in un contesto di crescente partecipazione agli scambi commerciali internazionali di Paesi che avevano punti di partenza, in termini di livello di sviluppo, molto diversi. Draghi riconosce che le delocalizzazioni prodotte dalla globalizzazione hanno considerevolmente ridotto la quota dei salari sul Pil, creando ostilità in coloro che ne sono risultati danneggiati. Così come, contrariamente alle promesse, la globalizzazione non si è associata alla diffusione dei valori orientati al rispetto delle libertà individuali e della democrazia. La seconda critica attiene alla politica economica e da qui origina la sua proposta. Draghi osserva correttamente che l’UME ha puntato, per la sua crescita, su un modello trainato dalle esportazioni, in una condizione di competizione fra i Paesi membri, che risulta perdente nel lungo periodo. Da qui la sua prescrizione: emettere – più del poco fin qui fatto – debito pubblico europeo per finanziare, in modo cooperativo fra Paesi dell’Eurozona, investimenti pubblici finalizzati, in particolare, alla transizione ambientale e digitale. Si stima un costo complessivo di 500 miliardi l’anno, ai quali occorre aggiungere la spesa per la Difesa. Si ritiene rilevante, a tal fine, un uso più produttivo dei risparmi europei, molti dei quali congelati nei conti correnti delle banche. Nell’impostazione fatta propria da Draghi, il ruolo della Banca europea degli investimenti (BEI) potrebbe essere rilevante.
La rilevanza di queste considerazioni per il Mezzogiorno risiede innanzitutto nell’applicazione a quest’area della diagnosi di Draghi. Non vi è dubbio che il Sud è stato colpito – come molti altri Sud d’Europa (Portogallo, Spagna, Grecia e la stessa Italia nel suo complesso: quelli che gli inglesi chiamano PIGS, ovvero “porci”) e come i Sud del mondo (Africa in primis) - dalla doppia dinamica della globalizzazione e dell’affermarsi del modello export-led in Europa. Nel primo caso, è stato penalizzato dalla concorrenza esercitata dai Paesi dell’Est; nel secondo caso, l’accento posto sulle misure di austerità e su una competizione basata sulla moderazione salariale ne ha compresso la domanda interna, non compensandola con adeguati aumenti di esportazioni nette, data la scarsa propensione alle esportazioni delle sue imprese. L’interesse del discorso di Draghi sta anche nell’accento che viene posto sulla legittimazione delle Istituzioni e, dunque, sulla necessità che la politica economica europea sia sostenuta da – e produca - adeguato consenso.
La diagnosi di Draghi è utile per mettere in evidenza il fatto che un’economia di mercato genera spontaneamente effetti di polarizzazione fra centro e periferie (e, in una dinamica di doppio movimento, fra aree interne e città). Una volta, infatti, determinatasi l’aggregazione industriale in una data area, quell’area continua a crescere per effetto soprattutto dei flussi migratori che attrae dalle aree più povere e dai risparmi provenienti da queste ultime, diventando un attrattore di risorse. Si tratta di un effetto noto, nelle scienze sociali, come causazione cumulativa ed è quanto sta accadendo a danno del Mezzogiorno. È stato stimato che, fatti 100 gli investimenti fissi realizzati nel Sud Italia, solo 54 vengono soddisfatti da produzioni interne, a fronte di 38 realizzati dal Centro-Nord (o dall’estero). Per contro, 100 euro di investimenti al Nord richiedono ben 87 euro di produzione interna e una quota irrilevante di produzione intermedia dal Sud. Questa evidenza suggerisce che il Nord non è la locomotiva del Paese: l’economia meridionale non cresce, infatti, quando cresce quella del Nord del Paese.
Di per sé, un aumento della spesa pubblica in Europa (comunque auspicabile rispetto alle misure di austerità che hanno caratterizzato la Storia recente del continente) non attenua queste dinamiche, potendo esclusivamente risolversi in una crescita della dipendenza delle aree periferiche da quelle centrali, per effetto delle maggiori importazioni. Il problema nasce dalla considerazione che le aree periferiche (fra le quali soprattutto il Mezzogiorno) non dispongono di meccanismi di crescita autopropulsivi e partecipano alla formazione delle catene del valore europee con produzioni a basso valore aggiunto e con uso più intensivo di lavoro precario. Occorre, dunque, potenziare la base industriale delle aree periferiche per evitare che la compressione dei salari – strategia perdente per tutti, anche solo per effetto della perdita di coesione sociale – si scarichi su queste ultime.