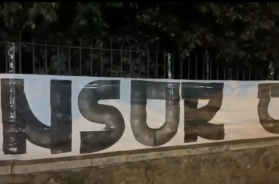È uscito, pubblicato da Espera, e disponibile in libreria e nello shop online del sito quisalento.it, La radio in Italia 1924-2024. Fatti, personaggi e trasmissioni, nuovo libro di Gianni Di Giuseppe, ex manager Rai (è stato direttore anche delle sedi di Bari e Potenza) e docente, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia.
Un volume che arriva nei giorni del centesimo compleanno della radio (lo scorso 6 ottobre), mezzo che nonostante la crisi e le minacce di televisione, web e social, è riuscito ad adeguarsi alla nuova società e ai suoi bisogni di comunicazione. Di Giuseppe parte da un excursus storico, dai primi esperimenti di Marconi, per arrivare alle radio digitali, e la Puglia è al centro della narrazione anche grazie alla storia di Radio Bari, prima radio libera italiana. La Gazzetta ha raccolto alcune suggestioni dell’autore e qualche retroscena dell’opera.
Come sta la radio oggi e perché l’esigenza di dedicarle un lavoro simile?
«Ho sempre avuto un certo fascino per la “scatola parlante”, immaginavo dietro piccoli uomini che cantavano e ballavano, e smontandola da ragazzino rimasi deluso nel vedere solo valvole e manopole, ma che ti consentivano di fare il giro del mondo. La radio oggi gode di ottima salute: negli anni ‘30 ci fu il boom, ma il costo degli apparecchi era elevato, poi con la nascita della tv si è dovuta reinventare, ma mettere in piedi una stazione radio costa molto meno. È riuscita a mantenere la sua caratteristica, il rapporto diretto con l’ascoltatore, le emozioni, poi le radio private hanno consentito anche alle piccole aziende di farsi pubblicità, garantendo una certa capillarità sul territorio».
La Puglia come si colloca in questa storia?
«Nel 1904 Marconi arriva a Bari e organizza un primo collegamento commerciale in Montenegro, era quella la funzione della radio. Poi nel 1932 viene inaugurata la stazione di Radio Bari, con un trasmettitore di 20kW, perché nell’interesse di Mussolini doveva sentirsi anche in Grecia, Albania e Africa, dove c’era l’impero. Radio Bari proponeva trasmissioni in nove lingue, e la sua evoluzione arriva grazie a un gruppo di intellettuali che propongono una controinformazione. Sarà mezzo per raccontare ciò che fanno i comitati di liberazione».
E il linguaggio negli anni com’è cambiato?
«Intanto l’ascoltatore non è un soggetto passivo, ma attivo, grazie all’interazione tramite telefonate, messaggi, e questo capovolge la comunicazione. Col passaggio al digitale, poi, gli ascolti si sono moltiplicati: oggi nel mondo si stima l’esistenza di 16 milioni di stazioni in onde medie e 29 milioni in modulazioni di frequenza. Il podcast è ancora diverso, è on demand, riprende quella che è stata l’esperienza del radiodramma, mentre la radio pura segue un clock, un’alternanza di musica, informazione, pubblicità. Anche oggi, dove in molti studi hanno aggiunto le telecamere, trovo sia solo un veicolo di marketing, non c’è niente in più a livello di informazione e contenuto».bianca chiriatti