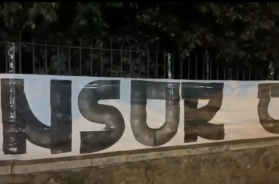Prima di parlare delle cardiomiopatie del cane e del gatto è d’obbligo una descrizione della struttura esterna ed interna di un cuore «normale». Come è noto, situato nel torace, dietro lo sterno, lato sinistro, è costituito da quattro cavità: due superiori, gli atri e due inferiori, i ventricoli. Sotto l’aspetto funzionale si è soliti pensare al cuore diviso in una sezione destra e in una sinistra. Il sangue venoso arriva nell’atrio destro e tramite la valvola tricuspide passa nel ventricolo destro e quindi da qui viene veicolato ai polmoni grazie all’arteria polmonare. Nei polmoni, dopo essersi caricato di ossigeno tramite le vene polmonari, sbocca nell’atrio sinistro; poi, attraverso la valvola mitrale, finisce nel ventricolo sinistro e di seguito, da qui, ad ogni battito cardiaco, viene eiettato nell’aorta che con tutte le sue ramificazioni porta il sangue ossigenato in tutto l’organismo. Ognuna delle camere cardiache è formata da tre strati, quello interno è l’endocardio. C’è poi il miocardio che è il muscolo cardiaco vero e proprio, mentre la parte più esterna è il pericardio.
Quest’ultimo avvolge e protegge il cuore difendendolo da possibili infezioni e traumi. È costituito da uno strato fibroso esterno e uno strato sieroso interno che produce un liquido lubrificante (liquido pericardico), che oltre a favorire i movimenti intrinseci del cuore ne riduce l’attrito con le strutture circostanti.
Vediamo adesso le cardiomiopatie nel cane e nel gatto. Sono malattie che colpiscono il muscolo cardiaco spesso compromettendone la sua funzione in modo piuttosto grave. Quella più frequente nel cane, sulla quale adesso ci soffermeremo, è la miocardiopatia dilatativa (DCM) caratterizzata da una severa dilatazione del cuore che comporta una ridotta capacità di pompare il sangue in circolo. Per alcune razze, come il Dobermann, il Terranova, l’Alano e il Levriero irlandese, questa malattia ha basi «genetiche» e quindi molti di loro sono predisposti a questa patologia, ragione questa per cui è opportuno tenerli sempre monitorati, in particolare verso una certa età.
Ma non dobbiamo dimenticare che questa malattia colpisce anche altre razze canine tra cui il Pastore tedesco, il Boxer ed il Cocker Spaniel e comunque anche soggetti non di razza di media e grande taglia.
Ci sono però anche altre cause predisponenti a questa gravissima patologia tra cui quella di tipo «nutrizionale», come la carenza di carnitina e quella di taurina. Di quest’ultima è molto sensibile soprattutto il gatto, che a sua volta viene spesso colpito da un’altra cardiomiopatia, ovvero: la cardiomiopatia ipertrofica felina (HCM), caratterizzata da un ispessimento anomalo della parete del ventricolo sinistro. Inoltre, non ultime, le pericolose cause «infiammatorie», spesso responsabili dell’evoluzione di questa malattia. I sintomi più importanti oltre che più frequenti che vengono evidenziati dai soggetti colpiti da forme gravi di miocardiopatia dilatativa sono un allarmante ed evidente stato di affaticamento, unitamente a severe difficoltà respiratorie, che si evidenziano con affanno e frequenti colpi di tosse. Inoltre nei casi ancora molto più gravi è presente anche un macroscopico aumento di volume dell’addome, causato dal versamento ascitico.
Parlando della diagnosi di questa malattia devo precisare che è basata su diversi tipi di indagini ed in primis l’esame «ecocardiografico», poiché il più attendibile. Seguono gli «esami radiografici» del torace e l’holter. Inoltre, molto utile è l’utilizzo dei «biomarcatori cardiaci» come la «troponina», esame molto utile per diagnosticare l’infarto miocardico, unitamente ad altri che possono fornirci indicazioni sulla dilatazione cardiaca e sulla presenza di un danno miocardico.
Vediamo adesso la terapia per la cardiomiopatia dilatativa (DCM) del cane. Si basa su alcuni farmaci che mirano a gestire i sintomi per rallentare la progressione della malattia che altrimenti ne provocherebbe il decesso in tempi brevi. Anche perché stiamo trattando una patologia inguaribile che di solito ha un decorso infausto. I «diuretici» (come la «furosemide») aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso. Gli «ace-inibitori» unitamente al «pimobendan» aiutano a ridurre il sovraccarico del cuore e hanno un effetto vaso dilatatore migliorando la funzione cardiaca e quindi la qualità della vita. Quando necessario si possono aggiungere gli «antiaritmici». Anche l’integrazione con dei ricostituenti cardiaci possono essere utilizzati facendo uso di acidi grassi Omega3 e carnitina. Nei casi di grave scompenso cardiaco «destro», che provoca quasi sempre «l’ascite», ovvero un’eccessiva raccolta di liquidi in addome, potrebbe essere utile rimuovere periodicamente il liquido in eccesso dalla cavità addominale o dalla cavità toracica per alleviare le sofferenze a questi sfortunati pazienti.