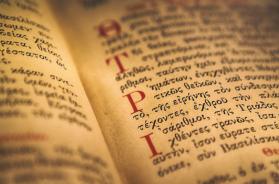«Quando sono arrivato, nell’agosto 2015, Ventimiglia era la frontiera più calda d’Europa. La Francia aveva appena schierato la Polizia di Frontiera coadiuvata dall’esercito per bloccare i migranti al confine e per riammetterli in Italia. Centocinquanta migranti erano accampati sulla scogliera per tentare di attraversare nottetempo la frontiera». Sono passati quasi dieci anni dall’insediamento di Martino Santacroce al comando della Polizia di frontiera di Ventimiglia; ma ricordando i primi caldissimi giorni, la voce si carica ancora di tensione.
Come visse quel ruolo così delicato in quel momento complicatissimo?
«Era una grande responsabilità. C’erano troupe da tutta Europa, le tv trasmettevano le immagini delle tende sulla scogliera e delle riammissioni in piena notte: il mio battesimo è stato alle 3 di notte del 3 agosto, quando una telefonata mi ha avvertito che la Polizia di Frontiera francese stava scaricando oltre cento persone in territorio italiano. La Francia aveva chiuso di fatto le frontiere (tecnicamente Schengen venne sospeso solo tre mesi più tardi) e io mi trovavo a gestire le conseguenze di una crisi internazionale con pericoli anche per l’ordine pubblico».
Come ne uscì?
«Dialogando. Quando mi arrivò quella telefonata alle 3 di notte pensai “devo trovare un referente”. Il giorno dopo scoprii che fino ad allora i rapporti erano stati unicamente con la Polizia di Frontiera di Mentone, il primo paese in territorio francese, che dipende da Nizza. Quindi chiamai direttamente il mio omologo di Nizza per capire quali modalità di cooperazione potevamo trovare insieme: da lì, dopo numerosi incontri che rafforzarono anche il rapporto personale tra noi, nacque un protocollo sperimentale, una delle cose di cui sono particolarmente orgoglioso».
L’esperimento della Polizia comune europea?
«È stato il primo abbozzo. Sperimentammo un gruppo di polizia di frontiera mista italiana e francese, con un organico specifico: in pratica una volante internazionale. Questo supera i problemi di competenza territoriale ma fornisce anche strumenti in più; ad esempio tu fermi un passeur a Mentone, in territorio francese, e puoi controllare subito se ha precedenti nella banca dati della polizia italiana. Prima era necessario portarlo in caserma, dove la polizia francese contattava i poliziotti italiani, eccetera eccetera. Oggi quello spreco di tempo e risorse non c’è più, perché quel protocollo sperimentale è rientrato nell’Accordo del Quirinale, firmato dai presidenti Mattarella e Macron».
I “passeur” sono gli scafisti di terra, cioè coloro che organizzano il flusso di immigrazione irregolare tra Italia e Francia. In questi quasi dieci anni ne ha visti molti?
«La mission principale della polizia di frontiera a Ventimiglia è il contrasto dell’immigrazione clandestina: mediamente ogni anno arrestiamo 250 persone di cui una cinquantina di passeur, persone che favoriscono l’immigrazione clandestina. Ho diretto numerose indagini in questi anni, svolte con la procura di Imperia e quella di Nizza, tra cui le operazioni Bengala, Scharun, Sicomoro e Pantografo».
È un mercato ricco?
«C’è un giro impressionante: in una indagine abbiamo tracciato il flusso di denaro di una organizzazione che con una flotta di 4/5 macchine arrivava a guadagnare anche 20mila euro a notte. Il pagamento per far passare la frontiera italo-francese può oscillare da 100 euro a 800: se ti nascondo su un treno, sul tetto o in un vano tecnico, sono 100 euro; se ti carico in una macchina ti chiedo 800. Entrambi i modi sono molto rischiosi: sul tetto del treno il migrante finisce spesso folgorato dal pantografo, il meccanismo che porta l’elettricità alla locomotiva. Le auto o i furgoni invece sono spesso guidati da autisti imbottiti di cocaina che non si preoccupano in nessun modo della sicurezza delle persone che trasportano».
Qualche episodio?
«Era il 2016, nel mio primo anno di dirigenza. Un furgone non si ferma all’alt e si mette a scappare. Scatta l’inseguimento da parte delle nostre macchine e il passeur alla guida si getta fuori dall’abitacolo dandosi alla fuga e abbandonando il furgone in corsa. In quel momento eravamo su un viadotto in salita e quindi il furgone, esaurita la spinta, comincia a indietreggiare, prende velocità e rischia di sfondare il guardrail e cadere giù. I miei uomini allora hanno la prontezza di riflessi di intuire il punto d’impatto e piazzano una volante, ovviamente vuota, che funge da cuscinetto. Il furgone sfonda la macchina, che a sua volta sfonda il guardrail. La corsa però si ferma: quando abbiamo tranciato il lucchetto del furgone, all’interno abbiamo trovato quaranta persone che urlavano terrorizzate. Momenti di panico vero».
Sul reale ruolo degli scafisti si è molto discusso dopo il film di Matteo Garrone “Io Capitano”: lì a guidare la barca tra Africa e Italia c’è un ragazzo uguale agli altri migranti ma talmente povero da potersi pagare il viaggio solo in quel modo. Evidentemente non un criminale, pur tecnicamente colpevole di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ha trovato qualcosa del genere anche a Ventimiglia?
«Io nella mia esperienza non ho mai visto un passeur che non fosse delinquente. I peggiori fanno questo mestiere pensando di arricchirsi alle spalle dei loro conterranei, magari imbrogliando gente che è sbarcata a Lampedusa 15 giorni prima, che non sa nulla dei rischi che corre e che loro avviano a morte non dico certa ma molto probabile».
E che cosa prova nei confronti delle persone che scappano, a volte attraversando quel confine che lei è chiamato a vigilare?
«Noi salentini possiamo capire cosa li spinge: siamo una terra di emigrazione. Quando sono arrivato a Ventimiglia ho pensato che forse di lì era passato mio nonno, quando è partito da Taviano per andare a lavorare in Francia. Ricordo ancora una famiglia di iracheni che trovammo nel doppio fondo di una Renault: il papà, la mamma, una figlia di sei anni, due altri bimbi di un anno. Il passeur li aveva incastrati come in un tetris, i piedi contro le teste, era davvero impressionante. I neonati non capivano la situazione, ma tu immagina il trauma di una femminuccia di sei anni nascosta lì dentro. Quando li abbiamo portati in caserma, le mie poliziotte li hanno portati a fare la doccia e noi siamo andati a comprare qualche vestitino. Sappiamo reprimere, ma siamo esseri umani».
È quasi arrivato al decimo anno di dirigenza a Ventimiglia, e dopo quei caldissimi primi giorni entrambi i Paesi le hanno voluto dimostrare apprezzamento: non solo l’Italia ma anche la Francia.
«Sì, nel 2019 la Francia mi ha conferito la medaglia d’oro per la sicurezza del Ministro dell’Interno mentre per l’Italia l’onorificenza di cavaliere ufficiale al merito della Repubblica mi è stata conferita dal presidente Mattarella a giugno del 2023».
Tra poco dovrà cambiare sede. Sa già dove?
«Ancora no, è presto. Posso solo dire che ho nostalgia del sole della Puglia».