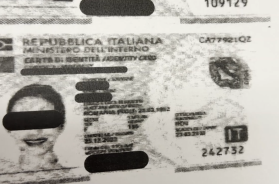Il 12 giugno, tra una dozzina di giorni, in contemporanea con le elezioni amministrative di alcune città, si voterà per i cinque referendum sulla Giustizia promossi da un milione di firmatari, da nove consigli regionali e ammessi al voto dalla Corte Costituzionale. In Italia i referendum sono l’unica occasione, l’unico appuntamento con la democrazia diretta - quella vera non quella farlocca delle consultazioni on line fai da te. I referendum consegnano a tutti i cittadini il potere, votando sì o no ai quesiti proposti, di abrogare o di confermare, in tutto o in parte, le leggi vigenti. La nostra Repubblica nasce dalla volontà popolare che abrogò la monarchia complice nell’avvento del fascismo, della dittatura di Mussolini, delle leggi razziali, della tragica alleanza col nazismo e dello scatenamento della Seconda guerra mondiale.
Negli anni Settanta e Ottanta decisero svolte decisive mantenendo fondamentali libertà civili come il diritto al divorzio e all’interruzione di gravidanza contestate dalla Chiesa cattolica e dai suoi referenti politici. Negli anni successivi il referendum sul piano energetico nazionale celebrato dopo il disastro di Cernobyl bloccò l’installazione di centrali nucleari e quello sulla «Giustizia giusta» stabilì il principio della responsabilità del magistrato che sbaglia per ignoranza delle leggi o manifesta incompetenza della causa.
L’ultimo grande referendum è stato quello del 2016 con cui gli italiani hanno bocciato la riforma costituzionale proposta da Matteo Renzi. L’ultimo e il più controverso giacché se è indubbio che Renzi sbagliò – lui stesso lo ha riconosciuto – a personalizzare la competizione arrivando a promettere di lasciare la politica in caso di sconfitta, la vittoria del fronte conservatore ha bloccato ogni volontà di revisione e di rinnovamento della Costituzione. «La più bella del mondo» sono soliti definirla coloro che hanno letto solo la nostra Costituzione tanto pregevole nella sua parte cerimoniale, là dove tratta di principi e valori, quanto lacunosa e claudicante nella parte efficiente, quella che definisce e organizza i poteri dello Stato. La Giustizia è l’aspetto in cui la nostra Costituzione mostra più chiaramente le sue piaghe. A cominciare da quella statuizione tanto perentoria quanto indeterminata e velleitaria che stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale. Stabilendo che tutti i reati devono essere perseguiti i padri costituenti hanno imposto a quella parte dello Stato che amministra la Giustizia un compito impossibile. Nessuno Stato, antico o contemporaneo, può perseguire contemporaneamente tutti i reati. Se a capirlo non basta il buon senso lo provano i fatti: in Italia più del 90 per cento dei reati resta impunito. Ora, la manifesta impossibilità di attuare quel comandamento assoluto ha sinora inibito ogni tentativo di stabilire una gerarchia tra i reati, dai più gravi ai meno gravi, lasciando la scelta di quali perseguire prioritariamente alla discrezionalità cioè all’arbitrio del singolo Pubblico ministero. A questo disordine istituzionale si sono poi sommate le storture prodotte dalla insostenibile convivenza tra le norme autoritarie del Codice fascista (Codice Rocco), i principi democratici costituzionali e le nuove norme del Codice Vassalli del 1988.
Quest’ultimo importando parzialmente il modello di processo «all’americana» e la parità (a parole) tra accusa e difesa ha aggravato il disastro. Poiché governi e parlamenti non hanno voluto, potuto, saputo por mano a una grande coerente riforma della giustizia l’unica possibilità che ci resta è quella di una mobilitazione popolare che li costringa a pensare e a agire. A questo servono i 5 referendum, per questo è nostro diritto, nostro dovere, nostro interesse di cittadini partecipare e votare. Votare perché la timida riforma Cartabia non sia ulteriormente infragilita in Parlamento; perché i partiti si sveglino dal sonno della ragione che li ha visti colpevolmente assenti dalla campagna referendaria; perché il Pd e il suo segretario Letta così meritoriamente attivo e solidale con l’Ucraìna aggredita e devastata da Putin, si liberi e ci liberi dai riflessi condizionati del giustizialismo e dall’incostituzionale subordinazione della politica democratica a quella che Sergio Mattarella ha definito come «la degenerazione del sistema correntizio e l’inammissibile commistione tra politici e magistrati» .