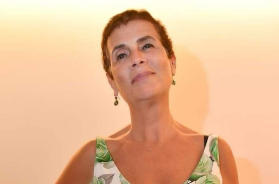SAN PAOLO ALBANESE - Una traversata, il sogno di una vita migliore, la voglia di ricongiungersi con i propri cari oltreoceano; poi, all’improvviso, un vento di burrasca, la necessità di fermarsi in porto per rifornimenti. Un errore umano, lo scafo in ferro cede, le 2.371 tonnellate sembrano una piuma. Le urla dei passeggeri sovrastano il vento di burrasca.
Nell’ufficio del sindaco di San Paolo Albanese, Mosè Antonio Troiano, c’è il modellino di un monumento in fase di realizzazione: sarà dedicato anche alle vittime che da San Paolo Albanese si imbarcarono e perirono.
Era il 17 marzo del 1891. Il piroscafo «Utopia» navigava nel mar Mediterraneo seguendo la rotta che partendo da Trieste conduceva i passeggeri a New York. Gli scali intermedi nei porti di Napoli e di Genova, permettevano di imbarcare altri (numerosi) emigranti italiani. E quello di Gibilterra era l’ultimo porto dove reperire i rifornimenti di viveri e carbone prima della traversata oceanica.
In quel pomeriggio di 132 anni fa la navigazione procedeva con difficoltà a causa della tempesta. Come raccontano le cronache dell’epoca e le ricostruzioni successive, il comandante decise di dirigersi ugualmente verso il porto per assicurare al vascello un ancoraggio sicuro. Entrando nella baia di Gibilterra si accorse che in rada c’erano diverse navi da guerra britanniche.
Pur se a bassa velocità, il comandante notò con disappunto che l’ormeggio a cui abitualmente attraccava il suo vapore era occupato dalle corazzate britanniche. Decise di attraversare il braccio di mare davanti ai due vascelli della Royal Navy ma in quel momento, secondo quanto riferì alla commissione di inchiesta il comandante, fu abbagliato dal faro della corazzata «Anson» che scandagliava il porto di Gibilterra durante la burrasca.
Un errore di valutazione che, unito al vento di burrasca, fu fatale. Il piroscafo affondò in meno di venti minuti. Morirono più di 500 persone, tra equipaggio e passeggeri. Impossibile fare un calcolo preciso delle vittime, perché molti passeggeri erano clandestini.
Quella storia sarà raccontata dal ricercatore Gianni Palumbo in un libro che sarà edito nel corso del 2023.
La Basilicata pianse molte di quelle vittime, che provenivano da almeno 10 comuni diversi, tra cui Matera e Potenza. Ma il sacrificio maggiore, in termini numerici, lo ha compiuto proprio il piccolo comune di San Paolo Albanese, con 12 vittime.
Il sindaco Mosé Antonio Troiano scorre lentamente il dito tra i dispacci di morte che arrivarono solo nel settembre successivo: Smilari Francesco, anni 62; Smilari Diamanda, anni 23; Troiano Caterina, anni 14; Trupo Andreana, anni 51; Buccolo Maddalena, anni 16; Blumetti Maddalena, anni 36; Osnato Maddalena, anni 41; Basile Giuseppe, anni 40; Blumetti Domenica, anni 29; Fioravante Maddalena, anni 34; Fioravante Raffaele, anni 24; Sassano Francesco Antonio, anni 32.
«Molti nomi sopravvivono ancora nelle generazioni di adesso - spiega il sindaco - segno, se mai ce ne fosse bisogno, che quella tragedia deve essere ricordata perché ci riguarda ancora. Sono corsi e ricorsi storici, è successo all’epoca e succede oggi. E succederà ancora se non si prendono dei provvedimenti. Sull’Utopia alcuni avevano il biglietto per andare in America ma sappiamo anche che nelle stive c’erano tanti clandestini senza un permesso regolare».
Scappare da una guerra e sentirsi accolti e integrati: fu il destino delle comunità Arbëreshë che si stanziarono in Italia tra il XV e il XVIII secolo dopo la morte dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderbeg. «Fu una storia di accoglienza - spiega il sindaco - perché i nostri avi sono stati accolti. Ma fu anche una storia di integrazione nella comunità italiofona. Oggi dovremmo parlare anche di uguaglianza, perché siamo un unico popolo».