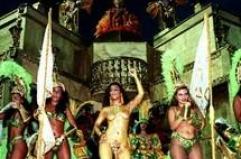Quanta cultura è passata nei secoli per Gaza, prima che si incasellasse tragicamente nelle pagine internazionali. Almeno dal Secondo Dopoguerra, e in particolare dal tempo della Nakba, il tema israelo-palestinese è stato una miccia esplosiva sul Novecento e nel cuore del Mediterraneo.
Intanto, da questa parte del mare, ci sentiamo – in questo momento della storia - impotenti, appendiamo lenzuoli bianchi alle finestre per ricordare quei tantissimi morti innocenti e quei sudari di Gaza. Nel libro Ultima fermata Gaza, dove prendono la parola Ilan Pappè (autore di La pulizia etnica in Palestina nel 2008) e il linguista Chomsky, si cerca di affrontare il tema
israelo–palestinese fuori dalle ipocrisie, anche in maniera piuttosto severa, rielaborando, in parte, quel saggio di Chomsky, Sterminate i bruti, in cui veniva offerta un’analisi smagata dei rapporti fra Israele, Stati Uniti ed Europa. Sono sempre gli scrittori e gli intellettuali a intravedere, per primi, le ceneri, quando il fuoco non c’è ancora. C’è, però, tanto altro da raccontare sulla grandezza di Gaza!
Qui vogliamo seguire le parole della scrittrice e giornalista, anche autrice di un libro Il gelso di Gerusalemme, Paola Caridi, che dice «prima, molto prima di quel tempo chiuso e sigillato nato con il ’48, Gaza era il porto, la città, e alle spalle la terra» e aggiunge: «in particolare dal V secolo d.C., in poi, Gaza era anche la grande cultura del monachesimo, era il centro mercantile e dei commerci». E infatti Gaza, col suo nome, ha attraversato i secoli lungo una storia millenaria che risale al periodo del Bronzo Antico (3500-3000 a.C.). Situata lungo la costa della Palestina, occupava una posizione strategica nella cosiddetta «Via Maris», un’antica rotta commerciale, che collegava l’Egitto alla Siria e alla Mesopotamia, fungendo da crocevia tra tre continenti. Attraverso l’antico Egitto, l’età greca e le testimonianze di Erodoto, il periodo romano e la sua successiva
cristianizzazione al tempo del vescovo Porfirio (347d. C.-420 d.C), Gaza è poi divenuta anche un importante porto per i pellegrini cristiani diretti verso il Sinai. Lì, in quelle terre, è fiorito un pezzo di cultura ellenizzata, lì è fiorita un’ultima grande scuola retorico-filosofica.
Gaza è stata un luogo con la più lunga conservazione del culto pagano accanto a quello cristiano, coi templi dedicati agli dei sino al V sec. d. C., insieme al fiorire del Cristianesimo, che rimaneggiava la cultura dei gentili. Come ricorda Caridi, Gaza era all’interno di una provincia che si spingeva in profondità verso est: fonti medievali la fanno arrivare fino a Wadi al-Hasi (cioè Nahal Shiqma per Israele), il corso d’acqua dei sicomori, testimoni privilegiati di un tempo migliore, raccontato anche, per la sua natura rigogliosa, da scienziati e viaggiatori, come il geografo arabo Muhallabi, uno dei più noti. La Striscia di Gaza era pertanto un punto di confronto pacifico tra paganesimo antico, cultura greca e misticismo cristiano, un sincretismo decisamente accogliente.
La cosiddetta “scuola di Gaza” va a coincidere con l’attimo storico poco prima della centralità di Costantinopoli…
Per quell’attuale pezzo di terra, è passato tanto Omero, coi suoi Patroclo e Achille, tanta cultura platonica e perfino diversi poeti come Pindaro, senza dimenticare i volumi di Teofrasto, di Plotino e di tutto quel pensiero che, con grande lungimiranza, seppe accostare la filosofia greca alle Scritture, che infiammavano gli animi dei primi fedeli. Se consideriamo il contesto cristiano in cui i retori gazei (come si diceva nel mondo antico) si trovarono a operare (e il loro duplice ruolo di retori della collettività cittadina e di professori responsabili della formazione della futura élite locale), viene da chiedersi: perché leggevano proprio Omero e le vicende dei suoi eroi?
Quel che sappiamo è che il mito pagano, e soprattutto gli eroi d’Omero, sono stati, per quella gioventù gazea, una base fondamentale della loro istruzione superiore. Si seppe intravedere proprio nel mito, una categoria interpretativa della complessa realtà. Era questo Gaza prima che la storia le si rivoltasse contro ferocemente. A Gaza si leggeva Omero, che - arrivato dopo secoli in quella zona, attraverso la ricezione della sua opera - era l’esempio dell’integrazione fra passato e presente, ma con curiosi spunti innovativi. Il retore Coricio, nella Gaza del tempo, ritenne di dare, per la prima volta, la parola a Patroclo, senza limitarsi a descriverlo fisicamente, come avevano fatto altri bizantini. Coricio ha saputo immaginare un discorso che il giovane avrebbe rivolto al suo amico amato, Achille, per chiedergli di placare la sua ira e di fermarsi a piangere i tanti morti di un esercito fraterno, che la guerra ha saputo solo sterminare.