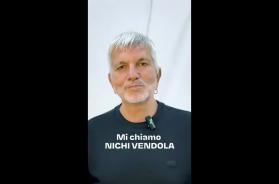ROMA - Quel grande fenomeno sociale, politico e di costume che è stato il '68 italiano è cominciato, in realtà, nel 1967, anzi, forse, addirittura nel 1966.
E' infatti il 1966 quando il mondo un pò imbalsamato della scuola italiana viene scosso dal «caso Zanzara», un giornaletto del liceo milanese Parini che aveva provocato uno scandalo nazionale pubblicando un'inchiesta sui costumi, anche sessuali, degli studenti. Ancora nel 1966, ad aprile, all'Università di Roma moriva Paolo Rossi, studente socialista, scout, «caduto» da una scalinata durante un assalto di estremisti di destra. A novembre del 1966, tra gli «angeli del fango» accorsi spontaneamente per dare una mano a salvare Firenze dall'alluvione, ci sono molti di quei giovani di sinistra e del dissenso cattolico che saranno poi tra i protagonisti del Sessantotto. A febbraio del 1967 gli studenti occupano l'Università di Pisa che doveva ospitare un incontro dei rettori con il ministro della Pubblica istruzione, Luigi Gui. E ancora, l'1 novembre, all'Università di Trento (frequentata, tra gli altri, da Renato Curcio e Mara Cagol) si svolge un sit-in contro l'università classista.
Ma quello che si considera il vero e proprio atto di nascita del '68 è del 16 novembre 1967 quando, davanti all'Università Cattolica fondata dal severo Padre Gemelli, accade un fatto inusuale per quell'epoca e soprattutto per quel luogo: un'assemblea di studenti che non solo discutono e protestano per la tipologia dei corsi di studio e per la selettività, ritenuta classista, ma pensano anche agli orrori della guerra in Vietnam, che la tv porta ogni sera in tutte le case, sognano di cambiare il mondo, vogliono abbattere gli steccati ideologici e culturali nei quali vedono imbrigliata la società.
Ad arringare i ragazzi della Cattolica c'è un giovane alto e magro, vestito quasi come un prete, si chiama Mario Capanna. Diventerà un leader politico, deputato e capo di Democrazia Proletaria. In quel momento è solo uno studente (poi sarà espulso dall'ateneo, insieme a Luciano Pero e Michelangelo Spada) capace di trascinare l'assemblea. A sera gli studenti decidono di occupare la Cattolica. Fatto straordinario che finisce su tutti i giornali, ne parla anche la tv, gli studenti ottengono un primo grande risalto, con le loro rivendicazioni che, a seconda dei punti di vista, vengono considerate innovative o sovversive.
Quella prima occupazione dura poche ore, perché nella notte gli agenti guidati dal commissario Luigi Calabresi (che nel 1972 sarà assassinato a Milano) provvedono a sgomberare i locali. Il giorno dopo nel capoluogo lombardo la protesta ricomincia e diventa più forte, torna l'occupazione e, soprattutto, da quel momento la protesta studentesca diventa un fatto nazionale. Dieci giorni dopo è la volta di Torino, con l'occupazione di Palazzo Campana che rappresentò anche un forte segnale politico, essendo Torino soprattutto la città della Fiat, individuata come l'emblema dell'autoritarismo. La protesta poi dilaga nelle università di Torino, Genova, Napoli, Firenze, Cagliari, Salerno, Padova che vengono occupate a dicembre e nei mesi successivi. Fino all'ondata travolgente di proteste, manifestazioni, occupazioni, del 1968 vero e proprio.
Il '68 italiano dunque iniziò davanti all'ingresso della Cattolica. Il governo, i partiti, l'establishment dell'epoca furono colti di sorpresa da quel diluvio di assemblee, occupazioni, proteste. Lo studio parve passare in secondo piano rispetto ai grandi temi della politica da svecchiare e rinnovare, della guerra da ripudiare con forza, della Chiesa e della cattolicità da modernizzare, dell'emancipazione femminile e della libertà sessuale da perseguire con determinazione.

Martedì 15 Gennaio 2008, 17:36
12 Novembre 2024, 16:25