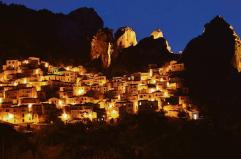Il «tesoro» è nascosto dalla chiesetta di gusto ottocentesco intitolata alla Madonna Odigitria: «colei che conduce mostrando la via». La via da mostrare è la Francigena, che i pellegrini percorrevano, e qualcuno lo fa ancora oggi, per raggiungere a Leuca, il Santuario De Finibus Terrae. Siamo nella linda e centrale via Vittorio Emanuele di Nociglia, poco più di duemila abitanti, con Botrugno, Giuggianello, San Cassiano, Surano, Sanarica e Supersano, una delle sette «terre di mezzo» della Penisola Salentina. Inglobato nella chiesetta, aldilà d’un passaggio che s’apre dietro l’altare, il «tesoro» si presenta, abbagliando, sulle quattro pareti affrescate dall’XI secolo e sino agli ultimi anni della dominazione bizantina (1453), d’una Cappella di 8 metri per 4 e cinque d’altezza, da artisti locali ed al seguito dei pellegrini.
Il primo impatto è con cinque statue in pietra leccese, assieme alle quali è una pregevole acquasantiera utilizzata nel Medioevo come fonte battesimale. Tre sono sull’unico altare: la Madonna dell’Immacolata e le Sante Barbara ed Irene; due sul pavimento: San Pietro e San Paolo, sotto il quale si cela un minuscolo ambiente ipogeo con tre casse di legno ricolme di scheletri, una delle quali, come avviene ad Otranto nella Cripta della Cattedrale degli 813 Martiri cristiani, schermata da un vetro. Ma a sovrastarci, è la bellezza, il tratto elegante, degli affreschi, la cui visione vorremmo rimandare per meglio goderla.
Ad attrarre è soprattutto lo sguardo emblematico, financo ammiccante che rimanda alla Gioconda di Leonardo, della figura d’una giovane donna ch’indossa un abito ocra, e il cui capo è avvolto da un turbante, che in origine doveva essere turchese. Nei secoli, s’è ritenuto fosse, in ordine, delle Sante, Agata, Barbara, Lucia, Orsola, Teresa. Infine, grazie alla corretta interpretazione, da parte dello storico dell’arte leccese, Sergio Ortese, del frammento in latino Esar, fatto precedere da (Ca) e seguire da (Ia), è stata assegnata a Caesaria: Santa Cesarea. Qui, la Santa reca nella mano destra un trullo; in altri luoghi, chiese soprattutto, regge una bacinella d’acqua con due colombe. Rappresentano la sintesi della sua dolorosa storia: per sfuggire alle insane voglie del padre che l’attendeva in un’altra stanza, la sventurata lasciò nella sua lo sbattere d’ali delle colombe, per simulare, mentre fuggiva per rifugiarsi in una grotta dell’attuale località termale poco distante da Otranto, che prende il suo nome, la preparazione all’indesiderato incontro.