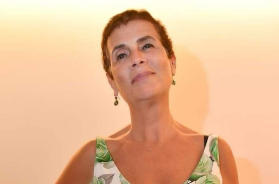Nelle mie «domeniche» sulla Gazzetta ho spesso ricordato che il Foscolo sosteneva con piglio tutto suo che gl’Italiani andassero esortati alle storie, altri, più sommessi moralisti e igienisti, hanno ritenuto che, piuttosto andassero invitati ai lavacri. Garibaldi, con la leggendaria capacità di sintesi, nel suo discorso per il laticlavio, invitò i suoi redenti connazionali semplicemente ad «esser seri». In realtà, quando il generale istigava i connazionali alla serietà gli irredenti erano rimasti in pochi: Trentini e Triestini che seri dovevano essere per forza, da sudditi asburgici che erano.
Mi accodo agli istigatori e mi permetto di incoraggiare gl’Italiani alle etimologie. Esercizio, questo che può sembra umile, ma che considero utilissimo. Può attivare lodevoli riappropriazioni e restaurazioni di fiori d’orgoglio nazionale. Ho sotto gli occhi l’ottimo Dizionario etimologico della Lingua italiana della Zanichelli, squadernato alla pagina che reca la parola mozzarella.
Ho fatto la ricerca per via della mia smodata propensione al gustare, la mozzarella. Anzi le mozzarelle. In una vicenda mia televisiva, mi permisi di sentenziare, per scherzo, qualcosa circa la necessità di un marchio di origine geografica per la mozzarella e per la burrata, squisito parente della «giuncata» conservata in abito verde di giunco.
Mi hanno scritto un paio di lettere e in cui mi si pregava di convincere i lettori che la produzione su larga scala (industriale?) non costituisce reato di lesa mozzarella. Forse non era così chiaro che, la mia, era una difesa, genuina, del fiore della produzione casearia pugliese. Mi dicono che avrei fatto una generalizzazione e che, in verità le buone trecce e le burrate si continuano a vendere. Anzi ne chiedono di più. Voglio farmi perdonare. Da anni siamo stati rassicurati della sopravvivenza della mozzarella genuina fatta all’antica italiana che, sola, merita il marchio d’autenticità sia che faccia fiorire in forma di formaggio sublime il latte di bufala (Campania e Lazio) sia che germogli sul fiore del latte di vaccina (mia meravigliosa Puglia soprattutto).
Fu una buona notizia, ma risale al 2000 e temo che, in 23 anni, la regolamentazione sia stata abolita o sostituita da più blandi accomodamenti. Questo spiegherebbe la «bufala» industriale. Bufala nel senso di «patacca», di imbroglio? No: è che mi piacciono i giochi di parole. A proposito di etimologie: dicesi «bufala» di fregatura per ricordare l’astuzia culinaria di certi osti che si facevano pagare come una bistecca di manzo, una più rude ed economica carne di bufala.
Ch’io ricordi, comunque, la mozzarella è salva. Si può chiamare così solo quella fatta con l’antica ricetta. S’ingegnino i casari sprovvisti del miracoloso savoir-faire e che si vogliono ostinare ad usare siero o succedanei del latte a trovare altri nomi per le imitazioni, ma giù le mani da «mozzarella».
Ero a questo punto con la riflessione, quando ho deciso di dar di piglio alla preparazione della mia merenda del sabato che sostituisce l’insopportabile (con questo caldo) pranzo delle quattordici. Anche l’ora del desinare la dice lunga sulle mie origini. Dunque vediamo: pomodoretto, sale, perfetto olio di Bitonto, mozzarella tagliata a fette e profumatissimo basilico a foglia piccola, quello del pesto, per intenderci. Mentre osservo lacrimare il candido formaggio m’interrogo sulle sue origini per dedicare al suo inventore un pensiero grato e reverente. Decido che per tanto portento non deve essere stato sufficiente un solo casaro geniale e lungimirante. Deve esserci stata l’opera di un popolo intero. Come taluni sostengono per Iliade e Odissea: non un solo Omero, ma un’intera nazione di poeti, più generazioni di aedi, folle di cantori. Insomma, dopo la «questione omerica» non è trascurabile una «questione della mozzarella». Meglio prepararsi e ciò spiega il mio affaccendarmi tra le pagine dell’amico vocabolario. Leggo e prelevo.
La parola compare per la prima volta Opera di B. Scappi, un testo scritto nel 1570: «Capi di latte, butirro, ricotte fiorite, mozzarelle fresche e neve di latte». Che meraviglia! Ma andiamo all’etimologia. Due le congetture: da mozzare «perché cacioline fatte con smozzature di cacio». Altri sostiene «Dall’esser, appunto, legato a mezzo (il formaggio) e quasi mozzato». Decido di optare per la seconda ipotesi a causa di certe infantili memorie presepiali in cui compaiono compunte pastorelle recanti alla Grotta santa buffe palle incordate da legacci che mi erano indicate come le mozzarelle di allora. L’allora di Gesù. Pensavo, bambino, che se Lui, il Salvatore, aveva anche i gusti a nostra somiglianza, avrebbe gradito avere anche i pomoderetti. Non se li aspettava dai Re Magi che venivano, sì dall’Oriente ricco di novità e primizie storiche, ma non dalle Americhe. E questo, il Signore lo sapeva bene. Quanto al basilico, la foglia dei re, non ne sarà certo mancato tra gli omaggi delle genti a Lui, Re dei Re, per fare la cialda o frisa o panzanella, fate voi. E qui, ecco arrivare trionfalmente il Pane, il maiuscolo pane di Altamura. E, per chiudere, i fioroni turgidi e dolcissimi. Italiani v’invito a tavola in Puglia.