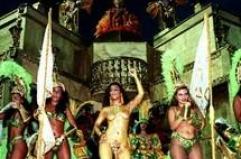Si stagliano come un romanzo giallo parallelo della storia italiana le cinque puntate dello sceneggiato televisivo Rai Lungo il fiume e sull’acqua inaugurate il 13 gennaio del 1973, diretto dai Alberto Negrin, e il successivo Storie della camorra di Paolo Gazzara che a sua volta si snoda in sei puntate nella triste primavera del 1978, a cominciare dal 3 maggio. Le rispettive colonne sonore di Roberto De Simone ne accompagnano l’andamento ritmico ed evocativo, tra tradizione popolare e inquietudine crescente, che scorre per l’appunto “lungo il fiume” e sotto la pelle di eventi connessi o comunque concomitanti e della cui portata ancora oggi si stenta a credere.
Il tutto sembra fatto apposta per un giallista di mestiere, capace anche di star dietro alla pista indiziaria e alle risonanze del poliziesco sul piccolo schermo, dove proprio i fatti e il contesto nazionale esterno reale eccedono la misura della finzione e stabiliscono un patto segreto, misterioso e cupo con le rispettive trame. Chiunque abbia infatti voglia di sbizzarrirsi sul versante politico-indiziario potrebbe agganciare le indagini e i risvolti musicali di Lungo il fiume e sull’acqua interpretato da Giampiero Albertini, Sergio Fantoni, Laura Belli e Renato De Carmine, non tanto al romanzo di partenza di Francis Durbridge, The Other Man, reso per le rime e le note molto italiano, per gli interni negli studi televisivi di Napoli più che per l’ambientazione inglese mimetizzata negli esterni nei paraggi di Londra. Molte battute scritte da Biagio Proietti di questo film di Negrin, già autore al cinema di Enigma rosso e per la tv de Il delitto Notarbartolo, offrivano volenti o nolenti lo spunto dilazionato per la curiosità in fieri di spettatori ancora non anestetizzati dall’overdose di serie. In altre parole musicalmente dense, nemmeno tanto “mutatis mutandis”, lo spessore di giallo trasversale e transnazionale effettivo proprio in quegli stessi giorni si consumava a Roma, da dove i principali responsabili della strage di Piazza Fontana, ricercati dai giudici di Milano, venivano “esfiltrati” a stretto giro in Spagna dai servizi segreti più o meno “deviati”.
La dose aggiuntiva di suspense da prima serata domestica che De Simone quindi riceveva come commissione in veste di compositore per il teleschermo si sarebbe cinque anni dopo riversata sul primo maxi-processo alla criminalità organizzata in Italia, ovvero lo scandaloso “processo indiziario” ai danni dell’allora invisibile Camorra, portata alla sbarra a tutti i costi per il delitto dei coniugi Cuocolo nella Napoli di inizio secolo. Lo storico processo Cuocolo, che fece il giro del mondo, fu una prova muscolare, spettacolare e politica che il capitano Carlo Fabroni consegnò all’aula di tribunale con la sua mirata crociata anticamorra. L’Unità d’Italia in procinto di festeggiare il suo primo cinquantenario voleva la testa dei camorristi a tutti i costi come pegno e per una volta, accusati ingiustamente da un cocchiere e testimone assai improbabile manipolato da Fabroni, finirono alla sbarra. Lo sceneggiato con Mariano Rigillo, Luigi Vannucchi e il non ancora trentenne Massimo Ranieri, diretto da Gazzara e musicato anche con cognizione di causa partenopea oltre che giudiziaria da De Simone era ufficialmente ricavato dal libro di Vittorio Paliotti La camorra, pubblicato nel medesimo anno, il 1973, di Lungo il fiume e sull’acqua; ma vantava come fonte insostituibile il celebre esempio di saggio-inchiesta di Roberto Marvasi, Così parlò Fabroni del 1914, con cui il giovane napoletano Francesco Rosi in veste di autore del soggetto inaugurò indirettamente il modello di film politico-indiziario italiano grazie a Processo alla città (1952) di Luigi Zampa, salvo poi diventarne l’autore cardine con Salvatore Giuliano (1962), Il caso Mattei (1972), Lucky Luciano (1973) e Cadaveri eccellenti (1976).
Non sfugga anche in questa circostanza l’effetto di una cronologia al cardiopalma che aggancia la messa in onda della prima puntata con gli ultimi giorni all’epilogo tragico del rapimento di Aldo Moro, seguendo quel sistema interno di combinazioni tutte italiane. Da un lato c’è dunque la partitura di De Simone per Storie della camorra a offrire materia acustica, retrodatata e genealogica a un cast composto anche da Isa Danieli nei panni letterari di Matilde Serao e Luigi de Filippo in quelli di Edoardo Scarfoglio, dall’altro l’offerta caduta nel vuoto dell’emergente boss Raffaele Cutolo della Nuova Camorra Organizzata nel vano tentativo di aiutare in tempo reale gli inquirenti a trovare il presidente della Democrazia Cristiana sotto sequestro. Se l’offerta di Cutolo era una tantum da “rifiutare” era non tanto perché poco disinteressata, dal momento che don Raffaele venne poi proficuamente consultato dai servizi per l’affaire del rapimento dell’assessore democristiano Ciro Cirillo, quanto perché Moro in quel frangente primaverile del 1978 “doveva morire”.