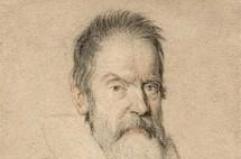«Il plagio artistico - scrive il musicologo Girolamo De Simone - non è altro che uno strumento di contaminazione, ricco di implicazioni giuridiche e filosofiche». E in effetti la storia della musica, da Bach ai Beatles, si è sempre nutrita di prestiti, imitazioni e metamorfosi: molto prima che la parola “plagio” evocasse tribunali, era sinonimo di omaggio, di continuità, di dialogo tra generazioni sonore. Già nel Medioevo, quando la musica si trasmetteva per via orale e il concetto di autore era quasi inesistente, le melodie migravano da un monastero all’altro. I canti gregoriani si ispiravano a modelli bizantini o mozarabici, e i trovatori riutilizzavano versi e formule melodiche comuni. Il Rinascimento, poi, fu un laboratorio di contaminazioni: Josquin Desprez, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria lavoravano spesso su temi preesistenti, trasformandoli in polifonie raffinatissime. Copiare significava continuare una tradizione, non tradirla.
E nel mondo classico? Copiare era addirittura un atto di rispetto. Händel prendeva a piene mani da Keiser o Stradella, e Bach trascriveva concerti di Vivaldi o Marcello, trasformandoli in veri laboratori di stile. Nessuno gridava allo scandalo: la prassi del riuso era il cuore del linguaggio barocco, dove un tema poteva rinascere mille volte. Mozart fece lo stesso con Haydn, e Beethoven con Mozart, passando il testimone della forma-sonata da un secolo all’altro. Brahms, infine, modellò la sua Prima Sinfonia sullo spirito della Nona di Beethoven, ammettendo ironico: «Qualsiasi sciocco può vedere che somiglia».
Nel Novecento la citazione diventa quindi poetica. Stravinskij costruisce Pulcinella su melodie di Pergolesi e colleghi napoletani del Settecento, inaugurando il neoclassicismo come estetica del furto consapevole. Respighi reinterpreta antiche arie per orchestra moderna, Mahler ingloba Bruckner, e Rachmaninov trasforma il virtuosismo di Paganini in una rapsodia febbrile. Tutto è memoria e rinascita: la musica, più che imitare, si reincarna.
Se il Romanticismo aveva trasformato l’autore in un demiurgo solitario, il Novecento riapre i confini. Erik Satie ironizza sulle Sonatine di Clementi, mentre Puccini ruba un tema di Rachmaninov per Turandot, e Cilea guarda a Debussy. «Rubato ma non troppo», direbbe Tito Aprea, in un suo interessante scritto del 1982: l’intera tradizione è un mosaico di frammenti che si inseguono. Perfino Berg, nel Wozzeck, non potendo plagiare un tema per via del sistema dodecafonico, copia un ritmo: quello della Pastorale di Beethoven.
Poi arrivò il pop, e con esso un nuovo tipo di saccheggio, spesso inconsapevole ma potentissimo. A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum nasce dall’eco bachiana del Contrappunto in re minore; Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley deriva dal settecentesco Plaisir d’amour; Eric Carmen costruì All by Myself sul Concerto n. 2 di Rachmaninov, tanto da doverne pagare i diritti. John Lennon chiese a Yoko Ono di suonare il Chiaro di luna beethoveniano al contrario: così nacque Because dei Beatles. Freddie Mercury aprì It’s a Hard Life con un tributo al compositore Ruggero Leoncavallo, mentre i Muse confessano il loro debito verso Paganini.
De Simone lo ha spiegato con chiarezza: nella musica contemporanea la contaminazione non è un incidente, ma una condizione strutturale. In un mondo in cui la riproducibilità tecnica - da Benjamin in poi - moltiplica all’infinito i modelli, ciò che conta non è l’origine ma la trasformazione.
Oggi, nell’epoca del sampling e della rete, il plagio ha assunto una nuova forma: frammenti di canzoni, jingle pubblicitari, suoni antichi e glitch digitali si fondono in un’unica materia. Dal jazz che rilegge Puccini alle world music che mischiano Bruckner e ritmi africani, fino agli algoritmi che generano melodie “alla maniera di”, tutto si muove in un’eco globale. L’autore arretra, la memoria collettiva avanza. Così, dal contrappunto di Bach alla tastiera elettrica di Lennon, la storia della musica può leggersi come una lunga catena di plagi virtuosi: appropriazioni, citazioni, metamorfosi che sfidano l’idea stessa di proprietà. Ogni nota nasce da un’altra, e nessuna appartiene davvero a qualcuno. Forse è questo il segreto più profondo della musica: essere, da sempre, un’arte collettiva che si nutre di sé stessa.
E mentre il diritto d’autore tenta di rincorrere l’inafferrabile fluidità del suono, la musica continua a mescolare i suoi geni, a confondere le sue origini, a riscrivere sé stessa. Perché ciò che chiamiamo plagio, in fondo, è solo il modo che la musica ha di ricordare il mondo che l’ha creata: un atto di memoria, più che di colpa; un dialogo infinito tra chi ascolta e chi, da secoli, continua a reinventare il silenzio.