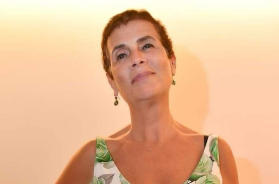In questi giorni si parla molto di perdite idriche negli acquedotti (che chiameremo per semplicità perdite) anche a causa della siccità che ha colpito gran parte dell’Italia. Il problema delle perdite, però, ha origine nello scorso secolo poiché è relazionato al naturale deterioramento con l’età delle infrastrutture. Lo si sta affrontando oggigiorno sotto l’impulso del varo del sistema regolatorio ARERA e dei fondi specifici messi a disposizione dal PNRR ed EU-REACT in specifico per il Mezzogiorno.
Inoltre, la consapevolezza sociale del problema delle perdite è cresciuta negli ultimi anni insieme alla sensibilità rispetto ai temi generali di sostenibilità socioeconomica ed ambientale delle opere ingegneristiche in relazione al naturale invecchiamento di tali sistemi.
Durante il prossimo lustro si prevedono ingenti investimenti per la riduzione ed il controllo delle perdite, che si stimano in più di due miliardi di euro. Si tratta di investimenti pubblici su infrastrutture di proprietà pubblica i cui attuatori sono i gestori del servizio idrico specifico attraverso le autorità idriche regionali.
Il tema della spesa in qualità è, quindi, rilevante sia da un punto di vista tecnico che sociale, interessando le future generazioni poiché laddove non si affronti in modo appropriato il tema delle perdite, oggi, esso rimarrà un fardello per i nostri figli.
Domande spontanee del cittadino sono: cosa sono le perdite? è vero che gli acquedotti sono colabrodo? Le affrontiamo cercando i «buchi» che le determinano? indicarle in percentuale è corretto?
Per rispondere alle precedenti domande è necessario comprendere la natura fisica delle perdite. Esse sono, dal punto di vista idraulico, forellini (efflussi torricelliani) caratterizzati da una specifica portata (volume di acqua nel tempo) che è generata dall’area del foro e dalla pressione locale. Le perdite si originano nelle tubazioni, nei giunti e nelle connessioni alle proprietà a causa del fisiologico deterioramento dei materiali che ha come forzante esterna i fenomeni di moto vario, le variazioni di pressione di esercizio, il traffico veicolare, le variazioni di temperature, ecc. La distribuzione spaziale dei «forellini» non è nota. Le perdite complessive in un acquedotto sono, quindi, determinate dai singoli volumi d’acqua persa localmente legati alla grandezza del foro di efflusso e alla pressione locale. L’età dei singoli acquedotti gioca un ruolo fondamentale nel numero di forellini e dimensione così come la storia gestionale e di esercizio quotidiano dello stesso acquedotto. La pressione locale ai singoli forellini genera i volumi d’acqua persa che, dunque, aumentano al crescere della stessa pressione in modo approssimativamente lineare.
La criticità delle perdite è relativa al fatto che gli acquedotti sono interrati. Se non misuriamo i volumi d’acqua in ingresso agli acquedotti e non valutiamo con attenzione i volumi di consumo non vediamo gli effetti delle perdite.
Pertanto, le perdite possiamo immaginarle come una popolazione di «forellini» di varia grandezza presenti nei singoli acquedotti. Per fortuna non tutti questi fori producono uscite di acqua importanti, ma molti sono gocciolamenti impossibili da rilevare come quando in un bagno, per esempio, facciamo l’esperienza della ricerca di una perdita che produce umidità sul pavimento. Per fortuna solo una piccola frazione dei fori produce volumi d’acqua più importanti.
La popolazione di forellini, dunque, può essere distinta in due «categorie» quella che singolarmente genera piccoli efflussi (gocciolamenti) di perdita di acqua, non rilevabili, e quella che genera efflussi di perdita maggiori (che producono un volume di acqua persa non maggiore del 20%, ma generalmente minore), rilevabili attraverso fattori fisici correlati come quelli acustici. Le singole perdite maggiori sono comunque l’evoluzione dei «gocciolamenti», in modo graduale, ma condizionato da fattori esterni (traffico veicolare, etc.) e di esercizio quotidiano degli acquedotti.
Quindi, è errato associare alle perdite degli acquedotti l’immagine di un sistema simile ad un colabrodo, ma, d’altro canto, non possiamo affrontare il problema delle perdite cercando pochi buchi che le determinano poiché nella gran parte sono irrilevabili (gocciolamenti).
Ma allora perché sono così alte? Più del 30% del volume immesso?
Innanzitutto, è necessario ricordare che i volumi annuali sono la somma di gocciolamenti diffusi che producono il loro effetto in più di 30 milioni di secondi (ovvero quelli in un anno). Inoltre, esse sono diffuse in una lunghezza di tubazioni che nel caso di un piccolo comune è già superiore alla decina di chilometri. Insomma, abbiamo tanti e tanti «bagni sotto terra» che hanno gocciolamenti e tutti noi abbiamo sperimentato come si riempia rapidamente una vaschetta sotto un lavandino che gocciola.
Pertanto, senza entrare nel merito tecnico-scientifico che è discusso in dettaglio in un articolo di Servizi a Rete del c.m., è improprio valutare le perdite in percentuale dei volumi di acqua immessa negli acquedotti poiché esse sono legate alla diffusione in lunghezza di tubazioni del sistema. Peraltro, in un comune che aumenta il numero di abitanti in estate le perdite in percentuale scendono drasticamente poiché aumentano i consumi di utenza senza che ci sia una coerente riduzione delle stesse in valore assoluto rispetto all’inverno.
Allora le perdite non vanno affrontate semplicemente individuando le tubazioni con maggiore propensione alle perdite, cosa peraltro affatto semplice, oppure immaginando di ricercare le singole perdite oppure semplicemente sostituendo le tubazioni che hanno avuto più rotture nel passato. È necessario ingegnerizzare il sistema facendosi aiutare nella spesa di qualità dai dati di monitoraggio, dalla modellistica idraulica e laddove utile dalla tecnologia senza sperare che ci siano scorciatoie ovvero soluzioni semplici a problemi complessi come spesso la natura umana è incline ad immaginare. Dal punto di vista del gestore, si tratta di disegnare una nuova organizzazione aziendale che affronti in modo anche strategico, quindi non solo nel breve ma anche nel lungo periodo, un problema tecnico del tutto nuovo e complesso.