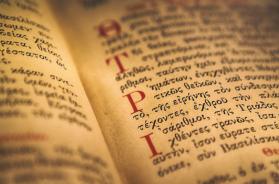BARI - Alessandro Laterza, editore, già vicepresidente di Confindustria con delega per Sud, che spaccato del Mezzogiorno emerge dalle ultime rilevazioni dello Svimez?
«Il primo elemento è molto chiaro. Il Sud ha tenuto il passo della ripresa del Paese nella fase post Covid. Suscita riflessione e preoccupazione che il contributo del Meridione alla crescita nazionale è in gran parte compreso nei servizi a basso valore aggiunto, nel turismo e nelle costruzioni. Solo in piccola parte nell’industria. Più servizi e edilizia, meno industria: questa è la sintesi».
Cosa allarma?
«È noto che il motore degli sviluppi dello sviluppo, dell’innovazione, dell’export in tempi lunghi è allocato nell’attività industriale. I numeri del Sud sono buoni nel complesso, ma risentono di questo squilibrio settoriale rispetto al Centronord. In più, il costo del denaro sta aumentando vertiginosamente e questi andamenti favorevoli potrebbero essere rallentati da carenze di liquidità».
In ballo c’è anche l’autonomia differenziata.
«Per come si configura è difficile che porti elementi positivi nel Mezzogiorno. È un po’ difficile al momento trovare un punto di equilibrio tra i Lep e le effettive dotazioni delle regioni. Il dossier va chiarito nei minimi termini ma l’impianto non convince».
Si discute di salario minimo. Da dove partire?
«Il tema riguarda il rapporto tra contratti collettivi nazionali e un mondo in cui si applicano alla luce del sole condizioni retributive molto più basse. C’è la consapevolezza che nove euro all’ora sia una cifra inadeguata, ma va valutato l’impatto di una novazione sulla contrattazione nazionale. Il vulnus resta quello di tre milioni di italiani, un terzo dei quali nel Sud, pagati con salari da fame. E parliamo di lavoro regolare o classificabile come tale».
Le eccellenze ci sono anche in Puglia.
«In controtendenza brillano nel Sud novantamila imprese nella strategia di specializzazione smart in materia di prospettiva futura secondo l’Ue: sono nei settori di energia e ambiente, agroalimentare, Tac, chimica verde e farmaceutica, meccatronica, aerospazio».
La prospettiva della Zes estesa?
«Vediamo come si configura. Il ministro Fitto vuole trasformare tutto il Sud in una Zes. Può essere una opportunità positiva, e può essere una soluzione per rispondere alla domanda di compensazioni legata agli squilibri meridionali. Nel mondo imprenditoriale c’è grande entusiasmo per le Zes, bisogna valutare gli investimenti pubblici e la durata temporale. L’allargamento del perimetro può essere una leva utile se la si incrocia con settori produttivi moderni che possono incrementare la partecipazione dell’industria nella formazione del Pil del Sud».
Il Pnrr?
«Ci sono tante stime per il Sud, e l’impatto sul Pil sarà rilevante e positivo. Mi interessa capire se avrà un effetto congiunturale o se favorirà un miglioramento duraturo del contesto civile e economico del Sud. Bisogna con attenzione cogliere come si incrociano le linee di intervento del Pnrr con i fondi europei e quelli nazionali di Coesione. Fondi che vanno azionati».
Vent’anni fa iniziava a muovere i primi passi della Primavera pugliese, con gli incontri di Franco Cassano e della cittadinanza attiva presso la libreria Laterza. Che ricordi le tornano in mente?
«Parliamo di esperienze che risalgono ad un movimento di riflessione suscitato dalle proposte di Franco Cassano, intorno al Pensiero Meridiano. È una stagione che appartiene al passato. Resta inutile rimpiangerla ma ha avuto un merito che a tutt’oggi potrebbe essere valorizzato, ovvero esprimere un forte invito al Sud affinché pensi se stesso e i propri modelli di sviluppo, anche dal punto di vista economico e civile».
È nata però una stagione politica che dura da vent’anni.
«Quella lezione è stata rilevante, una base di partenza notevole. In un momento in cui il Sud era silente, quella riflessione ha fatto rumore e ha messo in moto dei pensieri. Quanto si sia tradotto in flussi elettorali, è difficile dirlo».
Nichi Vendola e Michele Emiliano…
«Si ispirarono alle idee di Città plurale, ma i piani del consenso elettorale e della produzione delle idee non coincidono automaticamente. Franco Cassano indicava inoltre scenari più larghi nel Mediterraneo poi scontrati con le grandi sorprese e delusioni delle Primavere arabe».
Il Piano Mattei di Giorgia Meloni sembra cogliere alcuni elementi di quella riflessione politica.
«In questo caso si vuole frenare l’immigrazione e bisognerà misurare gli stanziamenti. Se si tratta di comprare il consenso di leader locali per frenare i flussi migratori non è un grande progetto; se si fonda su una virtuosa cooperazione euromediterranea acquisirà grande rilievo, ma ci vuole una visione non solo teorica ma anche economica«.
C’è il rischio di cadere nella retorica dei giudizi stereotipati sulle classi dirigenti?
«Quando mi capita di osservare fatti legati alla politica locale e nazionale e sento giudizi sul “basso livello della politica” credo che si configuri una forma di moralismo qualunquistico e borbottone».
Come stanno le cose?
«Il livello della vita politica è esile, non alto o basso. Il parametro è la densità del pensiero».
Adesso in Puglia siamo alla fine del doppio mandato di Emiliano e Decaro.
«E tutto ruota intorno al tema del terzo mandato per Emiliano e Decaro, che allo stato non è previsto normativamente. A destra e a manca mi pare che non si attenda che l’ardua sentenza. Non è un tema appassionante».
La Giusta causa si ispira a Città plurale.
«È una testimonianza bella di partecipazione ma la cornice politica resta, a mio avviso, quella che ho detto».
A livello nazionale?
«C’è una opposizione divisa che dà maggiore forza alla destra di governo. Sulla vita degli esecutivi nazionali pesano però molti fattori esterni non controllabili, come immigrazione, cambiamento climatico, l’economia e la finanza internazionale, le politiche deflattive praticate a livello mondiale con effetti sui territori, senza dimenticare la guerra a Kiev. Anche chi è gloriosamente in sella corre costantemente sul filo del rasoio».
La politica cosa può fare?
«Proprio perché ci sono tanti fattori esterni in campo, c’è un nodo su cui è utile riflettere: cosa sono sia l’interesse nazionale sia l’interesse territoriale. Se la politica, qui come a Roma, è di spessore esile e sotto costante pressione di fattori esterni si trasforma in organizzazione del consenso di gruppi di interesse più o meno consistenti. Niente di male, sia chiaro. Ma la somma degli interessi particolari, sui quali la destra sta indubbiamente agendo in modo più efficace, difficilmente può tradursi in una solida visione di interesse collettivo sia su scala locale sia su scala nazionale».