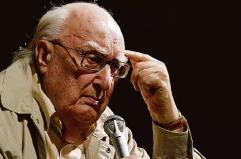Il mare è una frontiera, almeno a Gaza. Uno spazio liquido di libertà e speranza, un orizzonte inafferrabile sul cui limite le case restano in piedi, come legate da un filo invisibile al tetto del mondo. L’acqua e il cielo, un gioco di specchi. Senza porte. Lo sa bene Tariq, giovane palestinese in fuga. Non è quello il suo nome, è un significante piuttosto: “Colui che bussa alla porta”. Ma quale porta? Nella Striscia le porte non ci sono più, travolte dal nomos della guerra che le chiude per sempre, da dentro (Hamas) e da fuori (Israele). Non è facile capire dove andare. La strada più semplice è quella che conduce al cielo: lì non si chiede permesso, si entra senza complimenti. Buttati dentro. In tanti a Gaza hanno preso la via del cielo, spediti dalle solerti macchine di morte, umane e meccaniche, ma, è noto, chi è in guerra “corteggia la vita”. E allora Tariq si convince che la vita sia vicino al mare e si mette in cammino.
Il viaggio dalla sua casa di Beit Hanoun fino alla costa non è (solo) un viaggio. È un inarrestabile flusso di coscienza lungo 120 pagine in cui si affastellano ricordi, riflessioni, memorie, constatazioni dolorose e considerazioni geopolitiche. Perché Tariq non è un nome vero né una persona vera. Ma una verità scomoda che, questa sì, bussa alla porta delle coscienze addormentate. Gaza. L’altro olocausto (Il Poligrafo) è il potente romanzo di Gianfranco Longo, docente di Filosofia della Pace all’Università “Aldo Moro” di Bari, recentemente insignito del Premio Kafka Italia alla Cultura (2025). La forza del volume è già nel titolo, naturalmente, primo ingresso senza sconti in un conflitto che non è soltanto mattanza di carne e sangue, ma guerra di parole. E di ipocrisie. Tariq è solo nella notte del mondo. Viaggia con ai piedi due ciabatte di plastica troppo grandi per lui. Ha il problema di mangiare, di dormire, di dissetarsi. Si ritorna all’essenziale. «La guerra ci fa tutti più magri», scrive spesso Massimo Fini. Compaiono saltuari compagni di viaggio, presenze rapsodiche, ognuno con un significato che si dilegua. Tanti lo accompagnano nella mente, come la «retta guida» Rashid, «colui che ha raggiunto l’età matura». Una specie di Virgilio immateriale che guida questo Dante postmoderno nei gironi dell’inferno gazawi. Niente è scontato, però. La guerra porta via i nomi, taglia le radici, cancella gli orizzonti, pareggia le differenze anagrafiche, affila i pensieri. Nessuno è più nessuno, tutti sono tutti. Chi è Tariq? Chi è Rashid? Chi sono io? Lo scoprirà il lettore, pagina dopo pagina, strada dopo strada.
La lettura non è semplice, le banalizzazioni binarie da bar dello sport non trovano cittadinanza. E non certo per equilibrismo peloso. Semplicemente, il nomos della guerra ha due facce. La prima è quella dell’Idf, l’esercito israeliano con la sua meccanica ferocia. La seconda è quella di Hamas che uccide bambini, tortura, perseguita, arruola coloro che non ritornano. C’è chi uccide Gaza dal cielo e chi la dilania dall’interno. Nelle pieghe del discorso, Longo sussurra una traccia che non si può gridare: «Raschid sosteneva che (Hamas, ndr) beccava finanziamenti dal Mossad». E d’altronde fa sempre il suo gioco apparecchiando la tavola per la repressione. Gli uni e gli altri sono combattenti che non difendono, attaccano soltanto, facendo girare la stessa ruota («non lavorerei mai per gli israeliani, non mi metterei mai sotto la protezione di Hamas», confessa il protagonista). Basterebbe questo, ma il nomos è ancora di più. È una sorta di Giano rovesciato, oscuro. Proprio come l’antico dio bifronte ha una terza faccia nascosta che il primo assaggio non coglie. Una faccia deforme, cioè quella di «regnanti che continuano a pontificare, fingendo struggimento, tra pianti e canti massonici». Da Srebenica a Gaza balla sugli orrori della Storia con quel sentimentalismo delle occasioni perdute. O lasciate perdere. La civiltà euroatlantica, «stizzita di tante noie», ha responsabilità immense che rimbombano nella Striscia come a Kiev. Diffonde «cultura fentanylica», si addormenta nei cortei, si accende di militarismo e si compensa in un pacifismo da sfilata sul red carpet. Una parata delle cattive coscienze. Siamo noi, inconfessati a noi stessi.
Alla fine, lo sguardo dei tre volti incrocia quello degli inermi, gli sventurati figli del nomos destinati a marciare e marcire senza direzione. Non ci sono porte a cui bussare né fogli su cui scrivere. Le case crollano sotto i colpi di chi attacca ma non sa proteggere. E le strade si scoprono impolverate di silenzio. «No, dovrei dire che c’era una polvere di sacrificio. Di olocausto».