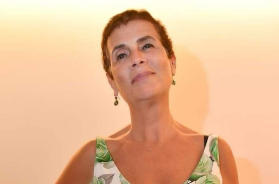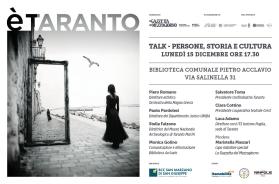Naturalmente uno che ha esclamato più di una volta «Amo le triglie di scoglio», non può che essere, da parte dei baresi e pugliesi in genere, automaticamente annoverato nell’Olimpo dei Supereroi: parliamo di Andrea Camilleri e del titolo del libro di ricordi e di varia aneddotica che gli hanno dedicato Bruno Luverà e Vincenzo Mollica (ed. Rai libri) in questo fatidico 2025 del centenario dalla nascita. Le triglie, il piccolo Andrea Calogero (Calogero il nome del patrono potentissimo di Porto Empedocle!) le andava a pescare dalla barca, di notte, insieme al padre Giuseppe, l’ispettore al porto, quello che aveva fatto la Marcia su Roma, fascistissimo eppure integerrimo, amatissimo dall’Andrea antifascista e comunista.
Avevano pescato insieme, nelle stesse acque siciliane, su quel Mediterraneo di miti greci, forse già teatrali, con alle spalle quella lontana parentela con tale Luigi Pirandello, cugino della nonna paterna Carolina. Un Pirandello in divisa da Accademico (alamari e ramages d’ argento, spadino e feluca con piumette) che il ragazzino Andrea, magari dopo una nottata a pescare triglie, si trovò davanti sulla soglia di casa, quando il Nobel passò da casa Camilleri per salutare, dopo una cerimonia a Porto Empedocle. Destini. Miti che si rincorrono.
Correva l’anno 1941quando già il sedicenne Camilleri metteva in scena nella Agrigento bellica Crispino e la comare, un libretto di Francesco Maria Piave, mentre l’anno dopo (1942) presentava a un concorso-raduno dei giovani fascisti a Firenze Le Montagne, commedia di Giuseppe Romualdi; Camilleri si piazzò secondo, vincitore un tale Giorgio Strehler! Nel 1944 addirittura il nostro mette in scena una rivista, Poker d’ assi, nella Agrigento e nel suo teatro pieno di americani. Più che normale poi che nel 1948 il Nostro partecipi con una commedia di suo pugno, Giudizio a mezzanotte, a un concorso a Firenze con presidente di giuria Silvio D’ Amico: arriva primo, ma della commedia non v’ è traccia, dato che lo stesso Camilleri, scontento, la gettò via. Perseguitato dal “vizietto” del teatro, il giovanotto si iscrive nel 1949 al primo corso di regia istituito nell’Accademia d’ Arte drammatica a Roma, ancora diretta da D’ Amico. A seguire verranno la collaborazione con Orazio Costa, l’ingresso in Rai e le innumerevoli regie (1300 in radio, 80 in Tv, 120 in teatro) insieme all’insegnamento presso l’Accademia fino al 1997.
Come incastonata nel mezzo di cotanta attività, si impone la “stagione barese” di Camilleri, tra il 1955 e il 58, quando è già stato assunto in Rai (dapprima rifiutato, in quanto “comunista”!) e quando in specie mette a frutto l’amicizia e la stima del vecchio maestro Orazio Costa. È infatti lui, Costa, che se lo trascina a Bari come aiuto-regista in Assassinio nella Cattedrale di Eliot, che debutta al Piccinni il 25 dicembre del ‘56. Esito non trionfale (un debutto il giorno di Natale, a Bari!) sotto l’egida di un Teatro Stabile diretto da Giuseppe Giacovazzo, ma che fa apprezzare il giovane Camilleri, che rieccolo come regista in altre produzioni promosse da Giacovazzo: Il topo di Carlo M. Pensa (Teatro Piccinni, 1957), Perfetto amore di Roberto Bracco (T. Piccinni, 1957), Zona grigia di Giovanni Calendoli (T. Piccinni, 1958), L’innocenza di Camilla di Massimo Bontempelli (T. Piccinni, 1958).
Nel frattempo Camilleri, assunto in Rai come direttore degli allestimenti e programmista-regista, collabora con la sede Rai di Bari, mentre presumibilmente continua a far strage di triglie di scoglio. Certo le avrà degustate, le triglie, quando ad Otranto nel luglio 1980 diresse la messinscena di Ottocento volte no, testo di Roberto Mazzucco dedicato alla vicenda dei Martiri idruntini durante l’assedio turco del 1480. Vi prese parte (era allievo di Camilleri all’Accademia di Roma) anche il debuttante Sergio Rubini.
Non fu l’ultima volta che Camilleri “passò” in Puglia, per carità. Numerose le vacanze in Valle d’ Itria, magari dentro un trullo, edificio di cui molto apprezzava la ricurva “rotondità”, analoga a quella placida e morbida rotondità delle forme da lui praticata e perseguita. Sovrapposta però ad una puntuta e affilata spigolosità delle idee, dei valori, della morale civile di fondo. A voler riportare l’effettivo ultimo passaggio di Camilleri in Puglia, va ricordata quella master-class che tenne al Petruzzelli nell’ambito del Bi&fest nell’aprile 2014, quando si dovettero chiudere le porte con la forza pubblica, per fermare la gente che voleva entrare in teatro.
Porte, del Piccinni e del Petruzzelli, che si riapriranno in Bari il 12 e il 13 ottobre, per letture, reading, musiche jazz e altre memorabilia camilleriane. Al Piccinni, il 12, immagine e voce di Camilleri nella proiezione di quella Conversazione su Tiresia che vide, Teatro Greco di Siracusa nel 2018, il Grande Vecchio Cieco dialogare col cieco Tiresia, attraverso i testi e attraverso i secoli.