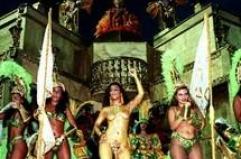Prima ancora che approdasse con successo al Teatro Piccinni di Bari, nel 1976 La Gatta Cenerentola e di conseguenza il suo autore Roberto De Simone “abitavano” già nella mia fantasia di quindicenne. Forte di un’amicizia col compositore Giancarlo Menotti che, negli anni, sarebbe diventata quasi fraterna, mio padre era solito frequentare il Festival dei Due Mondi di Spoleto sin dai primi Anni ’70, trasferendosi nella cittadina umbra per l’intera durata della manifestazione. E appunto a Spoleto, nell’estate del 1976, era andata in scena in prima assoluta l’opera di De Simone, della quale mio padre parlava sempre con toni entusiastici a quanti, una volta rientrato, gli chiedevano cosa avesse visto di interessante al Festival. Erano del resto gli anni d’oro della kermesse umbra che, sotto la guida di Menotti, si era imposta all’attenzione internazionale. Per restare in ambito partenopeo, basti ricordare che un anno dopo, nel 1977, l’inaugurazione spoletina vide in scena l’opera Napoli Milionaria tratta da Eduardo – che ne curò anche a regia - con le musiche di Nino Rota. Ma tornando a De Simone, la cui fama di autore, intellettuale e profondo conoscitore della musica e delle tradizioni popolari meridionali era di dominio pubblico, mai e poi mai avrei immaginato di poterlo ascoltare, molti anni dopo, in veste di jazzista. Il suo nome, a capo di un trio di pianoforte, basso e batteria, venne inserito negli Anni ’90 del secolo scorso durante un’edizione del festival “Rumori Mediterranei” di Roccella Jonica. E proprio il ricordo di quella inattesa performance mi aiutò a rompere il ghiaccio allorché, nel 2000, incontrai a Bari il maestro napoletano, fresco direttore artistico dell’Orchestra della Provincia di Bari: ero stato incaricato di redigere le note musicali sui programmi di sala e, di conseguenza, dovevo sentirlo settimanalmente per avere informazioni su autori e composizioni. De Simone, che aveva da poco lasciato la direzione del Conservatorio napoletano di San Pietro a Majella, aveva accettato l’incarico con entusiasmo, ma anche con la precisa intenzione di operare scelte musicali coerenti con il suo spirito di contaminatore. Fu così che, accanto a programmi sinfonici di stampo più “tradizionale”, si unirono proposte decisamente innovative a cominciare dalla Populorum Progressio, la cantata realizzata dallo stesso maestro sui testi dell’enciclica di papa Paolo VI e andata in scena nella basilica di San Nicola con un cast di tutto rispetto che annoverava, tra gli altri, la voce recitante di Michele Placido e l’intervento del duo pianistico di Bruno Canino e Antonio Ballista. E ancora, andrebbero ricordati almeno lo Sconcerto per contrabbasso e orchestra di Armando Trovajoli – che venne a Bari apposta per ascoltarne l’esecuzione -, un Bollani “sinfonico” affidato alla cura e agli arrangiamenti di Paolo Silvestri e persino un recuperato Sergio Endrigo. A proposito del cantautore istriano, De Simone mi spiegò di averlo invitato con l’Orchestra per rendere omaggio «a un punto di riferimento in quel vasto movimento culturale degli Anni ‘60 e ‘70, a quei fermenti che videro coinvolti artisti notevoli, come ad esempio, Pierpaolo Pasolini». Fu una permanenza breve quella alla guida dell’Orchestra, ma sempre scandita da grande curiosità intellettuale, dal desiderio costante di contaminare e, perché no, all’occorrenza anche provocare. E a proposito di provocazioni, ci rivedemmo sempre a Bari nel 2009, quando De Simone, incaricato di curare la regia della Turandot per il rinato Petruzzelli, volle riscrivere il finale dell’opera – notoriamente incompiuta – sostituendolo a quello classico di Franco Alfano. «Da quando ero studente – mi spiegò – il finale di Alfano mi piaceva poco, lo trovavo enfatico e fuori dal contesto del mito che caratterizza la vicenda. Ho visto Turandot come un personaggio vindice di un’antenata stuprata e di conseguenza ho concepito il nuovo finale come un esorcismo nei confronti della possessione che la attanaglia». Quel finale, in realtà, non venne mai rappresentato perché sorsero dei problemi mai del tutto chiariti con l’editore Ricordi. Il maestro, pur non volendolo ammettere, ne fu amareggiato e quando tornammo a parlarne, preferì glissare, proiettando il proprio pensiero oltre quell’episodio. «Qualcuno sostiene – mi disse congedandomi - che Turandot rappresenti la fine del melodramma italiano, io invece credo che mai come oggi ci sia bisogno di un nuovo teatro musicale. Con la Gatta Cenerentola, ho lavorato nella direzione di un rinnovamento della forma melodrammatica, senza utilizzare voci liriche tradizionali e lo stesso ho fatto più recentemente con Là ci darem la mano, una riscrittura del Don Giovanni di Mozart che abbina voci liriche con strumenti elettrici». In quell’ultimo caso, però, nessuno ne aveva bloccato la messa in scena.

Teatro Petruzzelli
Lunedì 14 Aprile 2025, 05:00