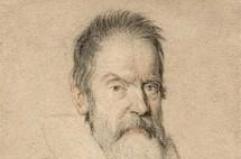La storia culturale non è soltanto la sovrapposizione o la combinazione di itinerari di ricerca individuali. Quando ci si accinge a interrogarla e a scoprirla, non si tratta solo di dipanare una meravigliosa matassa fatta di singoli fili, ma di esplorare una trama che, spesso, si rivela composta da fili doppi, da congiunzioni che superano la mera sommatoria di due singolarità. È il caso dell’esemplare rapporto d’amicizia e intellettuale che ha visto unite due figure di primissimo piano della cultura europea della prima metà del XX secolo: Walter Benjamin (1892-1940) e Bertolt Brecht (1898-1956).
Filosofo dai profondi interessi letterari e teatrali, il primo, drammaturgo dalla vocazione filosofica, il secondo, entrambi, nel loro costante dialogo, hanno contribuito a esaminare e a definire questioni, concetti e pratiche che, nei decenni successivi, avrebbero fortemente influenzato gli sviluppi della ricerca filosofica e di quella teatrale. Pubblicato da Kaiak Edizioni, Benjamin e Brecht. Storia di un’amicizia di Erdmut Wizisla (direttore dell’Archivio Bertolt Brecht e dell’Archivio Walter Benjamin) di questo rapporto ne ricostruisce l’evoluzione e le caratteristiche, tratteggiando il quadro non solo intellettuale, ma anche storico e politico, di una stagione tanto socialmente drammatica quanto culturalmente produttiva. Questo corposo lavoro, pubblicato per la prima volta nel 2004, è ora disponibile anche in lingua italiana, grazie alla perizia stilistica e alla cultura del regista teatrale e poeta Fabio Tolledi, che ha curato, tradotto e introdotto il testo, e alla lungimiranza dello studioso di estetica ed editore Vincenzo Cuomo.
Fondamentali, nel libro, sono gli ultimi due capitoli, dedicati agli undici interventi di Benjamin sull’opera di Brecht e alle opinioni di Brecht su Benjamin che comunque, come scrive l’Autore, «non costituiscono una controparte ai saggi di Benjamin su di lui». Emerge un dialogo estremamente profondo e produttivo, che ha trasformato alcuni temi di confronto, come il teatro epico, il gesto o l’eroe non-tragico, in fecondi punti di convergenza. Parallelamente a questo, Wizisla ripercorre il processo di intensificazione del rapporto personale tra i due, legato tanto al comune esilio a Parigi quanto ai periodi in cui il drammaturgo ha ospitato il filosofo a Skovsbostrand, in Danimarca, nelle estati tra il 1934 e il 1938.
Il libro, tradotto con eleganza e introdotto con efficacia da Tolledi, si arricchisce di diversi documenti che ricostruiscono il tentativo fatto da Benjamin e Brecht, insieme ad altri intellettuali – come il critico cinematografico e teatrale Herbert Ihering o i filosofi György Lukács ed Ernst Bloch –, di dare vita a una rivista che si sarebbe dovuta intitolare Krise und Kritik. Si tratta di un libro realmente prezioso, non solo perché contribuisce – e già questo sarebbe di per sé meritorio – a penetrare e a interpretare le costellazioni intellettuali di due giganti della cultura del Novecento, ma anche perché ci fornisce strumenti utili per abitare un tempo, il nostro, che sembra lasciare sempre più spazio a derive politiche che potrebbero rivelarsi pericolose e rispetto alle quali potremmo riscoprirci impreparati.