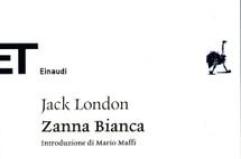In quel capolavoro della filosofia del Novecento che è Dialettica dell’illuminismo, Horkheimer e Adorno hanno esemplarmente argomentato come l’intero cammino dell’umanità sia caratterizzato dal tentativo di controllare la natura esterna, sebbene a un preciso costo: il sacrificio di quella interna, sacrificio rispetto al quale Odisseo appare ai due studiosi come un esempio eminente.
Ulisse, mosso dalla volontà di ascoltare, senza rimanerne vittima, il letale e seducente canto delle sirene (natura esterna), si fa legare all’albero della nave, auto-reprimendo la propria libertà (natura interna). In questo caso, il controllo su ciò che è esterno implica il controllo su di sé. A questo che potremmo considerare un controllo radicale (fatto anche di autorepressione) corrisponde oggi la totale mancanza di controllo. Tale situazione determina un dualismo che poco ci aiuta a compiere esperienze davvero sensate.
Queste prime osservazioni ci consentono di avvicinarci a un tema, quello del controllo, che costituisce il cuore pulsante di Sotto la soglia del controllo. Pratiche artistiche e forme di vita, da poco pubblicato da Laterza. In questo suo libro, Stefano Velotti – ordinario di Estetica a La Sapienza, da sempre interessato a esplorare questioni all’incrocio tra estetica e filosofia sociale – intende indagare le forme con le quali il controllo si presenta nelle nostre vite, non esclusivamente in relazione alle norme previste dalle leggi, ma anche rispetto al rapporto che ognuno di noi ha con sé stesso.
Il nodo problematico verso cui Velotti orienta il proprio sguardo, estremamente penetrante, consiste nel fatto che la relazione tra controllo e non controllo non dovrebbe comportare un’alternativa, un rapporto oppositivo, quanto invece un’interazione dinamica e cumulativa. L’ipotesi proposta dall’Autore è la seguente: oggi non è tanto «una “dialettica del controllo” a essere socialmente più diffusa e allarmante, quanto una mancanza di cooperazione tra controllo e non controllo, un blocco tendenziale della loro necessaria interazione» (p. 6).
Se, nel primo capitolo, articola un serrato dialogo con grandi autori come Simmel, Lukács, Weber, Heidegger, Kant, Dewey, Garroni e Noë, l’Autore, nel secondo e terzo capitolo del libro, analizza i lavori di due artisti: Tehching Hsieh e Thomas Hirschhorn. Nel caso di Hsieh, Velotti si sofferma sulle quattro performance realizzate dall’artista taiwanese tra il 1978 e il 1984, tutte chiamate One Year Performance. Dal momento che implicano una privazione (contatti con il mondo, concentrazione e riposo, riparo, privacy), ciascuna di esse incarna o manifesta «esemplarmente quell’intreccio tra controllo e non controllo che intesse le nostre vite».
All’indagine di questo specifico rapporto tra controllo e incontrollabilità, che Velotti “legge” anche attraverso il filtro di I Ching, uno dei cinque testi fondamentali del confucianesimo, segue poi l’analisi dell’opera di Hirschhorn, che dichiaratamente lavora “sotto la soglia del controllo”. In particolare, nei suoi Pixel-Collage, l’artista svizzero interviene su immagini anonime di violenza con la pixelazione o con la de-pixelazione. L’obiettivo, tra i diversi rintracciabili in queste opere, è quello di «rendere manifesta l’incommensurabilità degli elementi che appartengono al nostro mondo comune» (p. 158), non occultando (con i pixel) la crudezza e la durezza di un corpo distrutto, ma riappropriandosi «della visibilità del mondo, censurata, manipolata, da parte di chi si arroga un’autorità paternalistica e moralistica per proteggere “il pubblico”» (p. 159).
La rilevanza delle argomentazioni proposte da Velotti lasciano emergere questioni che ci riguardano, che chiamano in causa i modi in cui si articola la nostra relazione con noi stessi e con il mondo e i nostri tentativi di dare un senso alle esperienze che facciamo. In molte situazioni, ci suggerisce l’Autore, tra controllo e non controllo dovrebbe esserci una proficua e dinamica relazione di complementarità e di rilancio, non di conflittualità. Il nostro adattamento, naturalmente, ne risulterà non del tutto riuscito, non compiuto definitivamente e sempre in divenire.
Ma, se questo parziale disadattamento è fonte di ansia e di inquietudine, è anche «condizione della nostra vitalità, plasticità e creatività» (p. 19).