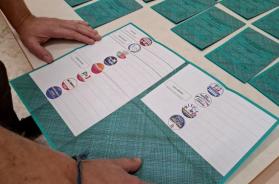Secondo il Governo e secondo Confindustria, il reddito di cittadinanza ha il solo effetto di generare scarsità di offerta di lavoro per molte professioni. C’è da dire, in premessa, che è discutibile la tesi per la quale in Italia le imprese non trovano lavoratori. In un’economia di mercato, infatti, dato il meccanismo della domanda e dell’offerta, se una risorsa è scarsa il suo prezzo aumenta. È dunque semmai corretto stabilire che il salario è troppo basso e che, in un’economia di mercato, per impiegarli in modo efficiente, il loro salario dovrebbe essere più alto di quello corrente. Occorre ricordare che il RdC ha raggiunto massimo 4 milioni di persone l’anno, a fronte di 5,6 milioni di poveri assoluti certificati dall’Istat.
La scarsità di offerta di lavoro, se e dove esiste, soprattutto quella giovanile, è il risultato del combinato di denatalità e di emigrazioni, soprattutto nel Mezzogiorno. Per alcune mansioni nel terziario, questa dinamica è particolarmente accentuata. Ad esempio, si registra il fatto che l’incidenza del turismo - soprattutto al Sud - è in costante crescita, a fronte della riduzione della platea di giovani (per effetto del calo delle nascite) disponibili sul mercato per quel settore (camerieri ecc.). Aumenta, in quel settore, la domanda di lavoro e si riduce l’offerta. Le imprese sono quindi poste nella condizione di dover aumentare i salari. Sebbene esse vi si oppongano, nelle condizioni date, è tuttavia auspicabile che ciò avvenga. In più, una ricerca recente, che propone un indicatore di «sovrappopolazione relativa», mostra che in Italia esiste uno strutturale eccesso di offerta di lavoro pari a circa il 17% (esistono, cioè, ben più lavoratori disposti a offrirsi rispetto ai posti disponibili).
È ben noto che i salari reali, in Italia, sono bassi e di gran lunga inferiori alla media europea. È poi sufficiente ricordare che l’Italia è l’unico Paese in Europa nel quale le retribuzioni reali si sono addirittura ridotte dagli anni Novanta per una percentuale quasi pari al 3%. È estremamente diffuso il lavoro povero: l’INPS certifica che il 23% dei lavoratori italiani riceve una paga più bassa dell’importo del reddito di cittadinanza. Una recente ricerca della Fondazione Di Vittorio, curata da Nicolò Giangrande, mette in evidenza che, esclusi agricoli e domestici, fra il 2019 e il 2020 si è verificata una contrazione del salario medio lordo del -5.9%, con una riduzione più intensa per gli operai, le donne e i giovani under 35, soprattutto nel Mezzogiorno. Il lavoro povero è diffuso soprattutto al Sud. È elevato, e superiore alla media europea, il numero di ore lavorate, peraltro in costante aumento.
Il dibattito sul RdC è stato, quindi, contrassegnato da una diffusa mancanza di conoscenza, sia di come funziona, sia dei risultati che ha prodotto. Si tratta di uno strumento molto simile a quello esistente da anni in molti Paesi europei. La sua riforma non ha l’effetto di accrescere l’occupazione, né ha avuto l’effetto di generare consistenti risparmi per il settore pubblico. La confusione sul RdC è confermata dalla recente proposta del Governo di sostituirlo con il MIA (Misura di Inclusione Attiva), che, nonostante le polemiche di Meloni, insiste nel confondere sussidio con politiche attive del lavoro. Il MIA riduce la spesa per il beneficio, con nessun intervento di modifica sostanziale per ciò che pre-esiste, se non la riduzione del sussidio per le madri e, su indicazione della Commissione Europa, la revisione del vincolo della residenza. Più in dettaglio, sulla base della bozza circolata qualche giorno fa, si prevede un assegno di 375 euro al mese percepibile per un anno e, per i non occupabili, di 500 euro che oggi è l’importo medio per nucleo (a fronte però di un limite individuale di 780 euro). L’assegno medio calerà e potrebbe arrivare anche una sforbiciata al contributo per l’affitto (oggi massimo 280 euro). Dopo il secondo ciclo da 18 mesi, il sussidio durerà un anno anche per loro. Il tetto di Isee passerà per tutti dagli attuali 9.360 euro a 7.200 euro e questo restringerà molto la platea dei beneficiari. Secondo le prime quantificazioni ufficiali, il risparmio di spesa sarà di tre miliardi, sugli otto totali del Rdc (pari a circa il costo lordo dei condoni in manovra). Si ipotizza che i beneficiari non supereranno il milione, contro gli attuali 2,7 milioni.
Il requisito minimo di residenza in Italia passerà da 10 a 5 anni, ma è imposto dall’Ue che ha aperto una procedura di infrazione e viene inserito solo per evitare la bocciatura della Presidenza della Repubblica. Viene poi consentito ai beneficiari di cumulare l’assegno con il reddito da lavoro fino a 3 mila euro senza subire decurtazioni. Sarà modificata la scala di equivalenza, cioè il meccanismo per cui il beneficio aumenta al crescere dei componenti familiari e che oggi penalizza i nuclei più numerosi. Finora ha previsto 100 euro per ogni minore, e già era considerato insufficiente per aiutare i nuclei numerosi: ora la cifra si ridurrà a 50. Una madre single con due bambini, per esempio, oggi beneficia di 700 euro, domani ne prenderà 600. L’impostazione insomma resta improntata sul colpire gli occupabili, secondo una filosofia che è stata definita «aporafobia»: ovvero basata sulla paura del povero per paura di diventare povero.