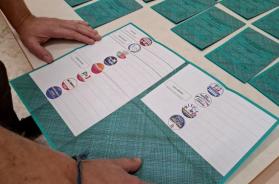Il Mezzogiorno avrebbe bisogno che i suoi giovani migliori non se ne vadano. È fatto assodato, quasi un’ovvietà.
La dispersione del capitale umano, infatti, è il primo fattore che rischia di rendere effimera la ripresa di questi anni. I giovani, però, non sono nani da conservare in giardino. Se non hanno motivazioni sufficienti prendono il largo, con il curriculum in valigia.
Tra il 2023 e il 2024 più di 241mila donne e uomini in carne ed ossa hanno lasciato il Sud. La maggior parte di loro non aveva compiuto quarant’anni. È come se, in soli due anni, una città di medie dimensioni si sia trasferita.
Sia scomparsa dalla carta geografica del Mezzogiorno, perché i suoi abitanti hanno deciso di vivere altrove. Non è perciò improprio affermare che il Sud stia smarrendo la sua linfa vitale. Quella che, invece, dovrebbe sorreggerne la crescita.
Secondo lo Svimez uno studente meridionale su due, al momento di scegliere il corso magistrale, volge lo sguardo verso un ateneo del Centro o del Nord.
In Basilicata sette laureati su dieci hanno scelto un percorso fuori regione, in Calabria il 37%, in Puglia il 34%.
La Campania negli ultimi cinque anni ha perso 30 mila giovani in possesso di una laurea triennale. E nello stesso lasso di tempo, il Sud nel suo insieme ha visto dileguarsi 132 mila laureati: 107 mila coinvolti nelle migrazioni interne; 25 mila recatisi direttamente oltre confine. Per molti, poi, la migrazione è a tappe.
Si completa il biennio (o si consegue il master) a Roma o Bologna; si assume il primo impiego a Milano e, quindi, si compie in «grande balzo». Una sorta di moderno «Grand Tour» della mobilità giovanile. Segno di una generazione inquieta, mai paga, alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide.
Contrapporre a tutto ciò i valori della tradizione non serve quasi a niente. Esortare i giovani del Sud a restare nella loro terra per custodirne le radici e difendere ciò che resta di paesi in alcuni casi in via di estinzione, non è sbagliato ma è inutile.
E anche gli incentivi, pur importanti, non si sono rivelati risolutivi. Le politiche pubbliche, piuttosto, dovrebbero immaginare azioni concrete per mettere in comunicazione le vie della mobilità giovanile: innanzitutto, quelle tra il Meridione e il Settentrione.
Ma per far questo, prima di ogni altra cosa, bisogna credere veramente (e saperlo comunicare) che per il Sud vi sia oggi «una grande occasione». Diversa, perché reale, dall’eterna illusione vissuta dal protagonista di Ferito a Morte di Raffaele La Capria. Se si parte da qui, sarà poi possibile distruggere pregiudizi che rischiano di trasformarsi in veri e propri paradossi.
Perché il Sud possiede ottime università. Ha generato dottorati in grado di attrarre ricercatori da tutto il mondo e non mancano i centri d’eccellenza che si occupano degli ambiti più sensibili della modernità. Per riattivare la circolazione delle competenze potrebbe perciò servire un «Erasmus domestico»: un patto in grado di replicare in chiave nazionale le caratteristiche del grande programma europeo. Esso metterebbe i giovani italiani nella condizione di scegliere sulla base di un’esperienza concreta, anziché di un pregiudizio.
E questo programma potrebbe essere integrato da un serio investimento sulla formazione nel bacino mediterraneo.
Oggi vi sono le condizioni per un’operazione come quella a suo tempo voluta da un visionario come Giorgio La Pira, allorché portò a Firenze l’Università Europea. La si deve tentare dialogando innanzitutto con i centri di formazione del Nord Africa, in alcuni casi di ottimo livello. Il «Piano Mattei» può agevolare il compito. Questa volta, senza commettere gli errori del passato. E, per questo, stabilendo rotte e collegamenti che siano a doppio senso: in entrata e in uscita.