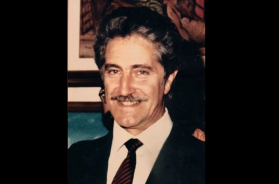Quella del voto di scambio non è una «scoperta», bensì l’ennesima acquisizione giudiziaria di un reato che sta alla base concreta della politica, scartate formule, retorica e ideologie. Hitler, da tiranno, nel Mein Kampf sbugiardava la democrazia parlamentare denunciandone la dinamica mercantilista. In tal modo, precorreva il crollo rovinoso della Repubblica di Weimar, dalle cui rovine sorse la mostruosità nazista.
Molto prima delle regalie, dalle cifre peraltro risicate, contro le quali sono in corso le odierne azioni penali, quando ancora non c’erano gli smartphone ma i cellulari di vecchia generazione consentivano di trasmettere immagini, fece epoca la consuetudine di fotografare le croci sui nominativi dei candidati prescelti, per dimostrare la fedeltà alla «committenza», collusa con la criminalità organizzata.
D’altronde, il voto di scambio era diffuso già nell’antica Roma. Si chiamava ambitus e rientrava nella Lex Baebia, cui aveva dato un impulso determinante Cicerone. Era un reato che non ammetteva deroghe. Come previsto oggi dal nuovo testo dell’articolo 416-ter, promulgato il 16 aprile 2014. Vi si stabilisce che chiunque accetti la promessa di procurare voti in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. In precedenza quest’ultima era compresa fra i 7 e i 12 anni.
Senza scendere nei dettagli delle normative, bastava osservare l’alacrità delle squadre addette alle affissioni dei manifesti con cui i candidati si proponevano agli elettori. Anche le potenzialità fotografiche di una volta permettevano ritocchi e abbellimenti oggi affidati al digitale. Colpiva la dedizione di giovani e adulti maturi dediti alla diffusione di volti e slogan dall’apparente valenza ecumenica. In realtà per tutti c’era l’aspettativa di un posto di lavoro, meglio ancora se fisso, come poi lo avrebbe satireggiato Checco Zalone con Quo vado. A meno che non si trattasse di militanza motivata da sincera adesione dottrinale, e in questo caso non veniva «servito» tanto il singolo quanto il partito.
Comunque, la deriva illecita dei meccanismi elettivi va di pari passo con lo sviluppo del Paese, e si allarga ben oltre la prebenda o la raccomandazione, mitico meme di quello che Edward C. Banfield definisce «familismo amorale» nel suo celebre saggio Le basi morali di una società arretrata.
Gli anni del boom economico sono falsati da un’oleografia di spiagge stracolme, bikini e juke box che ne irradiano la colonna sonora ormai abusata: Sapore di sale, Quando quando quando, Legata a un granello di sabbia, ecc. Mentre il ricordo della seconda guerra mondiale si affievoliva nella percezione di massa, la mafia accedeva perniciosamente all’alfabetizzazione economica e abbandonava la lupara e la coppola per indossare il colletto bianco. Gli appalti delle grandi opere di ricostruzione dell’Italia in macerie passavano per Roma. O anche più su.
Non a caso Leonardo Sciascia poteva scrivere in Il giorno della civetta che l’ombra della palma si allungava fino a nord. Un percorso criminale che persiste e viene enucleato nel film di Luca Miniero Un boss in salotto, del 2014, allorché un industriale della fascia prealpina dice chiaro e tondo alla moglie che lassù c’è bisogno del denaro camorrista per tirar mattina.
Ebbene, fin dall’Italia spensierata e solare dei «favolosi Anni ‘60», imperversava lo sfruttamento della democrazia parlamentare, grande conquista civile, a fini esclusivi di profitto. Ciriaco De Mita, in uno dei suoi ultimi interventi, avvertì sulla crisi del valore più nobile della politica: la rappresentatività. Sostituita, s’intende, dal self-service del potere che non mira alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla stabilità sociale, assegnando preminenza alla persona eletta quale attrattore caotico di interessi, per usare il linguaggio della fisica quantistica. Allora torna utile una frase di Mauro Corona: «Dovremmo scegliere i nostri governanti guardando le loro biblioteche».