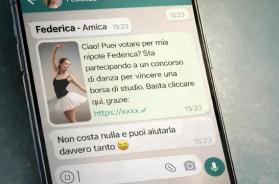Non c’è pace per i profughi armeni e su queste pagine non possiamo ignorare il dramma di un popolo verso cui ci sentiamo storicamente affratellati, ricordando i tempi in cui proprio gli armeni trovarono accoglienza a Bari, nel 1924, mentre sfuggivano al genocidio. Dalla Puglia, il cantore di quel dramma, il poeta Hrand Nazariantz, espresse il senso di smarrimento del suo popolo.
Oggi la situazione è diversa, ma altrettanto difficile. Non dobbiamo e non possiamo perdere l’occasione di far sentire la nostra voce accanto al dolore di quel popolo. Come noto, l’autoproclamata repubblica separatista ha annunciato, giovedì scorso, il suo scioglimento. La metà dei residenti dell'enclave sono fuggiti dopo l'offensiva dell'Azerbaigian. Il primo ministro armeno ha accusato l'Azerbaigian di «pulizia etnica». Il decreto del leader dell'enclave, Chakhramanian, ha annunciato l’annullamento «di tutte le istituzioni e organizzazioni governative (...) il 1° gennaio 2024» e di conseguenza «la Repubblica del Nagorno Karabakh, in quel preciso momento, cesserà di esistere».
Questa regione a maggioranza armena, che si separò dall’Azerbaijan dopo la disintegrazione dell’URSS, si è opposta a Baku per più di tre decenni, in particolare durante due guerre attive tra il 1988 e il 1994 e nell’autunno del 2020. Dando uno sguardo alla storia, si comprende, ancora una volta, come la disgregazione di quell’impero, nel Caucaso, ha prodotto scosse e mutamenti ancora insanabili, nonostante l’Occidente abbia cercato di applicare parametri di valutazione e di risoluzione decisamente inadatti per quella parte di mondo.
Facciamo un passo indietro, facendoci aiutare anche da ottimi volumi dell’editore Guerini e Associati. Iniziamo da una citazione di parecchio tempo fa. «Nel momento stesso in cui stiamo parlando, i massacri dell’Armenia ricominciano e le popolazioni armene, di nuovo, vengono massacrate», diceva Jean Jaurès nel suo storico discorso alla Camera dei Deputati francese. Era il 1897, ai prodromi del genocidio. La sua era una radicale condanna del silenzio dell'opinione pubblica occidentale. Le parole di Jaurès risuonano attualissime: anche oggi in tanti fanno finta di niente. Gli scontri sanguinosi del Nagorno-Karabakh prima e la violenza di oggi, non possono farci voltare la testa. L’Occidente non può star zitto dinanzi a quello che accade ai profughi armeni. In quell’area c’è già stato un lungo conflitto ignorato che, tra escalation e tentativi di pace, è andato avanti da trent'anni: dal 1988, quando a Sumgait scoppiò una violenta «caccia all'armeno», che sfociò nel vero e proprio massacro. Allora, le autorità sovietiche fecero di tutto per far passare sotto silenzio quella situazione. Le conseguenze, oggi, sono evidentissime.
Andiamo ancora un po’ indietro. Dopo una guerra sanguinosa, tra il 1991 e il 1993, le due parti hanno firmato un «cessate il fuoco». Qualcosa si è rotto, poi, nelle trattative e son tornate a farsi sentire prepotenti le polarizzazioni, quelle più influenti nel Caucaso. La Russia, come si sa, è tradizionale (e apparente) sostenitrice dell'Armenia, cui comunque assicura un notevole supporto militare, con fruttuosi tornaconti. Mosca ha, per esempio, una importante base militare nell’Armenia Nord-Occidentale. Entrambi i Paesi (Russia e Armenia) sono membri dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, un gruppo ufficiale politico che riunisce più nazioni del Caucaso. L'Azerbaigian, invece, non fa parte del gruppo. Che cosa ha sempre infuocato quell’area, se non le polarizzazioni pericolose, ben più interessate alle influenze territoriali che non ai diritti del popolo armeno?
L’altra insidia, inoltre, si nasconde nella Turchia di Erdogan, notoriamente antidemocratica e alleata dell'Azerbaigian, che è invece una repubblica (pseudo) presidenziale (anche se si registrano a Baku notevoli denunce mosse spesso da Amnesty International circa le violazioni governative della dignità della persona, segnalate perlopiù da giornalisti, che ricevono anche minacce di personaggi vicini al governo).
Le relazioni pericolose fra i leader di Ankara e di Baku derivano soprattutto dall'ostilità turca nei confronti dell'Armenia. Superfluo ribadire ciò si è scritto più volte: la Turchia non ha mai riconosciuto il genocidio armeno. Questo dovrebbe già dirla lunga sulla posizione tradizionalmente ostile alle popolazioni armene. La cartina geografica ci aiuta a capire meglio la situazione incandescente. L’Azerbaigian è uno snodo cardine tra l’Europa orientale e l’Asia occidentale; confina, come sappiamo, con Iran, Russia, Turchia e altre nazioni di grande importanza anche nell’ottica degli Stati Uniti. È inoltre un Paese ricco di petrolio e di metano. L’Armenia, pur guardando alla Russia con rispetto, vuole essere diversa dall’Azerbaijan e vuole stare il più possibile dentro le democrazie occidentali, pur mantenendo le sue tradizioni. L'Armenia è sì un Paese povero, ma vuole crescere scientificamente, vuole migliorare le competenze della sua classe dirigente, vuole adottare stili di vita più laici.
Queste ore, purtroppo, stanno segnando la caduta di un sogno, con lo spettro di un massacro che aleggia fra i profughi.