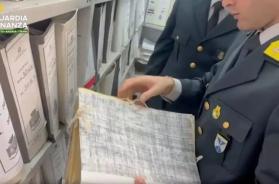Anni fa fui invitato a un convegno sulla sinestesia, organizzato dall’Arena di Verona. Tenni un recital con un programma solo in parte adeguato al tema; che è assai interessante e complesso. La sinestesia è la propensione di alcuni soggetti a sviluppare dei collegamenti automatici fra sensi differenti, per cui un suono evoca un determinato colore, o un certo profumo, o una forma geometrica specifica. In alcuni casi, anzi, la relazione è così forte e indissolubile che il suono e il colore viaggiano di pari passo.
Un dono e, assieme, una piccola condanna, come spesso i talenti e le forti predisposizioni.
Kandinskij, che era fortemente sinestetico, scrisse il lavoro teatrale (non l’unico della sua produzione) Il suono giallo, che un paio di compositori – tra cui Alfred Schnittke – hanno messo in musica.
A farne un’opera ci avevo, candidamente, tentato anch’io, quando, verso i quindici anni, ero caduto nella tentazione, poi naufragata, di diventare compositore. La cosa curiosa è che, in ben tre casi e senza averne alcuna consapevolezza, avevo intrapreso progetti già affrontati da qualcun altro, diciamo... appena più grande di me! Nel caso del Suono giallo, appunto, lo aveva già fatto Alfred Schnittke nel 1974 (circa sette anni prima che, ingenuamente, ci provassi io), e in ben due occasioni il mio «predecessore« era stato nientemeno che György Ligeti. Avevo letto, da adolescente, La Ballade de le Grand Macabre di Michel de Ghelderode. E mi aveva colpito la visionarietà pantagruelica, ipertrofica, del drammaturgo belga, che già allora mi ricordava lo stile di James Ensor, pittore belga le cui maschere hanno sempre suscitato in me grande impressione.
La dimensione del gotico, anche nelle sue trasposizioni ottocentesche (in questo caso novecentesche), l’ho scoperta grazie a un altro grande compositore, Penderecki, che – in un’intervista rilasciata in gioventù – dichiarava il suo amore per la pittura fiamminga e le cattedrali gotiche. Della pittura fiamminga citava soprattutto Hyeronimus Bosch, che resta uno dei pochi artisti, con Rothko, El Greco, Jaune Quick-to-See e Chuck Close, per vedere le cui opere farei un viaggio (infatti è accaduto e spero accadrà ancora, e nel caso di Jaune Quick-to-See il piacere è rafforzato dall’amicizia personale, piccola vanteria della quale chiedo venia al lettore, ma tant’è). Ligeti aveva scritto Le Gran Macabre, un’opera straordinaria (a proposito, mai rappresentata a Bari, chissà...) cominciandola nel 1974, come Schnittke.
L’altro caso è quello di un brano per soli metronomi, che avevo concepito su carta millimetrata. Bene, ancora Ligeti mi aveva battuto sul tempo, esattamente nel 1962, con il suo Poema Sinfonico per 100 metronomi. Nel mio caso, si trattava di far partire i metronomi a velocità diverse, e il pezzo sarebbe finito nel momento in cui i metronomi avessero ritrovato il sincrono. Ma non sapevo come fare, tecnicamente, e del resto anche i cambi delle luci e delle scene in Kandinskij rappresentavano per me una sfida improba, perché del compositore non avevo probabilmente il talento, e certamente mi mancava la tecnica. Alla scoperta che tutte le mie fatiche erano già state affrontate e brillantemente superate, decisi di ascoltarla soltanto, la musica nuova. E, solo dopo anni, cominciare anche a suonarla.
Ma l’esperienza della scrittura mi è comunque servita, e incoraggio i giovani musicisti a scrivere, comporre, pasticciare, sporcarsi le mani; non necessariamente per diventare compositori, ma per capire la musica, e dunque farla capire meglio a chi ci ascolterà.