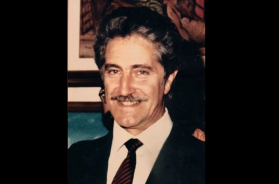L’8 e il 9 giugno, le urne attendono gli italiani, chiamati ad esprimersi sui cinque Referendum abrogativi, in questo 2025. Si tratta di un appuntamento elettorale importante, che tocca temi primari del diritto del lavoro e della cittadinanza. Non dobbiamo considerarlo una parentesi fastidiosa, ritroviamo il nostro buon senso civico, votare è un dovere e soprattutto un potere, in mano al cittadino. Il Presidente Mattarella ha giustamente ammonito a difendere uno dei diritti riconosciuti dalla Costituzione alle Italiane e agli Italiani: «Non possiamo arrenderci all’astensionismo», ha dichiarato e abituarci ad una «democrazia a bassa intensità».
Nel silenzio mediatico sulla consultazione referendaria, rotto soltanto da flebili istruzioni di rito - con l’eccezione nobile della «Gazzetta del Mezzogiorno», che ha informato diffusamente - è doveroso ribadire i contenuti dei cinque quesiti.
Il primo riguarda i licenziamenti illegittimi, in uno dei decreti del Jobs Act che regola i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. In caso di abrogazione, verrebbe ripristinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, in tutti i casi di licenziamento illegittimo. Il secondo vuole cancellare il tetto massimo all’indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di 15 dipendenti, lasciando al giudice la determinazione dell’importo. Il terzo quesito torna sul Jobs Act, affronta i contratti a termine e propone di abrogare alcune norme che regolano i contratti a tempo determinato e le condizioni per proroghe e rinnovi. Il quarto investe gli appalti e chiede di cassare la norma che esclude la responsabilità solidale di committenti, appaltatori e subappaltatori negli infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Il quinto quesito, in tema di cittadinanza italiana per gli stranieri, punta a ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia, indispensabile per avanzare la richiesta della cittadinanza italiana da parte di extracomunitari maggiorenni.
Gli ultimi due sollecitano qualche parola in più. Nel nostro Paese la mortalità nel mondo del lavoro è dolorosamente elevata, è bene insistere sulla sicurezza. Sono inaccettabili i numeri e il dramma delle morti bianche, sono troppi i lavoratori che muoiono per incidenti, soprattutto nei cantieri. E tanti, stranamente, sono al primo giorno di lavoro, ma non effettivamente, soltanto in base agli atti, perché prestatori d’opera non contrattualizzati - e quindi non coperti dalle assicurazioni obbligatorie - fino al verificarsi della disgrazia. Solo a quel punto i datori di lavoro provvedono a regolarizzare la posizione documentale e a farli risultare cinicamente assunti proprio quel giorno. Anche per questo è doveroso sottolineare il valore del referendum, che vuole tutelare la vita dei lavoratori ed interrompere una interminabile lunga lista di decessi.
Il quesito sulla cittadinanza agli extracomunitari ci porta in una sfera di civiltà giuridica moderna, di attualità civica. Non si tratta di un «regalo», ma di diritti oggettivamente riconoscibili. Pensiamo in particolare ai figli dei migranti: per essere nati in Italia, avere frequentato la scuola italiana, parlare la nostra lingua, sono ampiamente italiani a tutti gli effetti, manca soltanto il timbro.
Certo, sui referendum pende la condicio sine qua non del raggiungimento del quorum minimo, per considerare valido l'esito della consultazione: deve recarsi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Negli ultimi anni, uno scetticismo indolente e incosciente ha minato la partecipazione dell’elettorato attivo, ha sciupato la storia dell'istituto del referendum in Italia, che ha tratti nobili, in qualche caso esaltanti e fondativi, si pensi alla prima espressione democratica del voto dopo la seconda guerra mondiale e il fascismo. Il 2 giugno 1946, gli Italiani e per la prima volta le Italiane furono chiamati a scegliere la forma di Stato: Monarchia o Repubblica. Il quorum fu il più alto di sempre: 89,08%.
Si dovette poi attendere la disciplina del referendum abrogativo, di cui all’articolo 75 della Costituzione e si arrivò all'esaltante esperienza del 12 maggio 1974: divorzio Sì-No, quorum altissimo: 87,72%. Il 59,26% degli elettori si oppose all’abrogazione delle legge del 1970 sulle separazioni e sulla cancellazione del matrimonio.
L’11 giugno 1978, ordine pubblico (legge Reale) e finanziamento dei partiti: quorum 81,19%. Il 17 maggio 1981, aborto ed ergastolo: quorum oltre il 79%, 9 giugno 1985, scala mobile, quorum: 77,85%. L’8 novembre 1987, nucleare, quorum superiore al 65%. Il 18 giugno 1989: Parlamento europeo, il quorum schizza all’80,68%.
Primo stop il 3 e 4 giugno 1990: caccia e pesticidi, quorum non raggiunto, 43% e referendum non validi. Nel 1991 (riduzione delle preferenze, da tre a uno, nelle elezioni per la Camera e nel 1993, finanziamento ai partiti, droghe, abolizione dei ministeri) il quorum sale al 62,50%, nel 1995 al 76,98% per 12 quesiti, tra cui privatizzazione della Rai e pubblicità, quorum 57,22%, che precipita invece al 30,15%, per i sette del 1997 (privatizzazione, obiezione di coscienza, ancora caccia e carriere dei magistrati).
Partecipazione ai minimi storici, quorum massimo 25,65% per i referendum abrogativi del 1999, 2000, 2003, 2009. Successo nel 2011 sull’acqua pubblica, l’energia nucleare e il legittimo impedimento del premier a comparire in udienza penale: quorum oltre il 54%. Niente da fare per le trivelle, il 17 aprile 2016: quorum 31,19%.
Questa la storia dei referendum, quella dell’8 e 9 giugno è tutta da scrivere e dovrà essere una bella pagina di partecipazione, senso civico e cittadinanza.