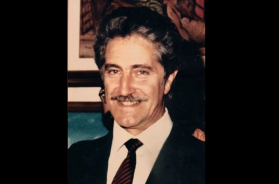L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi e si allontana di due passi, cammino dieci passi e si allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. E, allora, a cosa serve l’utopia? A questo serve, per continuare a camminare.
Le cose stanno proprio così? Come in questa «lezione di prospettiva» racconta lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano? E riusciamo a muovere passi ancora verso l’orizzonte? E permangono, sia pure in lontananza, linee d’orizzonte da agognare? Utopie da difendere? Riflettevamo su un fenomeno: l’attuale declino delle utopie, intese come modello ideale e agognato di assetto politico-sociale, religioso, e l’affacciarsi fitto fitto di distopie, premonizioni invece di una realtà immaginaria indesiderabile o spaventosa.
E lo facevamo proprio in questi giorni, a cavallo tra due eventi «realizzati», come la Festa delle Liberazione e il 1 maggio. Nelle celebrazioni, tra polemiche e revisionismi, di rituali ormai consolidati sembrano quasi dileguarsi le utopie per le quali abbiamo combattuto, una civiltà della democrazia e del lavoro, e prendono corpo le distopie deprecabili. In altre parole, il trionfo del tramonto sull’alba. Che con forza dobbiamo scacciare da noi, come pericolo grave e destabilizzante.
Rialziamo gli occhi e guardiamo un attimo gli orizzonti che intravediamo. Un primo orizzonte è quello geopolitico globale. Questo appare oscurato, da un lato, dallo stato di conflittualità permanente cui assistiamo, in presenza di contendenti che alzano giorno dopo giorno il tiro degli antagonismi, e, dall’altro, dall’infittirsi di calamità cataclismi e crisi ambientali. Su ogni scacchiere i conflitti sono dominanti rispetto alla cooperazione e alla marcia verso il benessere collettivo. E dalle stesse arti, il cinema, la letteratura, si profilano prodotti che prefigurano mondi distopici. Se poi guardiamo gli orizzonti nazionali, anche qui gli interessi particolari stanno prefigurando contese fratricide che non adombrano certo la forza propulsiva delle utopie.
Nel nostro Paese, un irrigidimento dei fronti a destra e a sinistra non trova soluzione se lo stesso dibattito delle idee, invece di arricchirsi e portare soluzioni, precipita in forme di censura e di epurazioni più o meno manifeste. Osservatori autorevoli come il filosofo Michael Walzer dichiarano che il caso Scurati, tanto per citare l’ultimo incidente, «è una evidente violazione della libertà di espressione, essenziale per la democrazia». Se rifuggiamo dai primi due cerchi, l’orizzonte mondiale e quello nazionale, che cosa ci rimane? Dove possiamo ambire a esercitare la partecipazione alla buona politica, a sperimentare le utopie della condivisione, a godere del benessere?
Proviamo a rifugiarci nella agorà locale, perché è il campo in cui ci muoviamo con più aderenza alla vita e agli spiriti e agli interessi di tutti i giorni, ma è qui che, forse proprio grazie alla forza emulativa che discende dal globalismo, la politica ci riserva la delusione più amara. All’ombra dei campanili, e in tutte le stagioni, si imbastiscono modelli di governo locale più distopico che utopico. Ma soprattutto scopriamo nella élite cui abbiamo affidato la rappresentanza una distorsione del significato più alto del mandato.
Sono mesi bui perché più profonda è la percezione di un alto tradimento che non ci meritiamo.