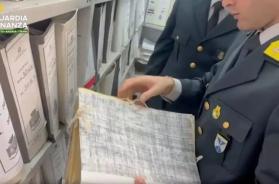MASSIMILIANO SCAGLIARINI
BARI - La tesi della Procura di Trani, che dovrà ora essere portata all’esame di un tribunale, è ben sintetizzata nel provvedimento con cui il gip Rossella Volpe ha autorizzato una serie di intercettazioni telefoniche. «I vertici di Ferrotramviaria erano ben consapevoli degli interventi mitigativi che sarebbero stati necessari per continuare a operare alla stregua dei requisiti di sicurezza imposti dalle norme nazionali in assenza di sistemi di sicurezza automatici e si ponevano il problema dei costi dell’adeguamento delle linee». I costi dell’adeguamento: secondo l’accusa, la tratta Andria-Corato su cui si verificò l’incidente del 12 luglio 2016 era priva di qualunque dispositivo elettronico perché non conveniva.
Per dimostrare questa tesi, che getta ombre molto pesanti, la Procura di Trani ha valorizzato dei tanti documenti scovati dalla Finanza tra i progetti depositati da Ferrotramviaria alla Regione. Massimo Nitti, attuale direttore generale e all’epoca direttore di esercizio, già nel 2005 (a valle di un accordo di programma firmato già dal 2002) spiegava al ministero delle Infrastrutture che l’installazione del sistema di blocco automatico, inizialmente prevista su tutta la Bari-Barletta, era stata limitata alla sola Ruvo-Corato cioè alla tratta a doppio binario. Perché? Per «evitare l’installazione di impianti destinati ad essere rimossi o pesantemente modificati in tempi non certo compatibili con il loro ammortamento». Detto in altri termini: siccome dopo Ruvo era comunque previsto il raddoppio dei binari, che avrebbe comunque comportato la realizzazione da zero dei sistemi tecnologici, Ferrotramviaria preferiva spendere una sola volta.
Una «logica aziendale, basata su ragioni eminentemente economiche» secondo il gip Volpe che per lo stesso motivo ritiene Ferrotramviaria responsabile di aver minimizzato il rischio: se già dal 2005 avesse introdotto misure di mitigazione, come i 20 «quasi incidenti» registrati dal 2003 al 2016 avrebbero suggerito di fare, si sarebbe prodotto «un sensibile calo della produttività e quindi della redditività dell’impresa», visto che significava (come sta accadendo oggi, da dopo l’incidente) rallentare i treni o introdurre il servizio a spola (un unico treno che fa avanti e indietro tra due punti). Ed è proprio per evitare questo, secondo l’impostazione accusatoria, che Ferrotramviaria avrebbe evitato di comunicare i 20 incidenti sfiorati alle autorità di controllo: una decisione di cui ora la Procura di Trani chiede conto sia agli amministratori che ai dirigenti di vertice.
Gli atti del «grande progetto» di ammodernamento della Bari-Barletta (finanziato dalla Ue con 83 milioni) sono stati passati al setaccio dai finanzieri, che in una lunga informativa sottolineano come «da nessuna parte» sia indicata «la specifica esigenza della messa in sicurezza della circolazione sulla tratta Corato-Andria», il cui raddoppio (già programmato prima) è stato affidato pochi mesi dopo l’incidente. E del resto, nell’accordo di programma del 2002 di cui abbiamo parlato prima, un accordo da 109 milioni, inizialmente erano previsti 7,2 milioni di euro per l’installazione del blocco automatico su tutta la linea fino a Barletta.
Ma il conte Enrico Maria Pasquini, all’epoca numero uno di Ferrotramviaria, propose di dimezzare l’investimento in sicurezza da 7,2 a 3,6 milioni, utilizzando la differenza per incrementare le somme destinate all’acquisto di quattro elettrotreni. Una proposta accolta dalla Regione e dal ministero delle Infrastrutture a luglio del 2004: nessuno dei vertici ebbe da ridire. Questo accordo, nato nel 2002, si è trascinato fino al 2011, con una serie di finanziamenti integrativi che hanno sì interessato la sicurezza, ma sempre fino a Ruvo: «Per la Corato-Andria (e Barletta) - scrive la Finanza nell’informativa - sono stati sostanzialmente azzerati i fondi destinati alla sicurezza della marcia del treno».
L’idea è insomma che la sicurezza non fosse tra le priorità della Ferrotramviaria, che nell’ultimo decennio ha avuto un enorme boom di traffico e lo ha sostenuto con l’acquisto di treni moderni e confortevoli (Alstom e Stadler), grazie ai quali ha potuto aumentare il numero di passeggeri e anche gli utili di bilancio. La sicurezza della tratta finale, quella da Ruvo a Barletta, semplicemente non era ritenuta urgente, nonostante i soldi fossero (almeno in teoria) disponibili già dal 2002. «Vi è quindi prova documentale - scrive la Finanza nelle sue conclusioni - che l’ipotesi di realizzare il “blocco automatico” sul binario unico ha avuto una genesi che, dal punto di vista temporale, precede di alcuni anni la proposta di finanziamento del raddoppio della linea interessata dal disastro ferroviario». Cioè, detto in altri termini: l’intera linea poteva essere dotata di blocco automatico fin dal 2004 o giù di lì. I soldi c’erano. Ma qualcuno decise che non valeva la pena spenderli in quel modo.