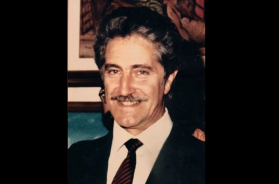FOGGIA - Una delle tante date da cerchiare in nero della storia di Foggia è il 5 agosto 2021: giusto due anni fa, al termine del lavoro della commissione d’accesso iniziato il 9 marzo precedente, fu firmato il decreto di scioglimento del Comune del capoluogo, già affidato ad un commissario dopo le dimissioni per motivi politici del 4 maggio del sindaco Franco Landella. Fu il secondo capoluogo di provincia in Italia sciolto per mafia, dopo Reggio Calabria nel lontano 2012.
In 145 pagine della relazione finale si analizzò la situazione della “Società” divisa in tre clan e con riferimento a guerre di mala e affari criminali; ci si soffermò “sull’attività amministrativa in materia di videosorveglianza che mostra una compiacenza dell’ente locale per imprese contigue a realtà mafiose accertate, in cui ritorna l’eco assordante della batteria Sinesi/Francavilla”; si sottolineò il fastidio di un consigliere comunale “con un ruolo dominante nel sistema tangentizio, che manifestò il forte disappunto per l’attività di prevenzione antimafia condotta dal prefetto, dicendo “queste interdittive ci hanno rotto un poco il c…”; si prese atto “della persistente resistenza degli organi di gestione per le verifiche antimafia”; si evidenziarono “i rapporti confidenziali inammissibili tra un amministratore locale e un soggetto che lo stesso amministratore conosce quale appartenente a una famiglia mafiosa”.
E ancora: si fece riferimento “alle logiche latatamente ricattatorie connesse all’esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo piegato agli interessi di un pubblico amministratore”; si osservò “l’ingiustificata commistione tra potere di indirizzo politico-amministrativo e potere gestionale, con lo sconfinamento dell’attività della giunta in settori riservati ai dirigenti comunali, che ritorna sistematicamente ogni volta che gli sconfinamenti procedimentali si risolvono in un temibile favore per imprese collegate alla criminalità mafiosa”; si elencò “il numero di amministratori coinvolti in indagini su corruzioni: la sistematicità dell’attività corruttiva fornisce un quadro di inquietante rilievo, che fa da cornice all’asservimento delle funzioni pubbliche a interessi privati perseguiti a qualsiasi costo dagli amministratori pubblici”; si criticò “la gestione personalistica del ruolo istituzionale ricoperto dal sindaco”.
Si espresse preoccupazione per “la circostanza che i titolari (o prossimi congiunti, affini e sodali) di società che erogano alcuni servizi sono collegati, direttamente o indirettamente, al mondo della criminalità organizzata foggiana, in un inquietante intreccio tra gestione del bene pubblico e il mondo del malaffare, per cui emerge la pervasività della criminalità mafiosa in settori strategici dell’economia legale”; si denunciò “il comportamento omissivo del Comune in un settore delicatissimo, le gestione degli alloggi popolari, che si è risolto in privilegi di indubbio spessore” a favore anche di parenti di presunti mafiosi.
Le conclusioni furono: “Foggia risente della presenza di sodalizi mafiosi la cui presenza si manifesta non solo attraverso fatti criminosi eclatanti ma anche e soprattutto attraverso una sistematica attività di contaminazione dell’economia legale, tipica della mafia degli affari. Queste attività criminali non potrebbero certamente essere gestite se non vi fosse da parte dell’amministrazione comunale, quanto meno una disattenzione nell’esercizio delle proprie attribuzioni. Si sono colti segnali di percezione nella comunità di una presenza opprimente dei clan locali in settori economici di primaria importanza e nei servizi erogati dall’ente comunale, talora adeguati agli interessi della criminalità organizzata. La superficialità del Comune nelle verifiche antimafia anche in presenza di contratti milionari, ha espresso una vulnerabilità del sistema pubblico rispetto agli interessi della criminalità mafiosa. Ai fini del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione pubblica è necessario porre in atto, soprattutto in territori così condizionati dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale per rimuovere anche visibilmente tutte quelle situazioni che in qualsiasi modo agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali”.
Ma “a Foggia ciò non è avvenuto e non avviene; non può vedersi imparzialità nella gestione del Comune, laddove le solite famiglie continuano a gestire l’economia in maniera indisturbata. Il Comune non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che derivano da un siffatto e difficile contesto. Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della criminalità organizzata. A fronte di tali interessi vi è stata se non connivenza sostanziale acquiescenza o comunque incapacità di intervento dell’amministrazione comunale. Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l’attuale amministrazione non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l’adozione di una incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Foggia capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata”.